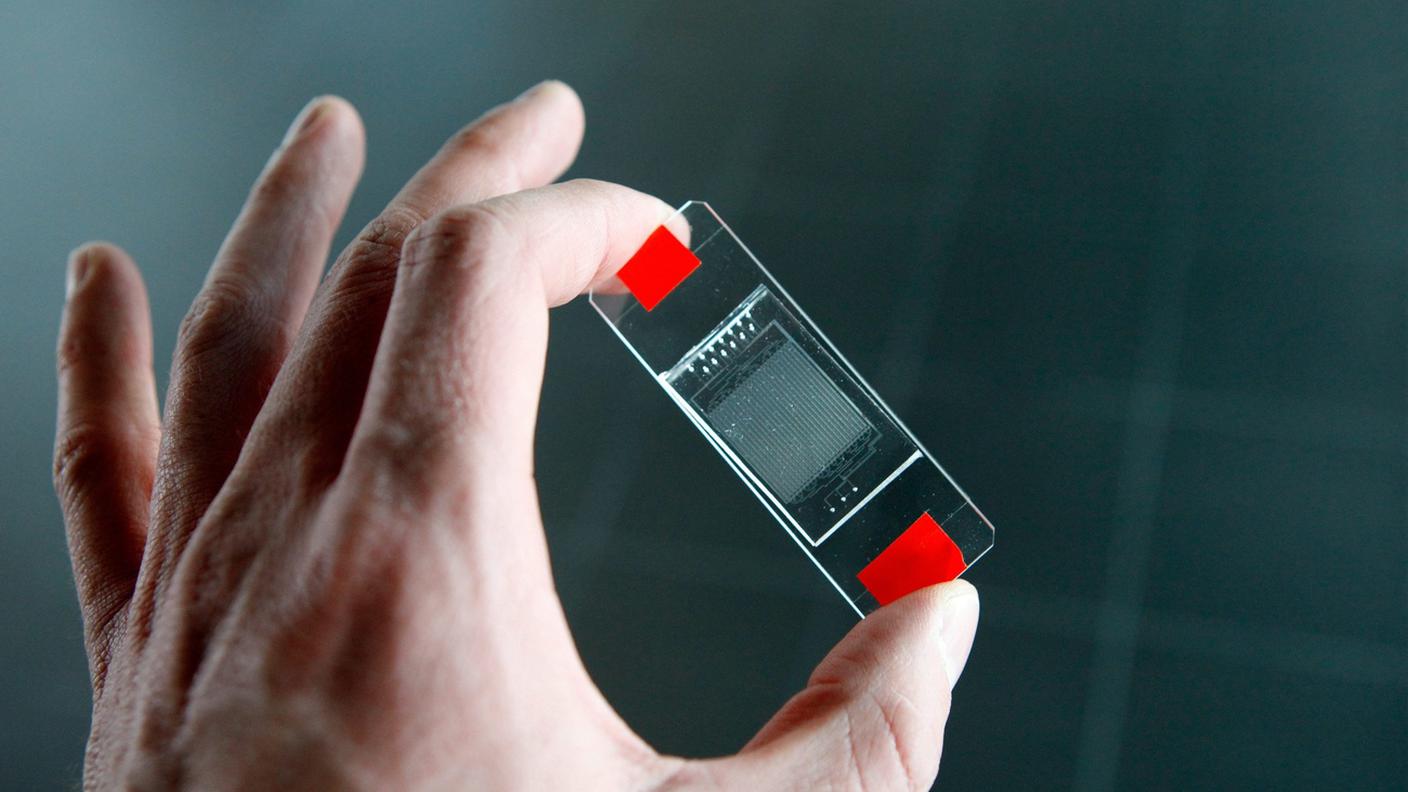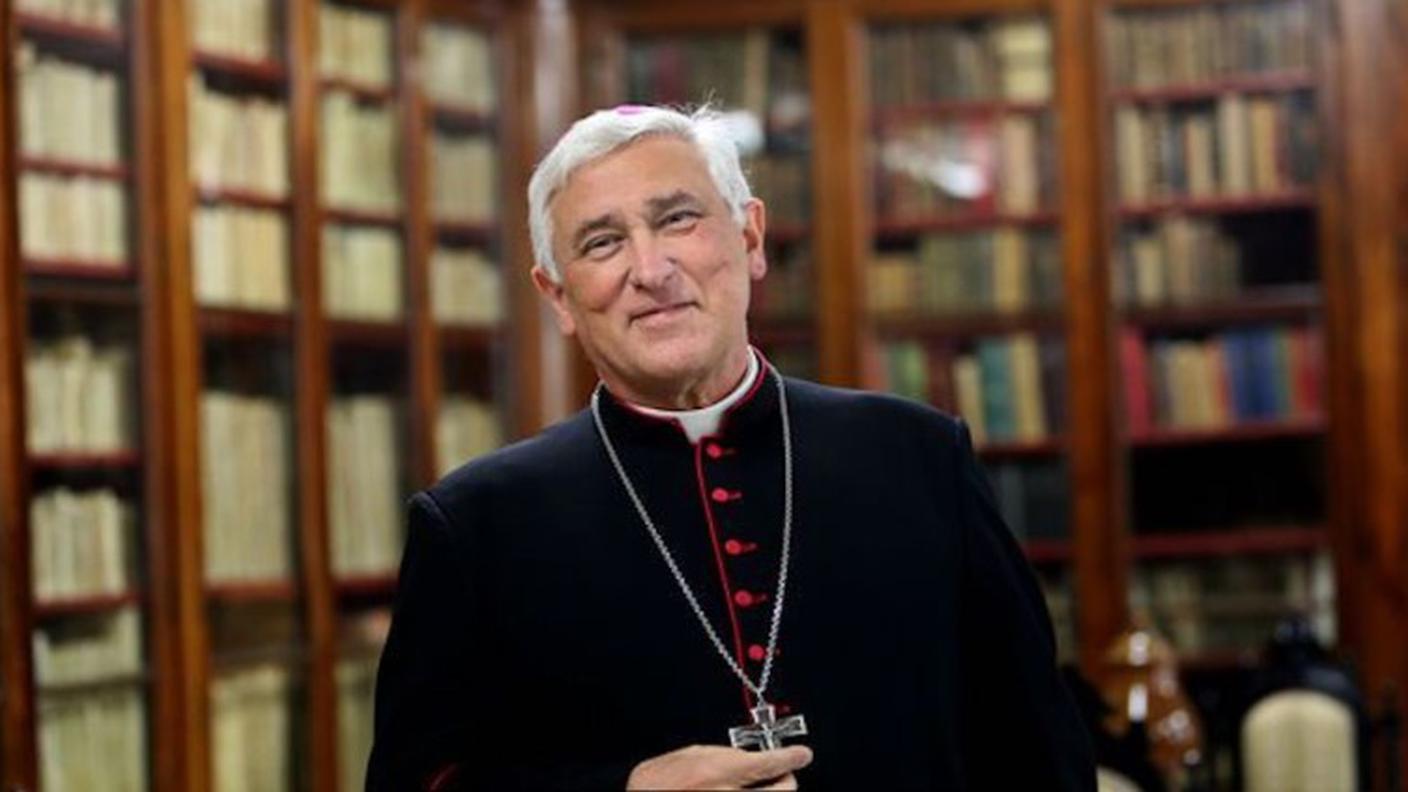Era il 13 novembre del 2015 a Parigi. L’incubo cominciò alle 21.16 e durò meno di tre ore. Un commando armato di terroristi colpì lo Stade de France e alcuni bistrot, per finire con la terribile carneficina del Bataclan, la sala dove 90 persone, per lo più giovani, furono uccise mentre assistevano a un concerto rock.
Giovedì la Francia si fermerà per ricordare il peggiore attentato di matrice islamista del Paese, che costò la vita a oltre 130 persone. Sono passati dieci anni dal momento che ha segnato un punto di svolta, nel mondo europeo, al terrorismo di matrice islamica. Com’è cambiata, se è cambiata, questa minaccia non solo in Francia, ma in tutta Europa, Svizzera compresa? Modem lo ha chiesto a Lorenzo Vidino, direttore del programma sull’estremismo presso la George Washington University, e Chiara Sulmoni, analista e presidente di Start Insight Lugano, think tank che si occupa di radicalizzazione.
Minaccia terroristica: diminuita, ma sempre presente
La minaccia terroristica è diminuita, ma non scomparsa, come sostiene Vidino. “Non abbiamo più visto fortunatamente attacchi della portata di quelli di Parigi di dieci anni fa”, spiega l’esperto, ricordando anche gli attacchi di Bruxelles e altri, di quell’ondata di jihadismo legata al fenomeno del califfato. In Europa l’ISIS-K, branchia dell’organizzazione in Afghanistan, ha pianificato degli altri attentati, poi sempre sventati dalle autorità, “ma la minore importanza e la minore capacità operativa dell’ISIS in Medio Oriente ha portato a una minore sofisticazione a livello operativo da parte di soggetti che operano nel nostro continente”, sottolinea Vidino.
Vi è però “la presenza di soggetti radicalizzati che adottano il credo jihadista dell’ISIS, di Al Qaeda, di altri gruppi o, più in generale, un credo jihadista”, rimarca l’esperto. Esiste un fenomeno di radicalizzazione dei giovani, soprattutto sui social (come TikTok), che “in piccoli gruppi o da soli decidono di passare dal jihadismo da tastiera a compiere o fare qualcosa”. Secondo dati Europol, negli ultimi anni si sono verificati in media cinque o sei di questi attentati all’anno. “Ce ne ricordiamo uno ad esempio in Svizzera, alla Manor a Lugano, compiuto da una donna, quindi non un profilo tipico del jihadista, che da sola si mise ad accoltellare persone”. Con la guerra a Gaza “abbiamo avuto un aumento di soggetti radicalizzati”, ma “il vantaggio, rispetto al passato, di questo tipo di attentati, è che tendono a essere di minore portata”, nonostante ciò per un piccolo gruppo o per un singolo individuo è più facile sfuggire alle maglie dell’antiterrorismo.
I profili: sempre più giovani, ma comunque adulti
“In Francia, dal mese di gennaio ad oggi, sono 17 i minorenni che sono stati messi sotto inchiesta per dei reati collegati al terrorismo”, dichiara Chiara Sulmoni, e “nell’ultimo rapporto sulla sicurezza in Svizzera del 2025, si legge che i casi di minori e giovani adulti che si radicalizzano online e che sviluppano delle intenzioni terroristiche continueranno ad aumentare”. Questa tendenza sembra essersi consolidata, tuttavia “l’età media di chi entra in azione o porta a termine un attentato in Europa è di circa 26, 27 anni”. Il fenomeno sembra quindi essere ancora “una prerogativa degli adulti”.
Ciò che è preoccupante tra i giovanissimi, come chiarito da Sulmoni, è la velocità con cui questi si radicalizzano in rete. I minorenni possono pensare che i loro attacchi vengano sventati o che non vadano a buon fine. “La loro giovane età non compromette però la pericolosità”, osserva l’analista, “perché possono anche ispirare, spingere altri, con maggiore motivazione o esperienza, a portare avanti degli attacchi”.
Malgrado si sia osservata una tendenza di radicalizzazione nei giovani, è molto difficile cercare di tracciare un profilo comune. Analizzando questi individui Vidino riscontra “undicenni, persone sui 60 anni”, e “da un punto di vista sociologico, persone con un alto livello di istruzione, soggetti ai margini della società e un’incidenza relativamente alta di disturbi mentali. Quindi ci sono vari casi”. Sarebbe comunque “riduttivo dire che i terroristi sono pazzi”, poiché “ci sono persone, invece, che non soffrono assolutamente di alcuna patologia”. Ad accomunare questi profili? Solo il web. “Faccio fatica a pensare a un caso, negli ultimi dieci anni, in cui non ci sia almeno un’impronta del web”, ricorda l’esperto.
Attuare un piano di prevenzione comune è molto difficile
Proprio la mancanza di un profilo comunque rende difficile creare politiche di prevenzione “L’aspetto di repressione è fondamentale”, rimarca Vidino, ma “va accompagnato dalla prevenzione”. “In Svizzera si è fatto molto a riguardo, come nella maggior parte dei Paesi europei”, però la mancanza di un profilo ben definito rende la prevenzione un atto individualizzato, che deve essere diretta al target specifico di cui si deve prevenire la radicazione.
Quali le strategie più efficaci?
“La Francia ha un sistema, che si chiama ‘Fiche S’, di soggetti che sono noti all’intelligence”, spiega Vidino, e “parliamo di circa un 25-30.000 individui”. Monitorare questo numero di soggetti è complesso, anche perché sussistono le “libertà civili, che non consentono allo Stato francese di monitorarli tutti solo perché, ad esempio, frequentano determinate chat”. Alcuni utenti online possono incappare in video jihadisti, pur non essendo interessati al tema, perciò occorre anche un grande lavoro di psicologia per capire quali fruitori potrebbero commettere degli attacchi. La psicologia, però, “non è una scienza perfetta”.
L’intelligence europea è migliorata molto negli ultimi anni, sia a livello di cooperazione sia sul piano legislativo. “Se penso alla Svizzera, ad esempio, molte delle leggi antiterrorismo sono state aggiornate, ampliate”, anche se questo ha fatto scaturire “polemiche sull’equilibrio tra sicurezza e libertà civili”. Rimane “impossibile raggiungere la sicurezza al 100%”, nei Paesi democratici in particolare.