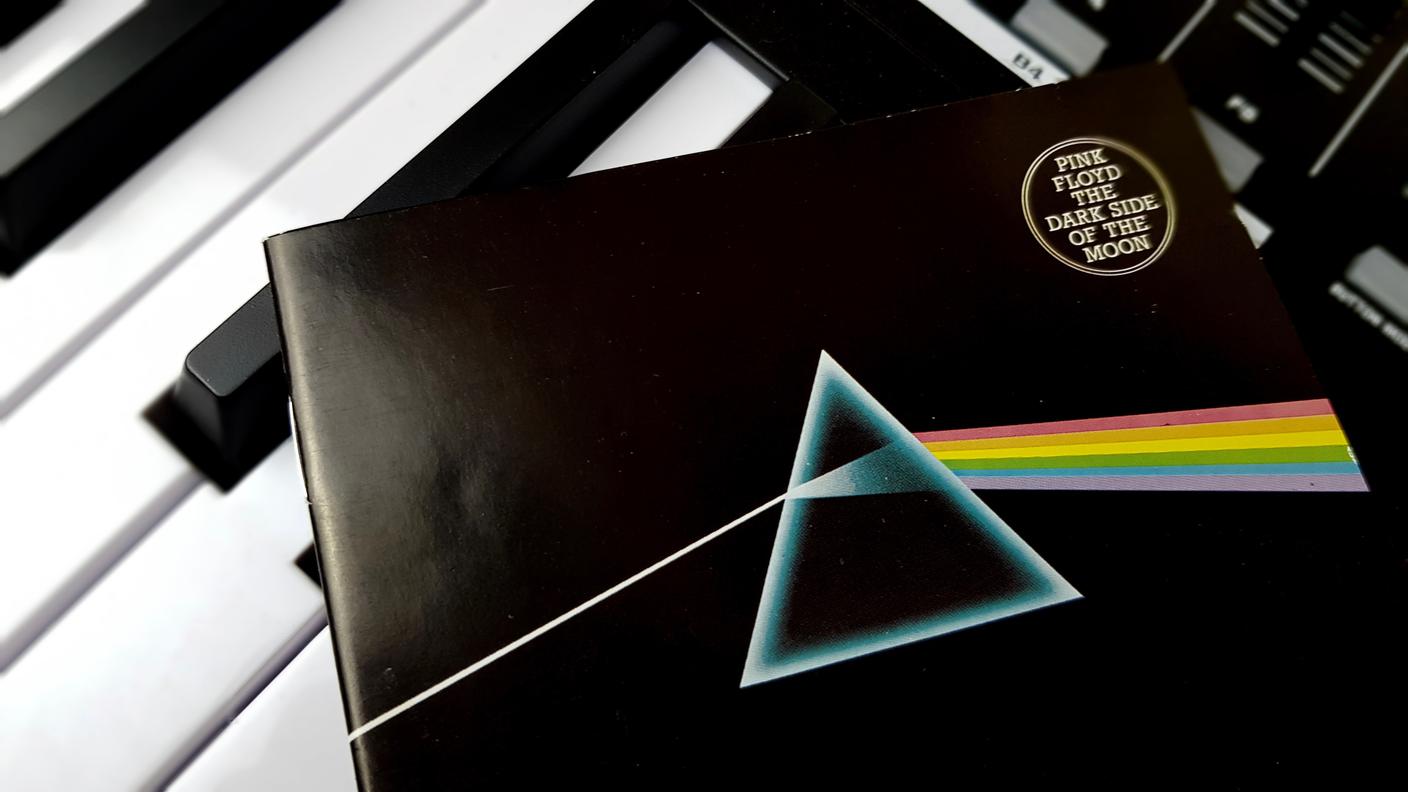Sarà anche succinta, ma basta a scatenare (di nuovo) i detrattori. Più di un esperto esprime le sue perplessità, diciamo così, sulla Breve storia eretica della Musica Classica di Alessandro Baricco. Lo scrittore e saggista italiano torna a cimentarsi con la musica: una scelta apprezzata dai lettori, meno dalla critica, che già in passato ha bocciato i suoi libri per via della loro superficialità e delle inesattezze in essi contenute.
Per cominciare, l’aggettivo che cattura l’attenzione è “eretico”: cosa rende tale lo scritto dell’autore torinese? Secondo Carla Moreni, firma del Sole 24 Ore, ben poco, perché si inserisce nella scia di altre storie della musica fin dalla scelta di procedere in ordine cronologico, partendo dagli antichi Greci per giungere a Stravinskij e Schönberg. Forse la cosa più eretica, osserva, è la mancata numerazione delle pagine, tra l’altro non proprio comodissima.
Proseguendo la sua analisi, la giornalista evidenzia l’inizio in stile biblico: «Baricco si sentiva Mosè quando ha iniziato: “In principio era il Mistero”. Accidenti, che attaccone!» Un’enfasi che sfuma nell’epilogo «assolutamente prosaico, perché finisce a Procida 2025. Si vede che ha finito di scriverlo lì» scherza. Non manca nemmeno di sottolineare le infatuazioni di Baricco, che «quando si innamora, si innamora a tutto tondo, senza riserve». Così «Bach è il dio della musica» mentre Beethoven «pensate che originale, è un artista moderno. Ma va’? Pensavamo fosse antiquariato».
Sulla questione sono intervenuti alcuni recensori di Rete Due. Per Franco Fabbri, queste pagine sono una proiezione del narcisismo del loro estensore, con le omissioni e gli errori tipici di un manualetto. Luisa Sclocchis si interroga sulla necessità di raccontare la storia della Classica in questa forma allucinata e ostica, che «piega la verità delle fonti a una non meglio precisata esigenza».
È sempre Carla Moreni a passare in rassegna gli errori commessi da Baricco nel suo testo (ne ha individuati in tutto quattro). La segnalazione più gustosa è forse quella su Bach, a suo dire descritto come un «parruccone che era lì chiuso con le sue musiche, e ad esempio non era interessato al fortepiano [precursore del moderno pianoforte] di Bartolomeo Cristofori. Non è vero!» E cita la documentazione a riguardo.
Cerca di smorzare i toni Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Che ammette di aver letto Breve storia eretica della Musica Classica due volte, «la prima con un certo sdegno, la seconda capendone anche i pregi». Il critico trova il volume non così ermetico ma «un po’ autoreferenziale, questo sì». Secondo lui i difetti risiedono nell’eccessiva semplificazione («Il problema è che riducendo, riducendo, riducendo si rischia di togliere parti essenziali») e in alcuni passaggi troppo sbrigativi («Liquida con una riga gente come Chopin, Schubert, Schumann, Čajkovskij, Liszt e Paganini»). Per Cattò un testo composto di tanti “flash” ha dei limiti perché come ogni storia, anche quella della musica «è fatta di una graduale transizione di grigi, senza stacchi improvvisi».
L’ultima battuta sulla questione se la riserva Carla Moreni, proponendo una modifica: «Il vero titolo è Breve storia baricca della Musica Classica. Uno ama Baricco, se la legge ed è felice».
Le eresie musicali di Alessandro Baricco
Voi che sapete... 15.10.2025, 16:00
Contenuto audio