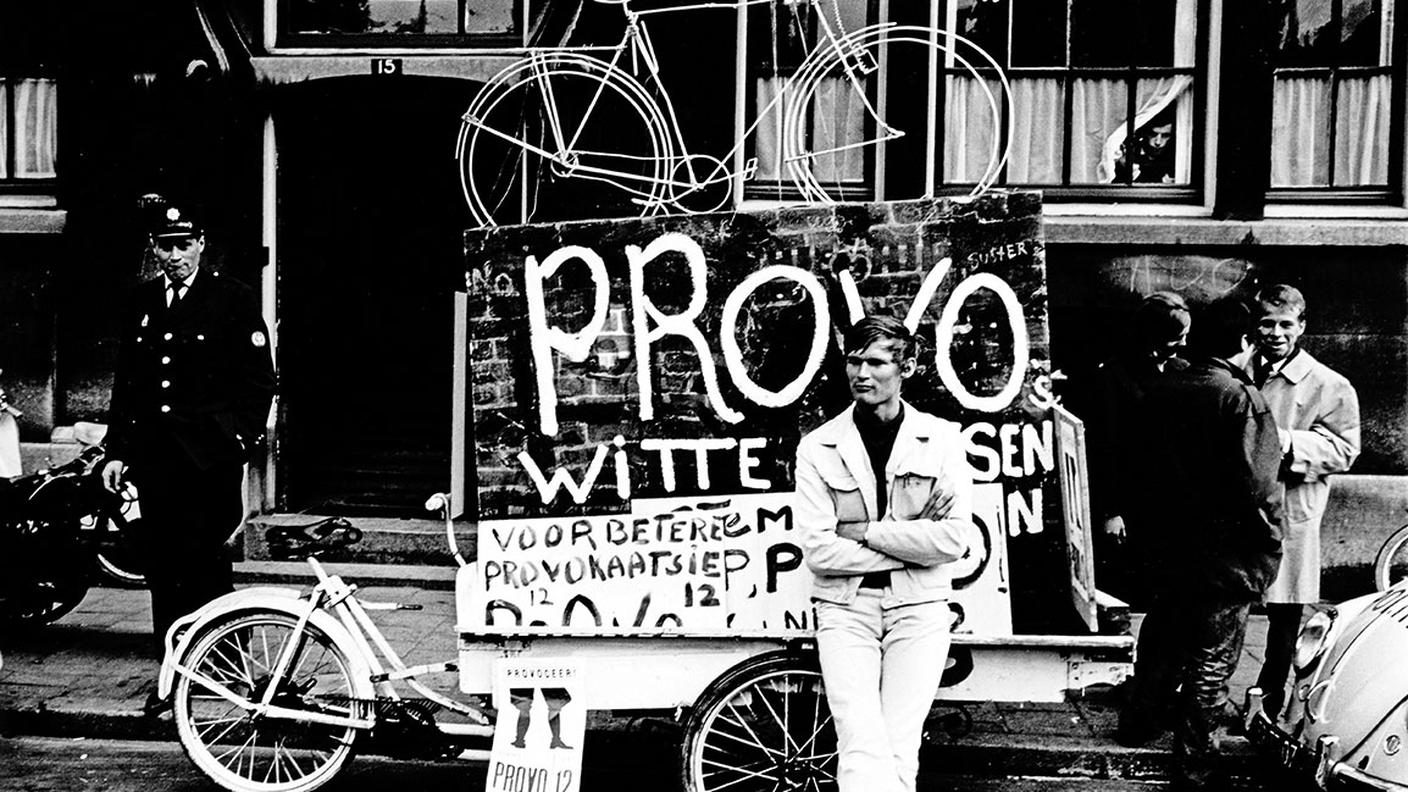I modi di dire sono parte della nostra società, perché sono come scrigni in cui si custodiscono tradizioni antiche e usanze passate. Alcune espressioni sono oggi così fossilizzate nel nostro linguaggio che vengono utilizzate in modo del tutto naturale, senza bisogno di essere ulteriormente spiegate o definite. Quante volte ci siamo trovati a usare un modo di dire senza conoscerne l’origine?
Tuttavia, se ci fermiamo a riflettere sulle parole, possiamo renderci conto che risalire alle radici di certe espressioni non è sempre un compito banale. Oggi vogliamo dare spazio ad alcuni modi di dire particolarmente diffusi in Ticino, espressioni idiomatiche che utilizziamo nel quotidiano e di cui abbiamo perso di vista l’etimologia. Ragionare sulla lingua è un modo per ritrovare in essa moltissimi altri elementi che definiscono la nostra società, la nostra storia e le nostre tradizioni culturali. I modi di dire in particolare sono strumenti interessanti attraverso i quali possiamo leggere in prospettiva diversa la collettività e i suoi usi. In alcuni casi, sono proprio uno specchio che riflette abitudini consolidate al punto da apparire totalmente normali, ma che meritano comunque una riflessione più profonda. Non è solo il lessico che si mescola, sono le stesse espressioni che, nel corso degli anni, si sono arricchite di sfumature diverse, a volte mischiate, a volte completamente nuove. Ecco alcune delle espressioni utilizzate in Ticino che portano con sé l’emblema del plurilinguismo svizzero, incorporando influenze locali e nazionali, in un curioso gioco di lingua, storia, tradizione e cultura.
Piantare in asso. Questa espressione, ampiamente usata anche in Italia, ha un’origine particolare: si fa riferimento al mito di Teseo e Arianna e sta a indicare una persona che è stata abbandonata all’improvviso. Teseo, dopo essere uscito dal labirinto grazie al filo lasciato da Arianna, abbandonò la principessa sull’isola di Nasso. La deformazione popolare nel tempo ha trasformato la frase “piantare, lasciare in Nasso” in ciò che oggi tutti conosciamo come “piantare in asso”.
Non avere peli sulla lingua. Tutti noi conosciamo qualcuno schietto e diretto, uno di quelli che ti dice le cose in faccia e che, insomma, “non ha proprio peli sulla lingua”. Questa strana espressione indica appunto qualcuno privo di filtri, con forse anche un po’ poco tatto, ma sicuramente sincero. L’immagine deriva presumibilmente dalla libertà di parlare senza intralci, senza, appunto, peli sulla lingua.
Confondere il burro con la ferrovia. Questo singolare modo di dire è comprensibile solo in Ticino ed è da intendere come “non confondere cose ben diverse tra loro’” o, più in generale, l’abbinare due elementi che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro. Il contesto da cui deriva è davvero unico, anche se ancora poco chiaro: pare che il tutto sia nato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando un ferroviere della Stazione internazionale di Chiasso, riferendosi a un vagone che trasportava burro in direzione dell’Italia, avrebbe detto che serviva al Duce per curarsi le emorroidi scatenando così le ire di un ufficiale fascista e provocando un serio incidente diplomatico.
Non sono cavoli tuoi - c’est pas tes oignons - das ist nicht dein Bier. In italiano il cavolo è il re dei modi di dire; le espressioni in cui compare questa verdura sono infinite, da “fare una cavolata”, cioè commettere un errore; qualcosa che non c’azzecca niente invece “c’entra come cavoli a merenda”; chi non capisce niente solitamente “non capisce un cavolo” o, ancora, i problemi diventano “cavoli amari” nel linguaggio comune. Insomma, davvero un ortaggio fortunato nella lingua italiana, ma non in tutte le lingue viene utilizzato il cavolo per costruire queste espressioni. Un francese arrabbiato invece di dire “non sono cavoli tuoi” urlerà: “non sono le tue cipolle!” (c’est pas tes oignons). Mentre per un tedesco, un modo alquanto diretto per invitare alla discrezione è dire: “non è la tua birra!” (das ist nicht dein Bier). Questo è un ottimo esempio che ci fa capire quanto i modi di dire siano legati alle tradizioni - in questo caso gastronomiche - di una determinata società in cui si sviluppano.
Ci son fuori sette soli. Quando il tempo è splendido, in Ticino è comune l’espressione “ci sono fuori sette soli”. Questo modo di dire viene dal dialetto: ghè da fö set so. L’interpretazione più comune è che il numero sette rappresenti un’esagerazione popolare, una sorta di iperbole per enfatizzare quanto il tempo sia bello, con un sole così splendente da sembrare che ci siano addirittura “sette soli”.
Prendere i topi / ciapà i rat. Sempre dal dialetto, ci arriva una simpatica locuzione: ciapà i rat, “prendere i ratti”, che sta a significare il non essersi svegliati in tempo, il fare tardi perché si ha dormito troppo. È un modo di dire colorito usato unicamente nella Svizzera italiana. La radice potrebbe essere la stessa del verbo ratare (in dialetto “mancare, sbagliare”), ma è da riscontrare anche la vicinanza al francese rater, che significa sempre “mancare” o “non riuscire’” In francese esiste l’espressione prendre un rat utilizzata quando un’arma si inceppa e quindi per estensione viene usato come sinonimo di sbagliare, mancare l’obiettivo.
Volere la botte piena e la moglie ubriaca / volere il cinquino e il panino. La prima espressione è ampiamente diffusa anche in Italia e significa voler tutto, pretendere tutto senza rinunciare a niente. È un modo di dire poco lusinghiero per le donne, ma ecco che nella Svizzera italiana compare un’alternativa: “non si può volere sia il cinquino (o soldino) che il panino”. Questa simpatica frase deriva dal tedesco Mann kann nicht den Fünfer und das Weggli haben ed è tipicamente elvetica. Il Weggli è un panino al latte che una volta costava cinque centesimi, per cui attraverso questa espressione si voleva far intendere che non si possono avere entrambe le cose allo stesso tempo.
Portare l’acqua al mare. È un’espressione che significa fare qualcosa di inutile, senza senso. Curiosamente però non in tutta la Svizzera questa frase è traducibile alla lettera; nella parte romanda, infatti, diranno porter de l’eau à la rivière, “portare l’acqua al fiume”, mentre gli svizzeri tedeschi scelgono un altro modo per indicare questo concetto: Holz in den Wald tragen cioè “portare il legno nel bosco”. Di nuovo, osserviamo come i modi di dire siano plasmati secondo gli usi popolari delle persone che li utilizzano.
Musica del futuro. Questo modo di dire, marcatamente ticinese, viene usato per parlare di qualcosa di utopico, da collocare in un futuro lontano e improbabile. L’origine è dovuta al contatto con le altre lingue nazionali. In tedesco si dice infatti Zukunftmusik e anche in francese esiste l’espressione musique d’avenir.
A Bizzeffe. L’origine questa volta è da ricercare nella lingua araba, in cui bizzaf significa “molto”. Si tratta quindi di un calco interessante, che ha dato vita a una locuzione usata davvero “a bizzeffe” nel linguaggio di tutti i giorni.
I modi di dire sono più che semplici manifestazioni linguistiche: sono il tessuto che collega passato e presente, tradizione e innovazione. In Svizzera, e particolarmente in Ticino, il plurilinguismo aggiunge una dimensione unica, trasformando le espressioni idiomatiche in veri e propri simboli di un’identità culturale che, pur condivisa, appare estremamente variegata. Se ascoltati con attenzione, i modi di dire raccontano storie di terre e persone, di tradizioni che resistono nel tempo, si evolvono e continuano a vivere nelle parole di tutti i giorni. Ogni espressione porta con sé una traccia del passato, un frammento di usi e abitudini che rimane vivo nella nostra lingua.
Tra la gente e i suoi modi di dire
Millevoci 20.02.2019, 11:05
Contenuto audio