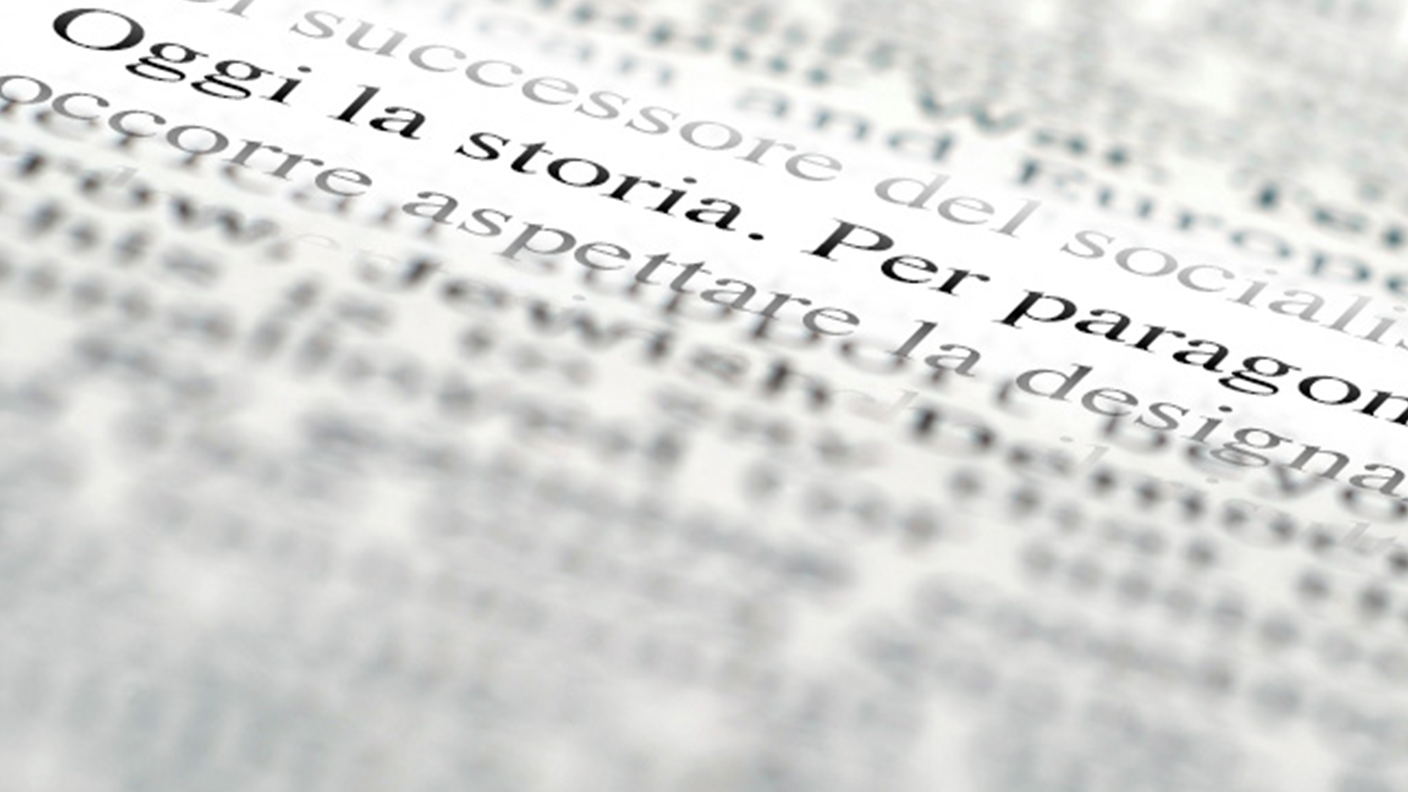
Oggi, la storia 17.10.14
Oggi, la storia 17.10.2014, 07:05
Contenuto audio
Nel nostro mondo si aggira un fantasma dalla fisionomia arcaica, l’ira, la collera improvvisa e feroce che annebbia la mente. Per gli antichi stoici era una “malattia dell’anima”, per i Padri cristiani uno dei peccati capitali. Cosa é per noi oggi? I nostri media usano frequentemente espressioni come: l’ira del Presidente X sul ministro Y…l’ira di Balottelli su Prandini e viceversa, l’ira della Merkel su Hollande (credibile) oppure l’ira di Hollande sulla Merkel (improbabile) e così via. Tutto questo è solo un modo di dire stereotipato - come i grotteschi “bagno di folla“, “evento epocale” o “a trecentossesanta gradi” - oppure indica un reale ritorno a un comportamento arcaico? Nel secondo caso la situazione sarebbe grave. Millenni fa l’ira era una delle passioni che distingueva l’eroe, qualcosa che suscitava insieme sgomento e ammirazione. In uomini come il Pelide Achille o come Giulio Cesare l’ira aveva qualcosa di grandioso e terribile come una catastrofe della natura e nasceva dalla percezione di un’ingiustizia che richiedeva riparazione ossia vendetta. Beninteso solo i grandi e i potenti se la potevano permettere: l’ira segnalava uno status etico/sociale privilegiato. Ma per i filosofi che studiavano l‘animo umano l’ira rimaneva il segno di una sopraffazione dell’istinto sulla ragione, un mancato controllo dell’umore collerico, una sconfitta etica. Quando il pensiero cristiano afferma l’eguaglianza degli uomini di fronte a Dio e i valori della humilitas e della mitezza di spirito prendono il posto della grandezza eroica e del furore guerriero, l’ira viene indicata come “l’arretramento della mente di fronte al corpo che scompostamente scaglia maledizioni come frecce e prega empiamente per la morte del fratello”. Così scrive per esempio Giovanni Crisostomo (IV secolo) che segnala ironicamente le manifestazioni “ridicole e asinine” dell’uomo iracondo. Un aspetto quest’ultimo da sottolineare: quando l’ira non appartiene più al mondo mitico dove svolgeva una funzione etica, e viene evocata nelle comuni faccende quotidiane appare comica oltre che pretenziosamente antidemocratica.
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri
