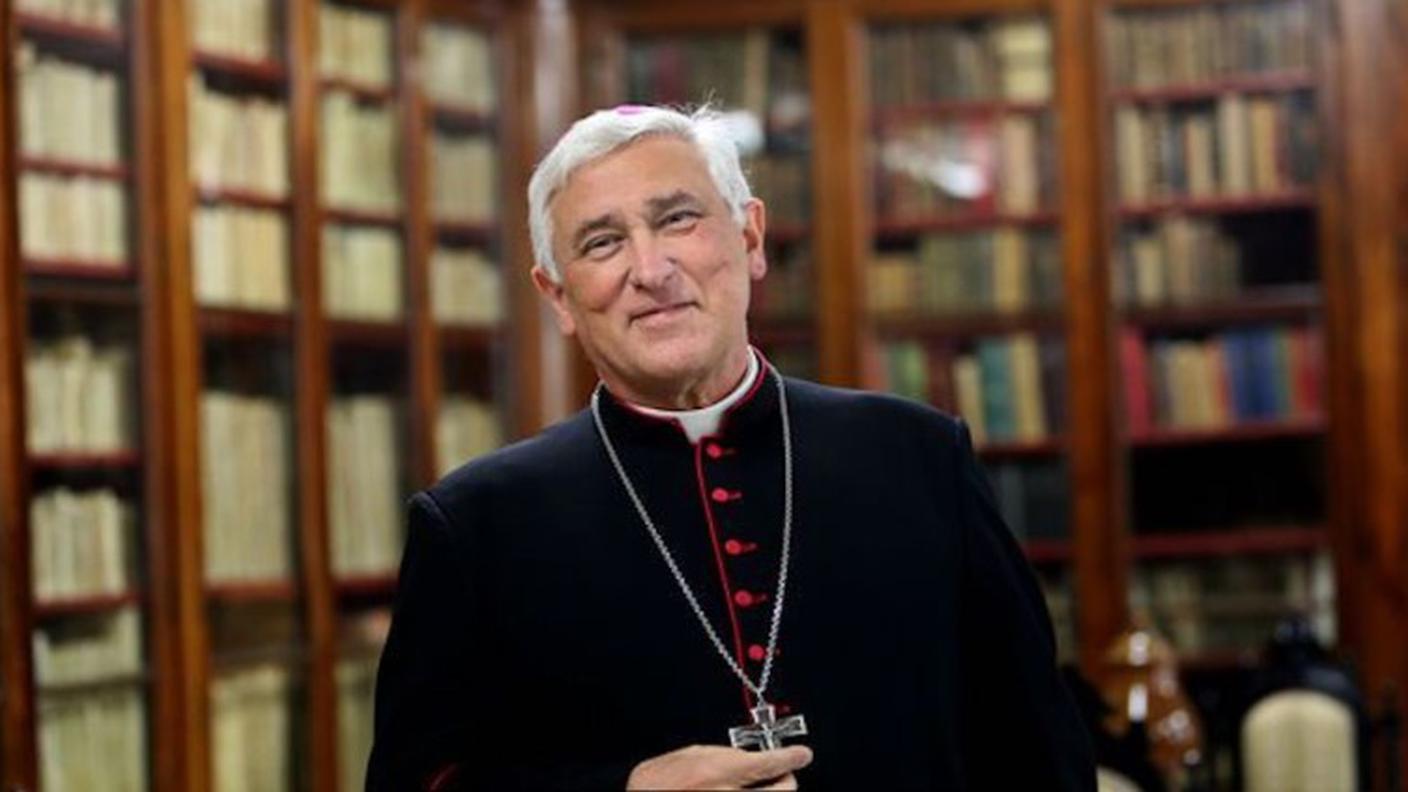Paolo Virno non è stato solo un filosofo. È stato un modo di pensare. Un modo di stare al mondo. Un modo di dire “noi” senza retorica, senza appartenenza, senza bandiera.
Nel suo pensiero, la rivoluzione non era un evento: era una grammatica. Un gesto quotidiano. Un’esitazione nel linguaggio. Un’interruzione del flusso. Virno non cercava la verità: cercava le condizioni di possibilità. Non costruiva sistemi: apriva varchi. Non offriva risposte: formulava domande che restano.
Christian Marazzi, su Effimera, lo ricorda così: «Scavava il linguaggio, lo interrogava, lo smontava. Non per gioco, ma per necessità». E in effetti Virno ha fatto della filosofia del linguaggio una forma di militanza. Ha mostrato come il parlare non sia solo dire, ma fare. Come il dire sia già un agire. Come il pensiero sia già un corpo.
La sua figura dinoccolata, il suo tono ironico, la sua lucidità tagliente: tutto in lui era pensiero incarnato. Non accademia, ma pratica. Non teoria, ma gesto. Non distanza, ma prossimità. Ha insegnato a Roma Tre, ma anche nei centri sociali, nelle riviste militanti, nei collettivi. Ha scritto Grammatica della moltitudine, ma anche Quando il verbo si fa carne, Il ricordo del presente, Esercizi di esodo. Libri che non si esauriscono.
Su Il Manifesto, Andrea Colombo lo definisce «comunista, non di sinistra». Perché la sinistra, quella istituzionale, aveva smesso di interrogarsi sul lavoro, sulla produzione, sulla vita. Virno no. Lui continuava a chiedersi cosa fosse il tempo, il rischio, la paura. E come si potesse vivere in un mondo dove il linguaggio è insieme risorsa e trappola.
Quando muore un filosofo
Kappa: la non notizia 10.11.2025, 18:00
Contenuto audio
Virno ha vissuto il trauma del carcere, l’assurdità dell’inchiesta 7 aprile, la fine delle utopie. Ma non ha mai ceduto al disincanto. Ha trasformato la delusione in analisi. Il riflusso in pensiero. Il fallimento in possibilità. Ha parlato di opportunismo, paura, cinismo — ma non per condannare. Per capire. Per restituire dignità all’ambivalenza.
Nel suo ultimo saluto, il Manifesto scrive: «Ha militato in Potere Operaio, fondato Metropoli, è stato arrestato, processato, assolto. Ha insegnato in Italia e all’estero. Ha lavorato per restituire senso alle parole». E oggi, quelle parole ci mancano. Ci mancheranno.
Il contributo teorico di Paolo Virno si colloca all’incrocio tra filosofia del linguaggio, teoria politica e antropologia della contemporaneità. La sua riflessione ha ridefinito le categorie del lavoro immateriale, della moltitudine e della performatività, offrendo strumenti concettuali per comprendere le trasformazioni del soggetto nell’era postfordista. Virno ha mostrato come le facoltà linguistiche e cognitive non siano solo tratti antropologici, ma anche dispositivi produttivi, inscritti nelle dinamiche del capitalismo cognitivo. In questo senso, il suo pensiero ha aperto nuove prospettive per una critica radicale dell’economia e della soggettività.
Per questo Virno non va solo commemorato, ma va riletto, rilanciato, riattraversato. Perché il suo pensiero non è un monumento: è una mappa. Una cartografia del possibile. Una grammatica dell’esodo. Un invito a pensare — e a pensarsi — fuori dai confini del già detto.