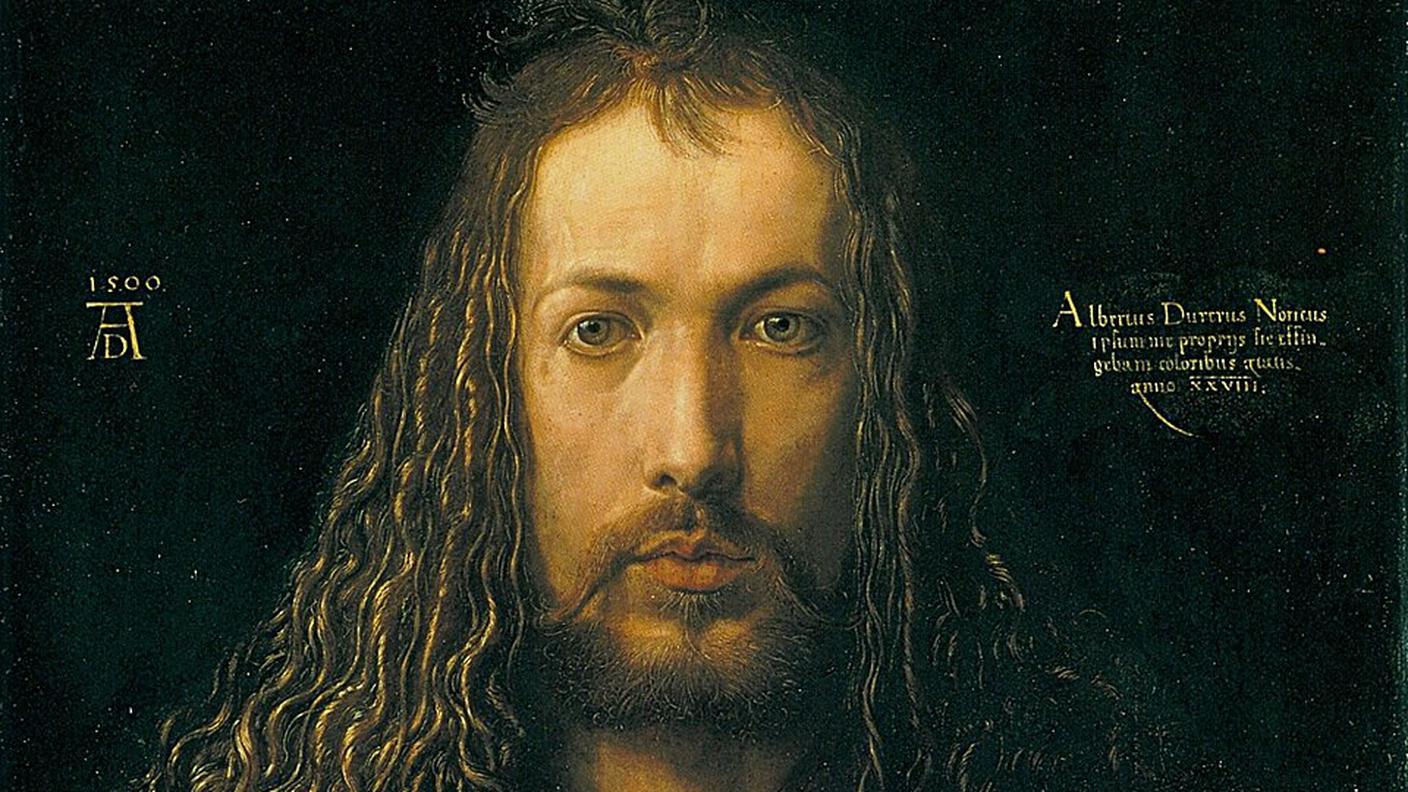Vi sono interpreti per i quali la voce è, se non tutto, tanto. Ma non è detto che, in questi casi, sia la gradevolezza ad averla vinta.
Ad esempio, l'uso che ne fece un Carmelo Bene concedeva – volutamente – ben poco al piacere, come questo è comunemente inteso: quei suoni che «si attardavano nel naso» sarebbero stati fuori luogo in chiunque altro. Che dire, poi, cambiando completamente ambito, della cantata fessa di un Bob Dylan, il cui inconfondibile timbro “miagolante” (che, negli anni, ha comunque subito più metamorfosi) sembrava sfidare l'orecchio con strafottenza. Per non parlare poi, rimanendo in contesto canoro, della caratteristica erre moscia di un Guccini, alla quale chi ascolta ha inevitabilmente bisogno di un tempo per abituarsi.
Il caso di Vladimir Vysotskij (Mosca, 1938-1980) – cantautore, poeta ed attore dalla vita intensa quanto travagliata – è, per certi versi, simile. Basta ascoltare pochi secondi della sua celebre La caccia ai lupi per rendersi conto di quanto quel grido rauco – in parte trattenuto, eppure esageratamente energico – che a tratti, come un'eruzione, pare voler sconquassare la compostezza dell'artista, renda uniche le sue leggendarie esibizioni
Tragicamente imparentata a quella tipica figura di artista russo che vede in Sergej Esenin un precursore e in Boris Ryžij la propria dannata progenie, benché sia oggi poco nota alle nostre latitudini la personalità di Vladimir Vysotskij è unanimemente considerata centrale nella storia della canzone europea del secondo Novecento. Figlio di un sottotenente ucraino e di una interprete dal tedesco, crebbe per alcuni anni a Eberswald, nella Germania Orientale – dove il padre era stato mobilitato come ufficiale delle truppe sovietiche di occupazione – per poi tornare a Mosca all'inizio degli anni Cinquanta. Qui, presto, assimilò la cultura popolare e il blat, il gergo della strada, malavitoso e marginale, che tanto peso ebbe nella sua opera.
Ma prima che la musica diventasse strumento centrale di espressione, fu il teatro a farsi sentire come vocazione profonda: negli ultimi anni di scuola dell'obbligo, Vysotskij prese a frequentare un circolo di animazione drammatica con l'idea di iscriversi, poi, ai corsi del Teatro Accademico d'Arte di Mosca. Nonostante l'opposizione della famiglia fu ammesso in istituto, dove si formò come interprete attraverso il celebre metodo Stanislavskij e dove, malgrado si facesse notare più come organizzatore di bagordi che non in veste di studente modello, alcuni insegnanti colsero il suo non comune talento poetico. Sempre in questo contesto si ebbero anche le prime, paradossali, considerazioni sulla sua voce: nel suo dossier di studente dell'epoca figura la seguente nota: «Orecchio: buono; senso del ritmo: buono; voce: non adatta al canto».
Eppure, come oggi sappiamo, fu proprio il canto a divenire per lui il veicolo privilegiato del proprio sentire, della propria visione del mondo. All'intensificarsi dell'attività teatrale infatti Vysotskij affiancò, man mano, l'apprendistato di cantante-paroliere mentre gli eccessi della sua vita privata iniziavano a destare preoccupazione (i suoi rapporti col Teatro Puškin, per il quale lavorò all'incirca due anni, rischiavano costantemente di guastarsi a causa del suo già pesante alcolismo).
Oggi le canzoni di Vladimir Vysotskij si possono catalogare attraverso specifici gruppi tematici che ne designano contenuto e fisionomia. Il primo importante ciclo è certo quello della mala, in cui appare – sempre per tornare a Esenin – l'immagine del chuligan, ossia del teppista. Ma diversamente dal poeta, nelle sue composizioni Vysotskij ci mostra dei veri e propri delinquenti, non la mera rivendicazione di un artista emarginato (un po' come De André, quando fa protagonista del proprio repertorio il mondo dei bassifondi). Avvalendosi dei personaggi che abitano l'universo della sua giovinezza, Vysotskij realizza quindi delle ballate che mettono in luce la società sovietica del suo tempo. Questa parte dell'opera all'epoca circolava clandestinamente, attraverso riproduzioni casalinghe in stile samizdat. Le canzoni guadagnarono presto popolarità, ma non il loro autore, il quale restò nell'ombra tanto da far credere tali creazioni come parte del repertorio popolare.
Secondo importante gruppo è quello che riunisce le canzoni a tema bellico, poiché, sebbene non conoscesse direttamente la guerra, Vysotskij era cresciuto in un ambiente familiare in cui essa era presente, sia attraverso il vissuto del padre che dello zio Alekséj, giornalista e militare pluridecorato. Così, mentre come attore intensificava la sua attività attraverso l'impegno cinematografico, alcune di queste – la cui caratterista è quella di contrapporre alla roboante retorica propagantistica i destini degli ultimi – vennero inserite nella colonna sonora di un film in cui interpretava un primo ruolo di rilievo: Sono nato nell'infanzia di Viktor Turov. Fra queste c'era Fosse comuni, brano che in seguito divenne uno dei pezzi di apertura dei suoi concerti.
Imparentato al ciclo della guerra è quello conosciuto come della montagna, nel quale l'avversità della natura fa sì che gli uomini si scoprano fratelli nel confronto con le dure prove del destino. Ma maggiormente importante è quello più generale dello sport, che a differenza dei precedenti non corrisponde a un'epoca precisa della vita del cantautore. Disseminate in più fasi del suo percorso creativo, queste canzoni sono infatti un evidente sberleffo ai piatti slogan del regime e all'icona del superuomo socialista. Si pensi al brano Ginnastica mattutina, del quale, in italiano, si ha tra l'altro la bella versione del comico Paolo Rossi, o al celebre Pugile sentimentale, di cui Vinicio Capossela ha tradotto il testo contenuto nell'album Liveinvolo (questi brani, unitamente ad altri di Vecchioni, Branduardi, Conte, etc., fanno parte del disco-omaggio Il volo di Volodja).
La burrascosa esistenza di Vysotskij, stroncata da un arresto cardiaco a soli quarantadue anni, fu caratterizzata, oltre che dai tormentati matrimoni, dai grandi ruoli sul palcoscenico (la sua interpretazione di Amleto al teatro Taganka divenne mitica), dagli eccessi alcolici – che, successivamente, si tradussero in una dipendenza dalla morfina – da una popolarità paradossale, sempre ostacolata dai diktat della cultura ufficiale.
Fu venerato da un ampio pubblico che lo stimava e si identificava nei frutti del suo talento, ma da parte del suo paese egli, in vita, venne sempre solamente tollerato e mai riconosciuto. Se si escludono alcuni articoli denigratori degli anni Sessanta, il suo nome non era citato dalla stampa, né come attore né come cantautore.
Come già accennato, noi italofoni, oggigiorno, forse conosciamo poco sia la sua storia che la sua grandezza. Un buon modo per porvi rimedio è cercare di procurarsi il bel libro Volodja di Sergio Secondiano Sacchi (Giunti, 2009). Contenente un ricco profilo biografico, una selezione di testi e interventi di altri autori, questo è certo una buona finestra alla quale affacciarsi per respirare la voce di un artista intenso quanto doloroso.