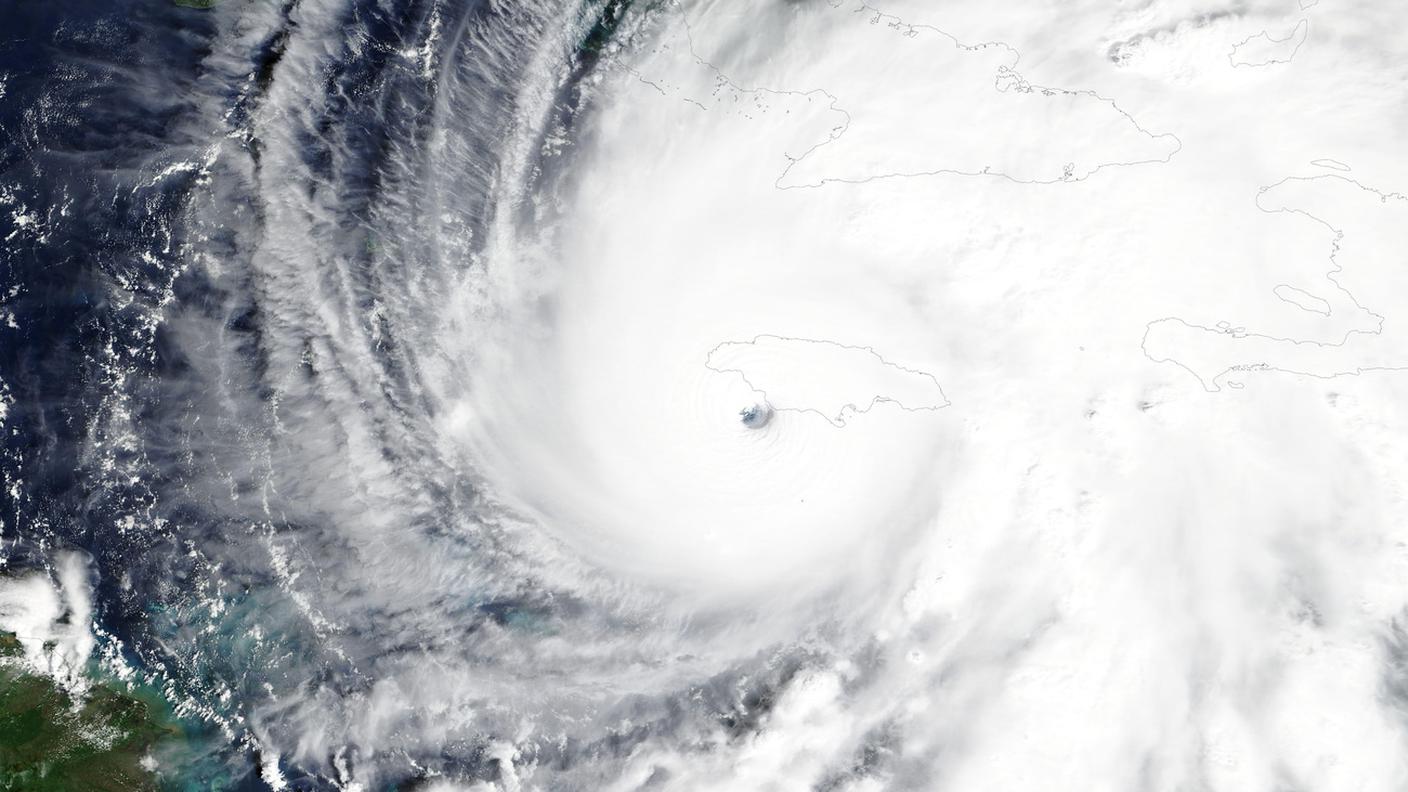L’evoluzione è un processo che non si arresta mai. Il suo punto di partenza è uno dei più grandi misteri della scienza e quello d’arrivo, in un certo senso, non esiste. Come tutte le altre, anche la specie umana sta cambiando nel corso del tempo, ma è impossibile prevedere la direzione che lo sviluppo del nostro corpo prenderà. Eppure, guardando agli animali attorno a noi e studiando i fossili, la scienza può cercare di immaginare quali parti del corpo potrebbero modificarsi nel corso dei prossimi migliaia o milioni di anni.
Il nuovo umano
Il giardino di Albert 01.11.2025, 17:00
L’evoluzione di una specie è un continuo e inarrestabile dialogo con l’ambiente circostante. Il nostro codice genetico cambia di generazione in generazione e, poco alla volta, dà origine a nuovi tratti o mette in risalto caratteristiche prima poco evidenti. Questo processo può avvenire in diversi modi. Ad esempio, un gruppo di uccelli può raggiungere una piccola isola e formare una nuova colonia, isolandosi dal resto della specie. I geni disponibili risultano quindi limitati e l’ambiente in cui devono adattarsi è diverso da quello d’origine, favorendo la nascita di una nuova specie, se le condizioni lo permettono.
In altri casi, nuovi geni possono comparire per mutazioni spontanee, e se i tratti che ne derivano offrono vantaggi nella sopravvivenza o nella competizione riproduttiva, l’individuo li trasmetterà alla generazione successiva. A loro volta, se i discendenti dovessero trovarsi in un ambiente molto diverso, magari a causa di migrazioni o cambiamenti climatici, potrebbero beneficiare di tratti finora rimasti nascosti e renderli poco alla volta più pronunciati.
L’evoluzionista riluttante
Laser 13.06.2025, 09:00
Contenuto audio
Un esempio è quello delle giraffe che, a partire da 14 milioni di anni fa, hanno sviluppato gradualmente colli sempre più lunghi. La biologa evolutiva dello sviluppo Tamara Franz-Odendaal racconta che «Le mie prime ricerche si concentravano su una giraffa dal collo corto di 5 milioni di anni fa, il giraffide più vicino alla giraffa dal collo lungo che tutti conosciamo. Si scoprì che queste giraffe dal collo corto mangiavano erba, non piante e che soffrivano di un difetto nutrizionale a causa delle inondazioni che si erano verificate nella zona. Quindi una delle ipotesi sul perché la giraffa abbia il collo lungo è che fosse in competizione con gli altri animali e che abbia optato per il consumo di foglie sugli alberi. Secondo questa ipotesi, il collo della giraffa è determinante per la selezione naturale: il maschio più forte è quello che viene scelto per l’accoppiamento».
I piedi e gli arti
Nel caso dell’uomo, è plausibile che, dopo diversi decenni di crescita, abbiamo raggiunto l’altezza massima che le nostre ossa e il nostro sistema circolatorio possono sostenere. Il biologo e statistico Alexandre Courtiol spiega che «È possibile che in futuro, a causa del riscaldamento globale, gli esseri umani diventino un po’ più simili a ragni, nel senso che avranno gambe e braccia più lunghe e un tronco più corto».
Contemporaneamente, i dati dimostrano che stiamo diventando più alti, ma non più forti, soprattutto se confrontati con gli altri primati. «Questo è dovuto in parte al fatto che usano le braccia per fare ogni genere di cose, mentre il nostro corredo genetico si è evoluto in modo da non aver bisogno di grandi muscoli nelle braccia», chiarisce Alexandre Courtiol.
Una sorte simile potrebbe capitare ai nostri piedi, come illustra il podiatra François Allart: «Se la cultura diventa quella dello stare seduti e del guardare tutto in video, il piede si indebolirà e diventerà sempre più piatto». Forse, il mignolo dei piedi potrebbe persino scomparire.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/salute/La-mano-meraviglia-della-nostra-evoluzione--2790328.html
Non è dissimile da quanto capitato ai cavalli che, all’origine della specie 50 milioni di anni fa, avevano cinque dita, mentre ora corrono sulla punta di una sola. La storia dei loro zoccoli rappresenta un eccellente esempio dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’evoluzione di una specie, come spiega la biologa e veterinaria Karen Overall: «I cavalli ancestrali erano bassi e poi il clima ha cominciato a cambiare. Quando i primi cavalli sono usciti dalla giungla e si sono spostati nella savana in espansione non potevano più nascondersi e dunque dovevano scappare in un altro modo. È qui che è avvenuto l’adattamento degli zoccoli, perché permettevano loro di correre molto velocemente per sfuggire ai predatori».
Negli esseri umani, questo sta avvenendo per il muscolo palmare lungo, posto nell’avambraccio. Attualmente, il 14% delle persone non lo possiede, a causa della variazione dello stile di vita. «I nostri antenati primati vivevano sugli alberi e il tendine aveva una funzione. Noi ora lo stiamo lentamente perdendo. Anche i gorilla, che hanno abbandonato gli alberi per vivere più a terra, stanno perdendo il muscolo palmare lungo. Per contro, gli oranghi ce l’hanno ancora perché ha tutt’ora una funzione. Gli oranghi infatti si appendono agli alberi e questo tendine aiuta la presa e il passaggio da un ramo all’altro. Noi impiegheremo centinaia di anni per perderlo, perché l’evoluzione è molto lenta in un organismo di grandi dimensioni che si riproduce a un ritmo molto basso».
Il codice genetico
L’evoluzione si basa su una grande varietà di geni e sulla loro continua ricombinazione. Se una comunità è piccola o isolata geneticamente, è possibile che ci sia una percentuale maggiore di figli con malattie ereditarie come la fibrosi cistica. Questo effetto è molto visibile tra i cani di razza, dove l’accoppiamento non avviene secondo criteri di selezione naturale, come spiega la biologa statunitense Karen Overall: «I pastori australiani purosangue hanno problemi genetici nelle loro linee genealogiche. Se si incrociano due cani con colorazione a macchie, le probabilità di ottenere un cane sordo o cieco sono molto alte. Quindi, per gli esseri umani, più si riproducono al di fuori della propria comunità, maggiore è la probabilità di diminuire la concentrazione di geni che causano malattie genetiche».
I geni della ricerca (4./5)
Alphaville: i dossier 09.10.2025, 11:30
Contenuto audio
Oggi le biotecnologie ci permettono di intervenire direttamente sul codice genetico. In particolare, la tecnologia CRISPR, che valse il premio Nobel per la chimica a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna nel 2020, consente di modificare i geni con grande precisione. Nonostante il suo potenziale per trattare malattie genetiche, la comunità scientifica è cauta. La difficoltà, spesso, è capire quali siano le conseguenze delle modifiche che vengono apportate, soprattutto sul lungo termine. Il bioeticista Françoise Baylis sottolinea che «Se si apportano modifiche alle cellule somatiche, le cellule del corpo, tali modifiche muoiono quando la persona muore. Se si apportano modifiche alle cellule germinali, le cellule riproduttive, tali modifiche saranno trasmesse di generazione in generazione. Il problema è che si possono commettere errori. E poi, una volta commesso un errore, si potrebbe non saperlo finché la persona non è cresciuta, si è riprodotta, ha avuto dei figli e quell’errore è stato trasmesso a un’altra generazione».