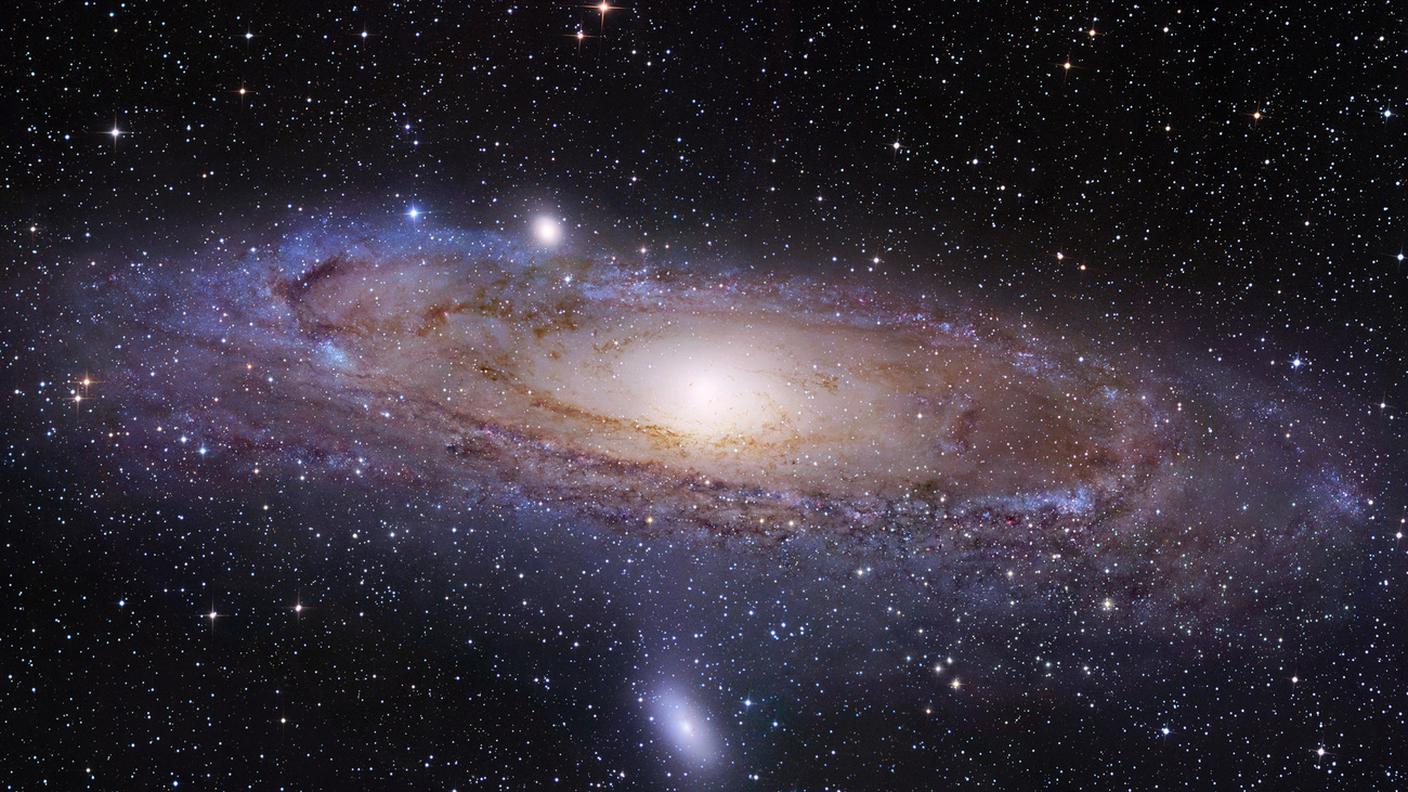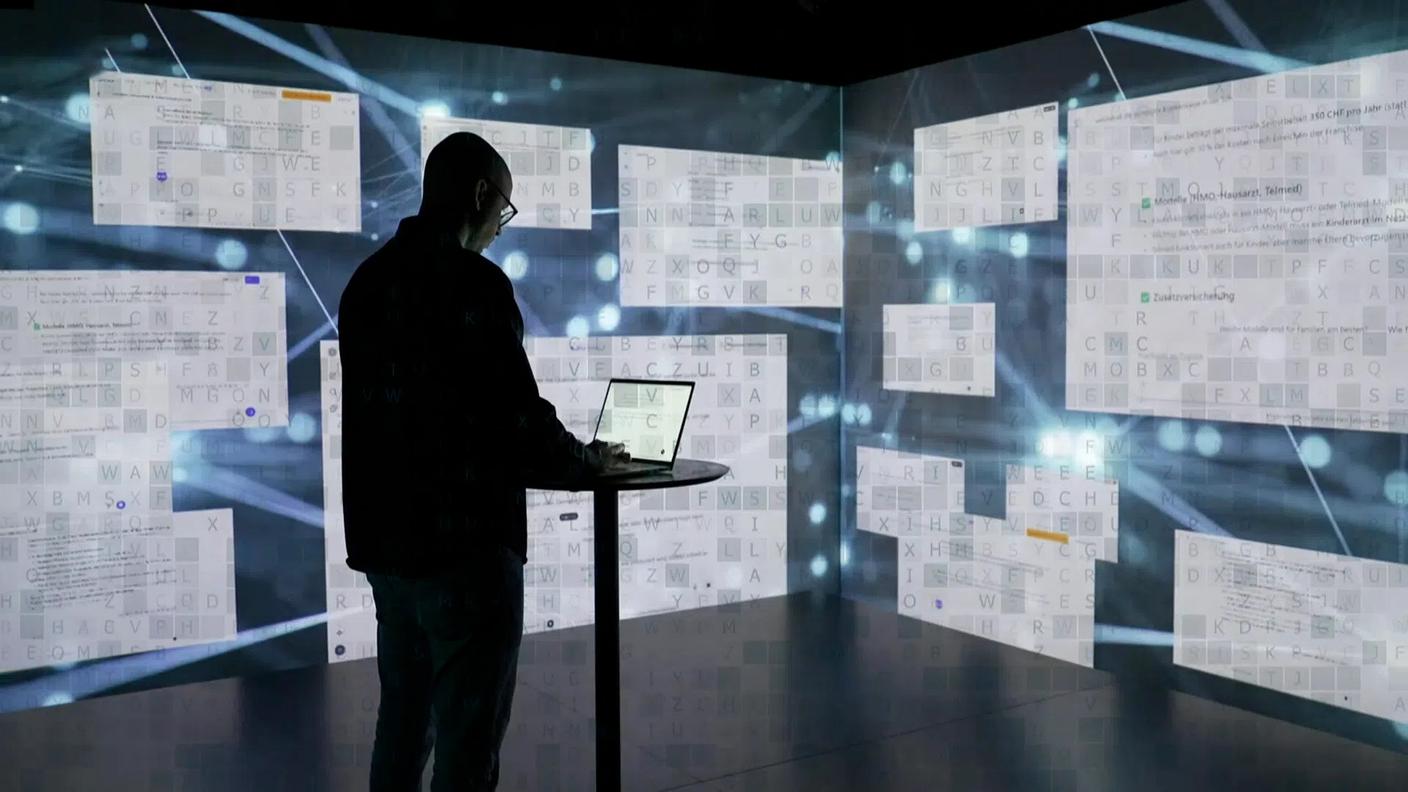Un documentario - frutto di quattro anni di ricerche e di spedizioni scientifiche dalla Siberia alla Papua Nuova Guinea, passando dal Tibet - racconta una delle indagini scientifiche più entusiasmanti dell’ultimo mezzo secolo, che ha permesso di scoprire nuovi elementi legati alla nostra storia e a quella dei nostri antenati.
Tutto ha inizio nell’estate del 2008, in una grotta siberiana, dove un team di ricercatori porta alla luce un reperto che provocherà una vera e propria rivoluzione nella comprensione della storia di Homo sapiens.
Rinvengono una minuscola falange, appartenuta ad una ragazzina di 7 anni, morta circa 40 mila anni fa. Sono inizialmente convinti che si tratti di un osso appartenente ad un Uomo di Neanderthal, ma le analisi successive riveleranno una vicenda destinata a rivoluzionare la storia dell’archeologia moderna.
Grazie all'aiuto del DNA è stato possibile ricostruire il volto della ragazza di sette anni, la cui falange è stata rinvenuta nella grotta di Denisova
Nel 2010 infatti, giunge la notizia come un fulmine a ciel sereno: l’analisi del DNA indica chiaramente che l’osso ritrovato nel 2008 appartiene verosimilmente a una nuova specie umana, poiché geneticamente si distingue da Homo sapiens e da Homo neanderthalensis. Si parla di Uomo di Denisova, dal nome della grotta in cui è stata rinvenuta la falange.
I risultati sono prima visti con sorpresa e interpretati con le pinze dal mondo scientifico, perché hanno un peso molto rilevante nella storia dell’umanità. Molti ricercatori hanno inizialmente interpretato la scoperta pensando che la falange appartenesse ad un tipo particolare di Neanderthal, ritenendo che le differenze genetiche riscontrate fossero comprese in quella che può essere definita una normale variabilità genetica all’interno della specie. Ma il sequenziamento dell’intero genoma contenuto in quell’osso ha mostrato che il reperto è geneticamente distinto da quanto conosciuto fino a quel momento. Si tratta quindi di una popolazione nuova, mai notata prima.
Risultati che nel 2022 sono valsi il premio Nobel in medicina a Svante Pääbo, pioniere degli studi in paleogenomica (disciplina scientifica che studia la ricostruzione dei genomi completi di organismi antichi per comprenderne l’evoluzione), che ha sequenziato il genoma dei denisoviani.
https://rsi.cue.rsi.ch/info/mondo/A-Svante-P%C3%A4%C3%A4bo-il-Nobel-per-la-medicina--1801132.html
Al momento non tutti considerano questa particolare popolazione una nuova specie e il dibattito sulla sua posizione tassonomica è ancora aperto. Quel che però è certo è che da quel 2010, decine di ricercatori di mezzo mondo hanno cercato di svelare il mistero di questo nostro avo finora sconosciuto.
Negli ultimi 15 anni sono stati ritrovati nuovi suoi fossili, in particolare in Tibet, e s’è scoperto che popoli lontani - come i Papuani della Nuova Guinea - possiedono fino al sei per cento di geni di questo estinto antenato. Un chiaro indizio che l’uomo di Denisova e l’Homo sapiens si sono accoppiati più volte nel corso della loro esistenza.
Già eravamo a conoscenza degli accoppiamenti tra noi Homo sapiens e H. neanderthalensis, testimoniati dalla presenza di una proporzione di 1-3 per cento di geni Neanderthal nel nostro attuale genoma. Ma quel che sorprende è che questa proporzione è più alta quando si considerano le ibridazioni con i denisoviani. Indizi ancora oggi presenti in Nuova Guinea.
Gli abitanti della Papua Nuova Guinea hanno il 4-6% dei loro geni in comune con i denisoviani
Un’indagine dai risvolti davvero sorprendenti che il Giardino di Albert ha voluto analizzare assieme alla paleoantropologa Silvana Condemi, grande esperta dell’universo denisoviano e co-autrice di “L’enigma Denisova”, un libro di recente pubblicazione che fa il punto sullo stato attuale delle conoscenze sui denisoviani.
Le indagini sono tuttora in corso e non smetteranno di stupirci svelando altri segreti. Sì, perché le tecniche di analisi del DNA antico stanno compiendo grandi passi avanti e oggi è possibile riesaminare anche i fossili raccolti tanto tempo fa. Insomma, la ricerca prosegue ed evolve. E con essa anche la comprensione della nostra storia, quella di Homo sapiens.