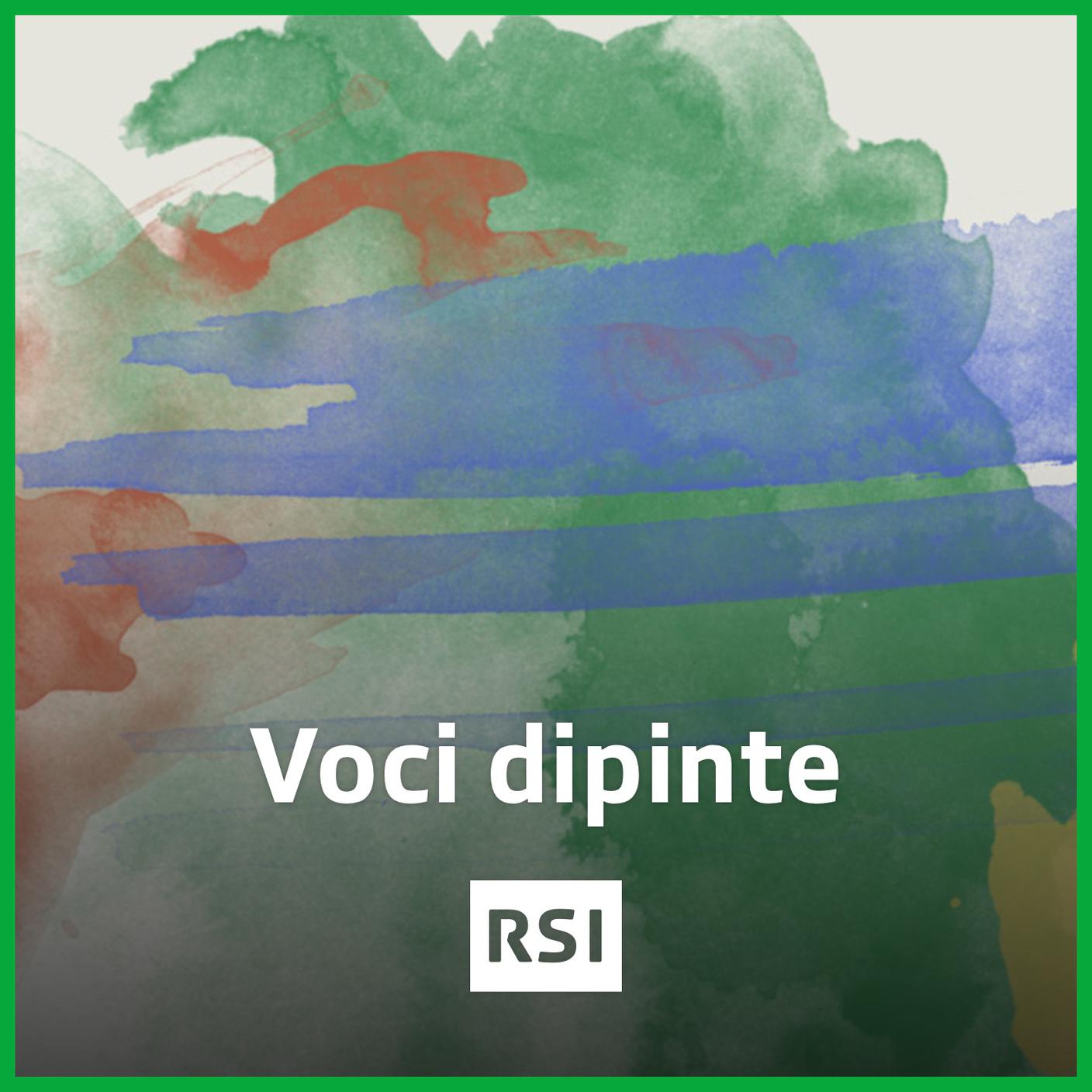L’architettura, arte funzionale per eccellenza, è sempre stata circondata da un’aura di solennità. Le città celebrano i propri architetti con monumenti, medaglie, monografie e mostre che ne esaltano il genio creativo. Ma cosa accade quando questo linguaggio celebrativo viene rovesciato, quando al posto dell’elogio subentra la caricatura, la vignetta, la parodia? La mostra “ARCHISATIRE. Una controstoria dell’architettura”, allestita al Teatro dell’Architettura di Mendrisio, prova a rispondere a questa domanda con un percorso sorprendente e dissacrante.
Il curatore Gabriele Neri, al microfono di Cristiana Coletti in Voci Dipinte, lo spiega con chiarezza: «Di solito siamo abituati a vedere gli architetti celebrati con medaglie commemorative, monografie, esposizioni, monumenti. La mostra ARCHISATIRE è un po’ il contrario di tutto ciò. Ci fa vedere delle case invivibili, degli architetti cialtroni, derisi, trattati male.» È un ribaltamento che non mira a demolire la disciplina, ma a mostrarne il lato umano, fallibile, contraddittorio. La satira diventa così uno specchio che riflette le tensioni tra visioni avanguardistiche e reazioni del pubblico, spesso ostili o ironiche.
Archisatire
Voci dipinte 16.11.2025, 10:35
Contenuto audio
Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche. In “L’architetto in caricatura” troviamo figure storiche come John Nash, immortalato da George Cruikshank in una scena feroce: impalato sulla cima di una guglia, simbolo di come le sue opere fossero discusse anche in ambito politico. Non meno pungenti le vignette dedicate ad Adolf Loos, il teorico del “ornamento è delitto”, ritratto mentre trova ispirazione in un tombino. Un colpo di ironia che smonta la seriosità del modernismo e ne rivela la fragilità.

George Cruikshank, Nashional Taste!!!, 7 April 1824
La sezione “Scandali urbani” porta lo sguardo sulle metropoli e sulle loro trasformazioni. Una vignetta del New Yorker mostra turisti su un autobus con tetto di vetro: la guida indica le Twin Towers “alla vostra sinistra”, ma i passeggeri guardano in alto, perché i grattacieli hanno cancellato le coordinate tradizionali dello spazio urbano. È un esempio di come la satira sappia cogliere, con un tratto leggero, la portata rivoluzionaria di certe architetture.
Non manca l’autocritica: molti architetti hanno avuto una doppia carriera, progettisti e al tempo stesso collaboratori di riviste satiriche. Giuseppe Terragni, Alvar Aalto, Piero Portaluppi hanno saputo ridere di sé e del proprio mestiere. Saul Steinberg, laureato in architettura a Milano e poi artista di fama mondiale al New Yorker, ha trasformato i cantieri in disegni di carta, dimostrando che la satira può essere un’estensione naturale della pratica progettuale.
Federico Babina, Archicards, 2016
Il percorso si arricchisce di materiali audiovisivi, come il film muto di Buster Keaton One Week, parodia della casa prefabbricata da montare come un kit industriale. E ancora, i disegni di Jean Marc Reiser dedicati alle opere di Mario Botta, pubblicati su Charlie Hebdo: un incontro inatteso tra architettura e satira che dimostra come il linguaggio della caricatura possa dialogare con la progettazione contemporanea.
Ma qual è il senso ultimo di questa controstoria? Neri lo definisce un «atto d’amore». La satira, scegliendo l’architettura come bersaglio privilegiato, ne riconosce l’importanza sociale e culturale. Ridere degli architetti significa ammettere che il loro lavoro incide profondamente sulla vita di tutti. È un modo per ricordare che dietro le facciate monumentali ci sono uomini e donne con idee, errori, contraddizioni. E che proprio queste fragilità rendono l’architettura più vicina a noi.
Saul Steinberg, Chest of Drawers Cityscape (1950), Morgan Library & Museum, NY
In un’epoca segnata da trasformazioni urbane incessanti, la mostra di Mendrisio invita a mantenere uno sguardo critico e consapevole. La satira non distrugge, ma illumina. Non riduce il valore dell’architettura, lo amplifica, mostrando come essa sia parte integrante della società e della cultura. “ARCHISATIRE” è dunque più di una mostra: è un invito a ridere, a riflettere, a riconoscere che l’arte di costruire il mondo che abitiamo non può sottrarsi al giudizio ironico di chi lo vive. E che proprio in questo sguardo esterno, talvolta spietato, si nasconde la possibilità di capire meglio chi siamo e come vogliamo abitare il futuro.