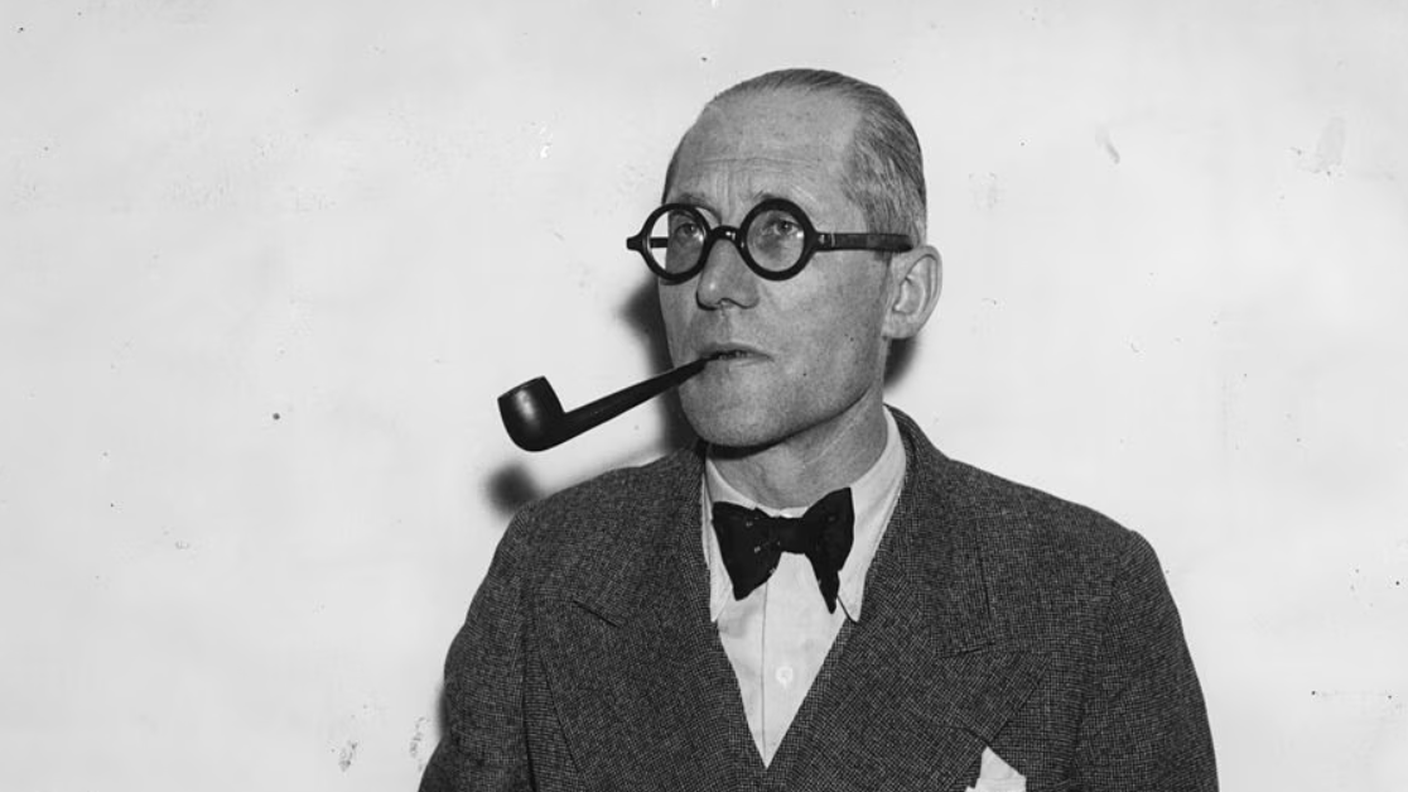A quanto ci è dato sapere, la storia della Socìetas inizia a metà degli anni ‘60, lungo un torrente dell’Emilia Romagna, dove due bambini si divertono con della creta di fiume. Fra loro la più grande è Claudia, che supera Romeo di un paio d’anni. Sono fratello e sorella ed amano entrambi creare i propri giochi da sé, prediligendo come attività il disegno. Quando, adolescenti, sceglieranno di dedicarsi al teatro, l’universo fiabesco di quegli istanti sarà uno dei punti cardinali del loro agire, unitamente all’arte visiva, della quale si nutrono molto più che di spettacoli o pièces.
La coppia cresce e mentre frequentano, rispettivamente, il liceo artistico e l’istituto agrario di Bologna (scuola che Romeo lascerà), coinvolgono alcuni amici nell’ideazione di una serie di rappresentazioni. Fra questi vi sono Paolo e Chiara Guidi, coi quali, presto, decidono di darsi il nome di Socìetas Raffaello Sanzio, «traendo il proprio emblema dal classico dei classici italiani, in contrasto con l’arte “della pura riproduzione”». Ma se nei loro giochi infantili – un po’ come le sorelle Brönte – i Castellucci praticavano «un teatro spontaneo», che vedeva come protagoniste figure della quotidianità campagnola, ora sono le grandi discussioni teoriche a imperversare: interrogandosi su come «riprodurre la realtà», i membri del gruppo giungono alla conclusione che «la forma prevale sul contenuto».
A distanza di anni da quei primi passi, in un’intervista Romeo dichiarerà che «il teatro più forte e interessante» è proprio quello «privo di contenuti» non perché superficiale o facile, ma in virtù del suo essere «una forma in sé, (…) una energia in sé» (fenomeni quali Vaslav Nijinsky, il butoh e Carmelo Bene confermano questo assioma).
L’universo del fanciullo, quindi, sarà una costante nel cammino della Raffaello Sanzio, che dalla fine degli anni ‘70 inizia mostrare il proprio lavoro in pubblico: tra il 1980 e l’85 vengono realizzati sei allestimenti, ma solo a partire da Santa Sofia. Teatro Khmer (1986) il gruppo riconosce una propria maturità. Su richiesta della compagnia, nei primi anni ‘90 l’amministrazione del comune di Cesena affida loro una vecchia scuola per tornitori in ferro in cui realizzare un grande progetto su Le favole di Esopo (1992). Da allora il gruppo ha sede lì, in quello che poi diventerà il Teatro Comandini e dove, in quell’occasione, furono ospitate duecento bestie in carne e ossa
Il cammino della Socìetas – dal 2006 il nome della compagnia viene abbreviato – è vasto, complesso e articolato ed è impossibile renderne conto nello spazio di poche pagine o solo attraverso alcune opere (per una migliore conoscenza si rimanda, ad esempio, al volume di Jean-Louis Perrier La disciplina dell’errore, nel quale sono riunite le interviste dell’autore a Romeo Castellucci). Semplificando, si potrebbe dire che in una prima epoca le creazioni si sono sviluppate collettivamente, attraverso una sorta di triangolazione in cui Claudia Castellucci e Chiara Guidi curano partiture di movimento e vocalità mentre Romeo si occupa di regia, creazione di luci e scene (Paolo Guidi si staccherà dal gruppo nel 1996). Sono anni che portano ad Amleto. La veemente esteriorità della morte di un mollusco (1992), Masoch. I trionfi del teatro come potenza passiva, colpa e sconfitta (1993), Orestea (una commedia organica?) (1995) e Giulio Cesare (1997).
In questi atti artistici ricorrono elementi fondanti, come la centralità dell’immagine e del suono in opposizione al concetto di trasposizione; l’utilizzo di «corpi segnati» (anoressici, obesi, mutilati) quali precisi segni drammaturgici al servizio di un disegno che ha come obiettivo la messa a fuoco del tragico; la presenza di macchine, animali e bambini la cui incandescente-innocente evidenza scenica manda in cortocircuito l’idea stessa di rappresentazione. Lo spettatore che ha avuto modo di udire la voce scorticata di Dalmazio Masini – attore laringectomizzato nel ruolo di Antonio nel Giulio Cesare – o di scorgere fra buie macerie, su quella stessa scena, i corpi scheletrici di Alessandra Fabbri e Cristiana Bertini nei panni Bruto e Cassio, era chiamato ad essere parte dell’opera attraverso l’atto di vedere; atto che, afferma sempre Romeo Castellucci, da tempo «ha perso l’innocenza» col nostro essere eterni consumatori-spettatori.
Il culmine di questa pratica si avrà coll’imponente Ciclo della Tragedia Endogonidia (2002-2004), una serie di undici spettacoli generati in dieci città europee che, ancora, come recita il titolo, investe la propria ricerca nella riflessione sulla tragedia: «il problema della tragedia non è (…) il tema della morte, ma il tema della nascita, lo scandalo della nascita», sostiene il regista in un articolo del 2005, riportando come in Sofocle e Freud la vita intrauterina al centro del dramma umano. «Questo scandalo è legato alla condizione pre-alfabetica dell’infanzia che deve essere occupata dall’alfabeto»; e infatti il termine «endogonidia» rimanda alla biologia, ad esseri semplici che comprendono sia il maschile che il femminile. Nuovamente costituiti da un concatenarsi di visioni e vibrazioni sonore, i singoli episodi del Ciclo non hanno dunque origine da un testo, ma da un insieme di metafore di cui la città in questione è la radice.
A questo punto della storia, però, qualcosa cambia e l’assetto creativo della Socìetas assume una nuova conformazione. Dal successivo lavoro i singoli artisti scelgono di non agire insieme, ma ognuno sotto il proprio nome (fenomeno non dissimile da quello che ha visto coinvolti i membri del collettivo letterario Wu Ming).
Attraverso tale scelta, Claudia Castellucci approfondisce radicalmente la danza e il ritmo, con l’ideazione di numerosi percorsi di studio, ricerca, creazione di compagnie e performances (Mòra, Scuola Mòra, École du rythme, Scuola Còina); inoltre, realizza drammaturgie proprie, così come testi per gli spettacoli del fratello. Chiara Guidi porta avanti il suo discorso sulla voce quale «chiave drammaturgica» per opere destinate al pubblico adulto e infantile (universo, quest’ultimo, che l’ha sempre impegnata moltissimo, a partire dallo storico Buchettino) e si dedica all’ideazione di laboratori, scritture e spettacoli. Romeo Castellucci, infine, tiene fede al proprio non scendere a compromessi con la bellezza concependo allestimenti imponenti, quali la Divina Commedia (2008), lo sconcertante Sul concetto di volto nel Figlio di Dio (2010) e le molte regie liriche che lo coinvolgono mondialmente.
A Lugano, nel 2021, gli spazi del LAC hanno ospitato il debutto di uno dei suoi capolavori: Bros. Qui, su una scena perennemente ombrosa, della quale l’occhio non riesce a definire le misure, uno stuolo di comparse calza i panni di un esercito di sbirri. Non si tratta di attori, ma di semplici uomini della strada assoldati per l’occasione. Nessuno conosce la parte che dovrà interpretare. Guidati attraverso un auricolare, i partecipanti eseguono ordini impartiti via radio. È vietato loro disobbedire. Incarnando quella cieca aderenza al comando che caratterizza la pulsione, i poliziotti di Bros suggeriscono un’inquietante riflessione sul potere in un’epoca in cui la forza contenitrice del linguaggio appare fragile e annacquata. Uno spettacolo straordinario, esteticamente altissimo, dove ancora una volta il pubblico è reso partecipe di un fatto di cui deve prendere atto coi propri occhi.
Il Ring di Castellucci a Bruxelles
Alphaville 25.10.2023, 11:05
Contenuto audio