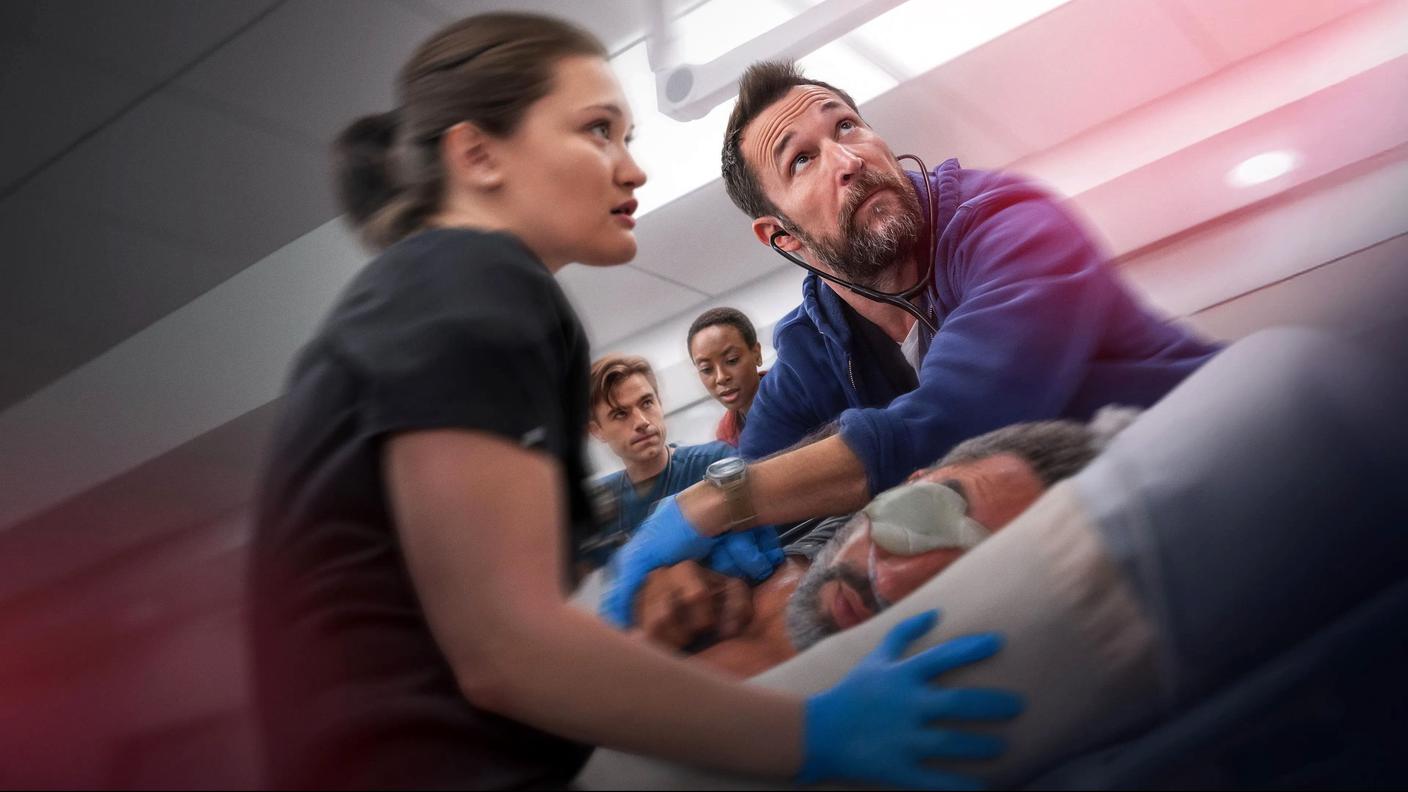Come si fa a incontrare François Truffaut nel 2024, a quarant’anni esatti dalla morte (21 ottobre 1984)? Facile: è dappertutto.
Truffaut è dentro i film di registi di tutto il mondo, che continuano a citarlo come fonte di ispirazione, nonostante siano lontani da lui nel tempo e nello spazio: ricordo tanto per dirne uno Bong Joon-Ho, in una delle tante interviste dopo l’Oscar per Parasite, dire che «I 400 colpi è la migliore opera prima della storia del cinema». Truffaut è dentro le mille serie televisive che raccontano i drammi sentimentali della contemporaneità, e che senza dichiararlo ti rimettono davanti agli occhi la freddezza di La calda amante, o l’ironia di Baci rubati. Truffaut è dentro i romanzi, citato da scrittori immensi così come da quelli immensamente scarsi. Truffaut è dentro quella strana nostalgia del Novecento che oggi appare fortissima e trasversale, anche se sempre discutibile – personalmente farei a meno di cento nuovi Hemingway, se ci risparmiassimo anche un conflitto mondiale. Perché se Truffaut è ancora attuale (vero), è anche incapsulato nell’ambra del ventesimo secolo, esempio insuperabile di quell’epoca difficile, che ad alcuni faceva da crudele scuola per raggiungere la grandezza. Truffaut è il Novecento perché amava i libri (oggi, chi legge più?) e il cinema (oggi, chi va più in sala?), e perché la sua vita assomigliava a un romanzo, a un film, come nel Novecento, senza il benessere che oggi abbiamo, poteva più facilmente capitare.
La sua biografia – quella fondamentale è ancora quella scritta ormai trent’anni fa dagli ex dei Cahiers Antoine de Baecque e Serge Toubiana – comincia con un parto clandestino: nasce un bambino concepito fuori dal matrimonio, che viene subito nascosto dalla famiglia presso una balia, e poco frequenta la giovanissima madre Janine De Monferrand. Venti mesi dopo, il piccolo François viene riconosciuto dall’uomo che sposa quest’ultima, Roland Truffaut, assistente in uno studio di architettura. Ma quella composta da Roland e Janine non sarà mai la sua famiglia. I due hanno infatti un altro figlio, che però muore a meno di due mesi di vita: non possono sopportare la vista di François, che ricorda loro quel lutto. Alla fine, il bambino viene adottato dalla nonna, che lo accoglie nel piccolo appartamento dove già vivono altri tre suoi figli. È probabilmente lei a permettere a François di diventare ciò che è stato, facendolo andare a scuola e soprattutto trasmettendogli l’amore per la lettura che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita e la carriera di regista.
Non si tratta di un’infanzia esattamente felice, beninteso, ma di un precario equilibrio che, paradossalmente, si spezza proprio quando François ritrova i suoi genitori: a dieci anni, dopo la morte della nonna, viene infatti riaccolto in casa da Janine e Roland Truffaut. La convivenza, infatti, diventa subito difficile: nei ricordi di François, la madre era una donna «acida», che lo vedeva come un ostacolo a una vita più brillante e non sopportava alcun rumore, non lasciandogli quasi altro passatempo che la lettura. Il che, viene da pensare, conferma il sospetto che nel Novecento i ragazzi leggessero di più, ma non per una particolare passione né per una diversa impostazione della famiglia o della scuola: semplicemente, non potevano fare altro. Avesse avuto a disposizione una Playstation 5, probabilmente il giovane Truffaut si sarebbe dedicato più volentieri a God of War.
Non che la lettura abbia un risultato migliore dei videogiochi, sui suoi risultati scolastici: indisciplinato, comincia un giro di iscrizioni ed espulsioni presso diversi istituti, senza alcuna soddisfazione tranne quella – non da poco, con il senno di poi – di conoscere il suo migliore amico. Robert Lachenay, più grande di un anno e mezzo, diventa per lui un Lucignolo meraviglioso, con cui condividere le avventure pericolose tra i poco raccomandabili vicoli di Pigalle, ma soprattutto le passioni per cinema e libri. Le stesse che diventeranno salvezza per due ragazzi costretti a passare la prima adolescenza nella Parigi occupata, impegnati in furti d’ottone (versione novecentesca di quelli di rame, appannaggio oggi della criminalità di più basso rango) e rivendita di vino al mercato nero. La sera François e Robert si nascondevano (quasi sempre clandestinamente) nei cinema, da cui uscivano nel buio di notti senza illuminazione pubblica, popolate da ladruncoli e prostitute che esercitavano il mestiere direttamente nelle strade. Il resto era fame, freddo e violenza. Può stupire che, di fronte a esperienze del genere, Truffaut abbia perso ogni fiducia negli adulti, e allo stesso tempo ogni nostalgia dell’infanzia? Probabile che sia proprio grazie a quelle esperienze, tragiche eppure inevitabilmente fonte di passioni contrastanti, se ha saputo raccontare l’emotività dei ragazzi in modo terribilmente autentico, senza sconfinare in alcun romanticismo.
Tra le interviste raccolte in Tutte le interviste di François Truffaut sul cinema, uscito nel 1990 per l’editore romano Gremese, ce n’è una rilasciata nel 1968 in cui il regista afferma: «Un uomo si forma tra i sette e i sedici anni, poi vivrà tutta la vita con ciò che ha acquisito tra queste due età». Ecco. Del resto, anche uno degli autori che amava, Georges Simenon, era convinto che «si lavora su tutto quello che ci è successo dalla nascita fino ai quattordici anni», come ricorda Paola Malanga nel testo che resta il fondamentale tra quelli italiani, Tutto il cinema di Truffaut.
Truffaut ha costruito quasi ogni sua storia a partire da quella sanguinosa infanzia, dai ragazzi, dai padri e dalle madri. A partire dall’insopportabile madre di Antoine Doinel nei 400 colpi.

35 anni senza François Truffaut
RSI Shared Content DME 12.12.2019, 10:03
A proposito di padri e madri, François Truffaut perde definitivamente i suoi intorno ai sedici anni, quando Roland Truffaut lo consegna alla polizia e spedisce in riformatorio. Tutto per colpa del cinema, ancora una volta.
François aveva infatti messo in piedi un cineforum con un piccolo gruppo di amici, noleggiando una sala in Boulevard St. Germain, e in poche settimane aveva accumulato migliaia di franchi di debiti, a causa dei quali aveva commesso anche qualche piccolo furto. Roland li aveva ripianati una prima volta, ma visto il perseverare del figlio, aveva deciso di passare alle maniere forti, approfittando di una legge che permetteva ai genitori di chiedere la detenzione di figli causa di grave malcontento (sic). Durante il periodo in riformatorio, se non altro François viene curato dalla sifilide che aveva contratto durante una delle sue frequenti visite ai bordelli di Pigalle (tanto per ribadire che l’adolescenza nelle città della prima metà del Novecento era, bè, diversa), ma rischia di sprofondare nella depressione.
Ad aiutarlo a superare il momento c’è la psicologa del riformatorio, la signora Rikkers, che lo raccomanda ad André Bazin, leggendario critico e fondatore in seguito dei già citati Cahiers du cinéma. Tra i diciotto e i ventuno anni, sarà Bazin – nonostante sia lui stesso pieno di problemi – a correre in suo soccorso e a tirarlo fuori da guai che visti con gli occhi di oggi sembrano pazzeschi. Ma era il Novecento: era quasi normale arruolarsi nell’esercito in seguito a una delusione d’amore, poi disertare, e finire a scrivere per una rivista (appunto i Cahiers du cinéma freschi di fondazione) pur avendo lasciato la scuola a quindici anni. Intorno alle proiezioni della Cinémathèque française prima e alla redazione della rivista poi, si cementa un gruppo di giovani appassionati destinati a cambiare il cinema europeo: tra gli altri Jacques Rivette, Claude Chabrol e Jean-Luc Godard.
Inizia così grazie a Bazin la vita da critico di Truffaut, le cui recensioni sono oggi raccolte in I film della mia vita (Marsilio, 2003), dove Truffaut dichiara il suo debito nei confronti di Bazin: «Incoraggiandomi a scrivere dal 1953 in poi, Bazin mi ha fatto un grande favore. Il fatto di dover analizzare e descrivere la propria passione non trasforma automaticamente un dilettante come me in un professionista, ma mi ha riportato a guardare alle cose concrete, in quell’area non ben definita in cui lavora il critico. Il rischio che si corre è quello di perdere l’entusiasmo: fortunatamente, non mi è successo. […] Ero un buon critico? Non lo so. Ma una cosa di cui sono sicuro è che ero sempre dalla parte di coloro che venivano fischiati e contro coloro che fischiavano; e che il mio divertimento iniziava spesso dove quello degli altri si interrompeva: i cambi di tono di Renoir, gli eccessi di Orson Welles, le disattenzioni di Marcel Pagnol o Sacha Guitry…». Questa idea di critico-Robin Hood è particolarmente attuale nell’epoca di internet, dove il 90% degli appassionati si ripromette di gettare luce su nicchie sconosciute della produzione cinematografica mondiale e ribaltare il tavolo delle grandi corporation. Eppure le possibilità di creare un solo polo culturale capace di influenzare una generazione – come sono stati i Cahiers du cinéma – sono oggi inferiori a quelle di veder fallire gli Amazon Studios. Il Novecento è lontano.
Cinque anni dopo, il giovane critico Truffaut sarebbe diventato finalmente regista – anche se la sua attività di scrittura proseguirà per i decenni successivi. Bazin, ucciso dalla leucemia a quarant’anni, non vive abbastanza per vedere terminato il primo film del ragazzo che aveva salvato da un destino segnato. O che forse si era salvato da solo, vivendo diverse vite in appena un quarto di secolo della sua: quella di figlio clandestino, ragazzo di strada e giovane dissoluto, certo. Ma anche quelle di instancabile lettore, poi di critico appassionato, infine di regista. All’ombra di quel Novecento che a “fare i 400 colpi” ti ci costringeva, anche solo per sopravvivere.