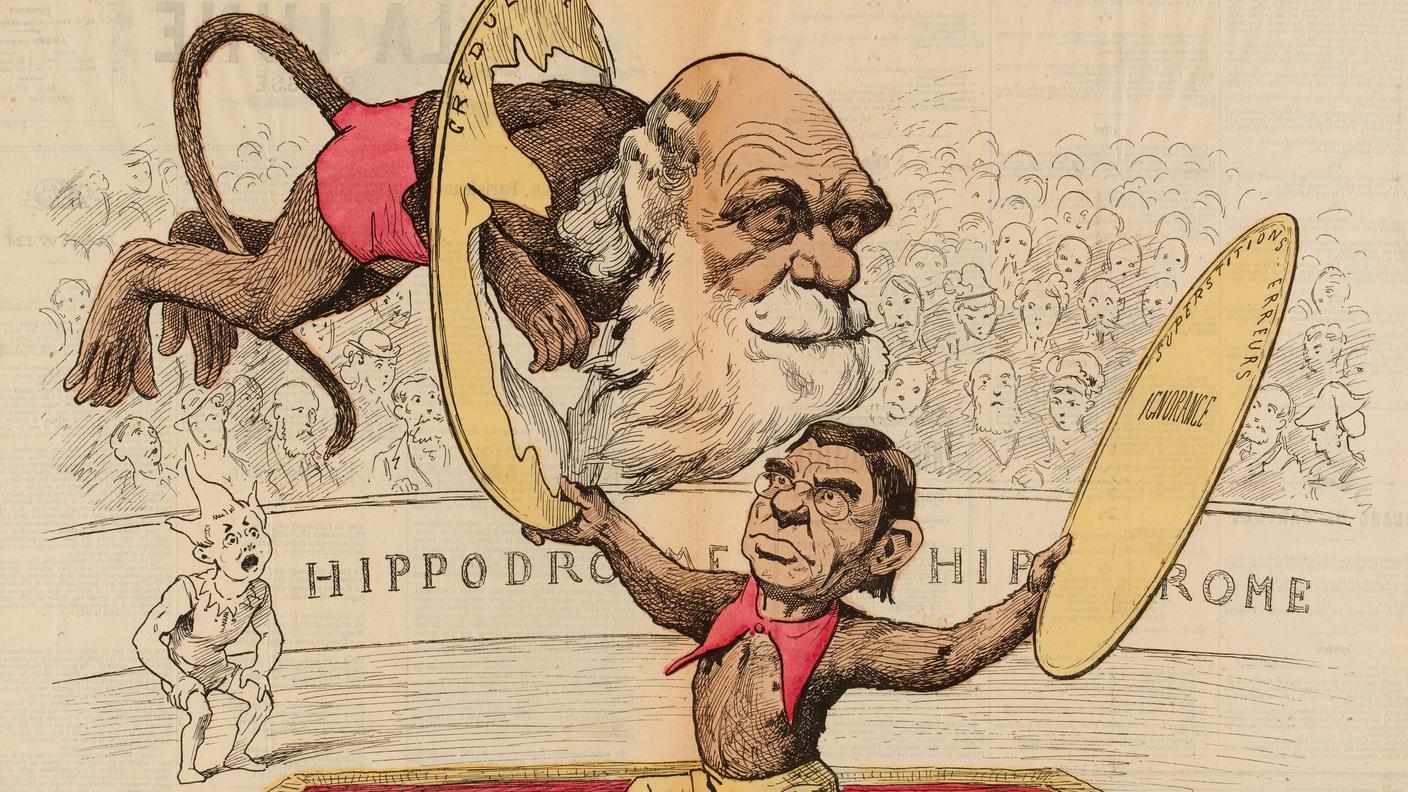Le scoperte della fisica contemporanea, a cominciare dalla teoria della relatività per giungere alla cosiddetta quantistica, rappresentano una grande svolta nell’indagine sulla natura, con conseguenze di rilievo anche per l’opinione comune. Si pensi allo sconvolgimento operato nei concetti di spazio e di tempo, che hanno perduto la consistenza tradizionale, fino ad ieri garantita dalla fisica cosiddetta classica, galileiana e newtoniana. «Per noi fisici il tempo non esiste», scriveva Einstein a un amico, per dirgli che è illusorio lo scorrere dal passato nel futuro attraverso il presente, ed anche la distanza spaziale viene annullata, se lo stesso fenomeno può apparire contemporaneamente in due luoghi lontanissimi (il cosiddetto entanglement), determinando così il carattere non locale della realtà fisica. Saltato è pure il comune, familiare concetto di materia, dal momento che si è dissolto anche quello del suo fondamento primo, l’atomo, e, in stretto parallelismo, se ne è andata anche la distinzione usuale tra materia e spirito, o materia e coscienza, entrambe da considerarsi semplicemente un fenomeno quantistico. In sintesi, la visione della realtà che la fisica contemporanea propone è olistica, ovvero comprende tutto (dal greco òlos, tutto, come l’inglese all, o il tedesco alles), e soprattutto è non dualistica bensì monistica: tutto è uno.
Non insistiamo oltre, dato che questo è acquisito, almeno a un livello medio di informazione. Meno noto invece è il fatto che le teorie fisiche contemporanee vengono utilizzate da alcuni teologi per operare una sorta di aggiornamento della religione tradizionale. Così l’immagine del Dio biblico, che crea il mondo, interviene nel tempo e nello spazio secondo il suo volere, giudica ed assolve o condanna per un aldilà eterno, ecc., viene sostituita con quella di un’ infinita energia pura, non estranea al mondo, ma ad esso intrinseca, che avvolge e permea tutto il cosmo e l’umanità intera, da sempre, perché tutto è uno, appunto, anche se si manifesta in modi molteplici.
Non intendiamo discutere qui queste idee, ma solo fare due rilievi: uno di ordine storico, un altro di ordine più propriamente religioso. Il primo rilievo consiste nel fatto che la storia della scienza è - come diceva in proposito un suo insigne esponente, Paul Feyerabend - «un cimitero di errori», nel senso che le teorie si susseguono nel tempo, in modo variamente duraturo, finendo sostituite da altre, che appaiono migliori, più “vere”, fino a che non vengono a loro volta smentite, più o meno parzialmente, da altre ancora, e così via. Per fare solo un esempio importante, quando, nel medioevo, si diffuse la fisica aristotelica, essa soppiantò le precedenti visioni del mondo e fu considerata assolutamente valida per secoli, salvo essere smentita nell’era moderna. È perciò ingenuo pensare che le teorie scientifiche contemporanee siano ultime e definitive, tali da spiegare tutto: un’idea, questa, messa in circolazione dai sedicenti divulgatori scientifici, ma categoricamente rifiutata da tutti i grandi scienziati, da Galileo, a Newton, ad Einstein, per fare solo alcuni nomi. «Il progresso ha in sé soprattutto questo, di apparire più grande di quanto lo sia davvero»: questa la frase dello scrittore austriaco Nestroy, che Wittgenstein pose in esergo alle sue Ricerche filosofiche. Al presente, infatti, i fisici stanno cercando di accordare la quantistica, che vale per il mondo dell’ invisibile, infinitamente piccolo, con la fisica classica, che vale per i fenomeni del mondo visibile, ma, nonostante tutti i tentativi, questa teoria unificata ancora manca, per cui è davvero molto ingenuo, per non dire sciocco, pensare di aver risolto tutti i problemi scientifici. E, del resto, se anche tutte le possibili domande scientifiche avessero una risposta, in nostri problemi vitali non sarebbero neppure sfiorati, scrive ancora Wittgenstein nel suo Tractatus logico-philosophicus.
Proprio questa osservazione introduce il secondo rilievo. Applicare una qualsiasi teoria della fisica alla religione non ha alcun senso, perché la prima ha a che fare con la natura e le sue eventuali leggi, mentre la seconda concerne il valore supremo, il Bene, che è «al di fuori dell’essere», come scrive Platone, per cui «il senso del mondo deve essere fuori di esso» e «la soluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori dello spazio e del tempo», per citare ancora una volta il capolavoro di Wittgenstein. Una teoria fisica può certamente avere influenza sulla visione del mondo storicamente connessa a una religione, come, ad esempio, l’eliocentrismo copernicano pose fine alla concezione geocentrica accettata dal cristianesimo medievale, ma questo non tocca per niente la sua essenza: il valore religioso della Divina Commedia non è certo diminuito dal fatto che Dante segua la concezione aristotelico-tolemaica dell’universo. Ai giorni nostri, all’ arcivescovo di Canterbury che chiedeva ad Einstein quali fossero le conseguenze sul piano religioso della teoria della relatività, il grande scienziato rispose stupito che, ovviamente, non c’era conseguenza alcuna, dato che quella della relatività è una teoria fisica e, come tale, non ha niente a che fare con la religione. Pensare che la fisica abbia in qualche modo influenza nel religioso è possibile solo se si pensa quest’ultimo come spiegazione del mondo; una confusione concettuale determinata dal fatto che la fede stessa viene vista come una credenza, che fornisce un sapere surrogatorio e/o integratore della fisica, ad esempio per quanto concerne un “aldilà”, immaginato nello spazio e nel tempo, o per un “anima”, immaginata come elemento in vario modo rapportato al “corpo”. Ovvio che questi contenuti della “fede” possono esser messi in discussione dalla scienza della natura, ovvero dalla fisica, determinando il ben noto, ma assurdo, conflitto fede-scienza. Infatti la fede non è affatto una credenza, ma, al contrario, il movimento dell’intelligenza verso l’assoluto, che libera da ogni contingente credenza e presunto sapere, facendo spazio alla luce eterna, che può così pervadere l’anima. Così hanno pensato e pensano i veri maestri spirituali, non solo del mondo cristiano occidentale, ma di tutti i tempi e di tutte le culture.
Il lungo percorso della fisica
Alphaville 24.03.2025, 12:35
Contenuto audio