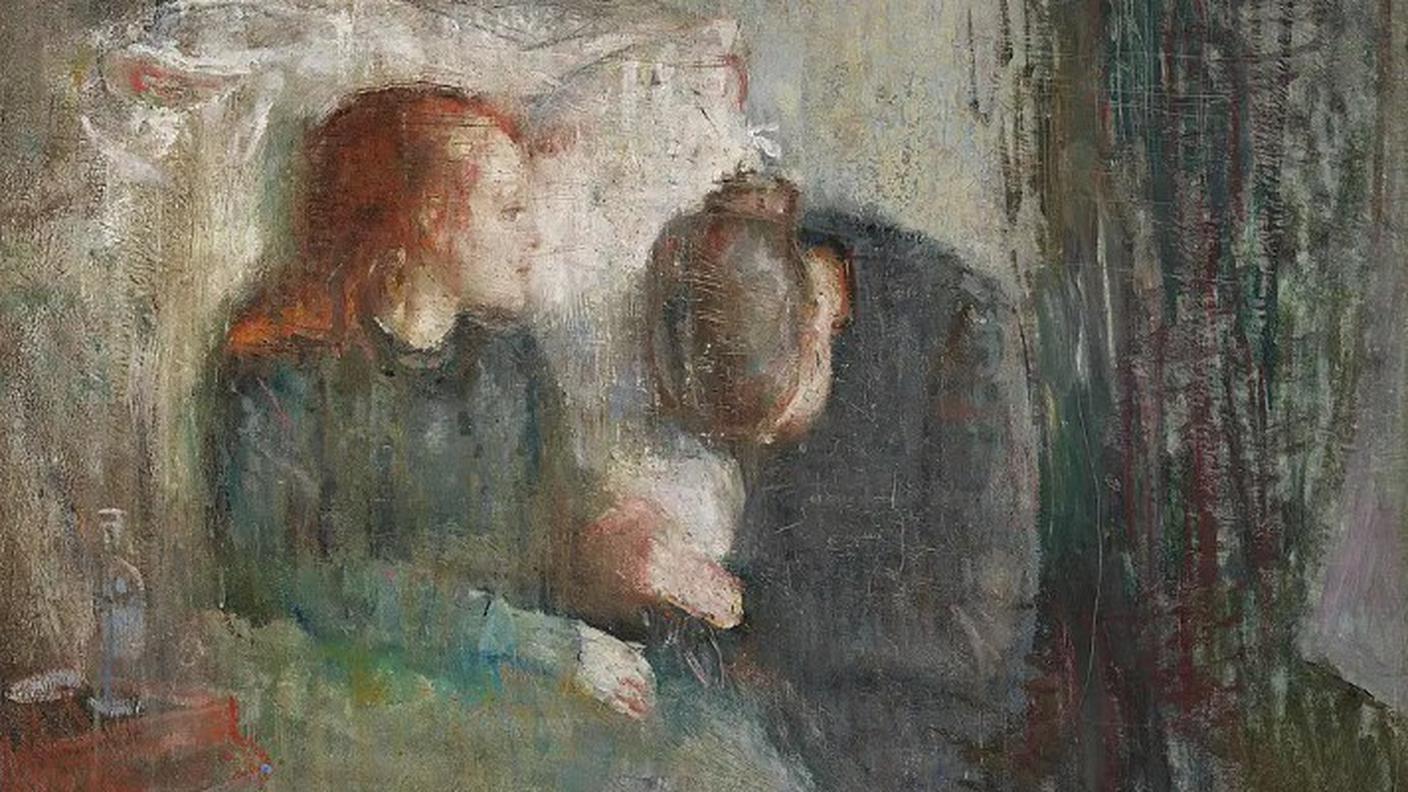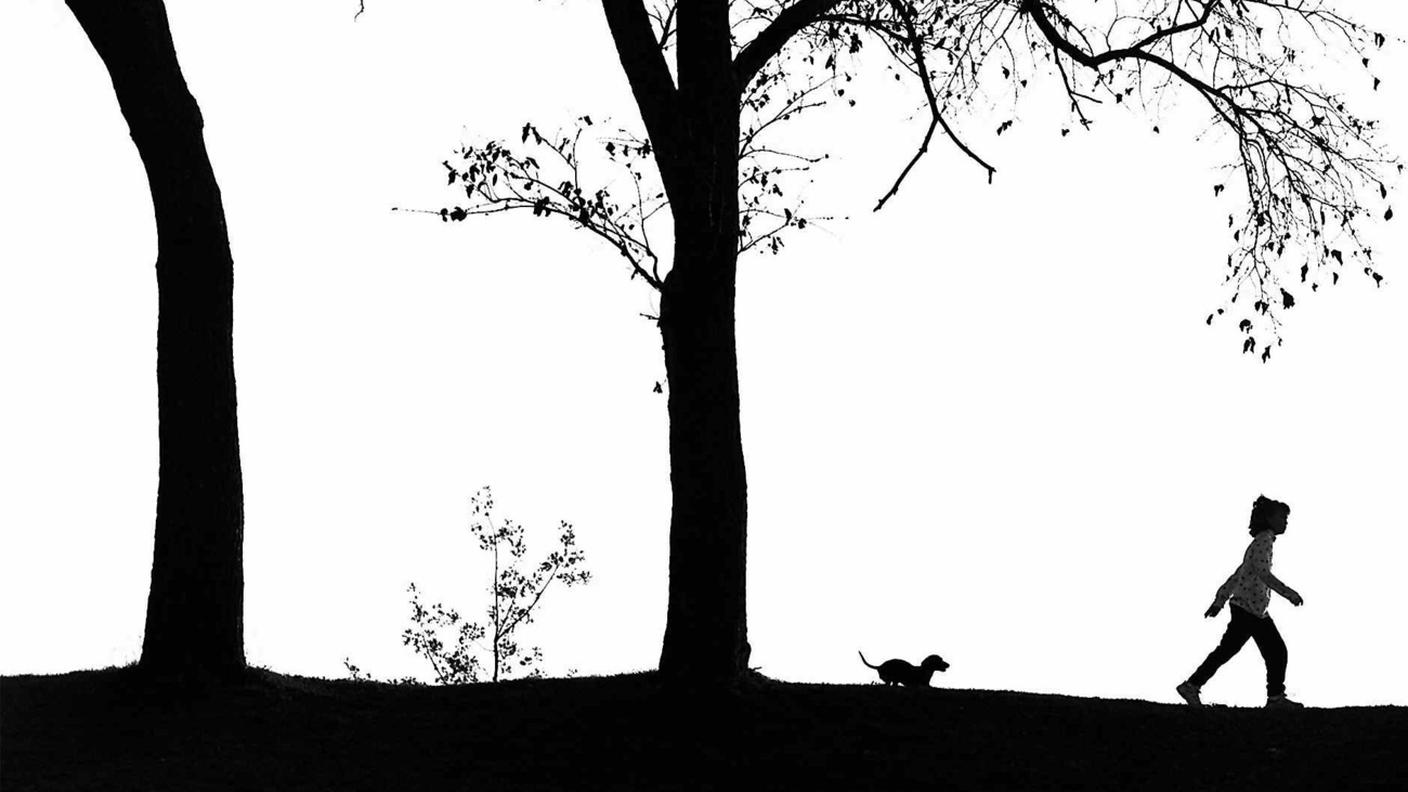Con le avvenute esequie di papa Francesco in piazza San Pietro e la tumulazione delle sue spoglie nella basilica patriarcale di Santa Maria Maggiore tutta l’attenzione è ora rivolta all’imminente conclave, il cui compito, per utilizzare le parole pronunciate dallo stesso Bergoglio la sera della sua elezione, è quello di «dare un vescovo a Roma».
E non potrebbe essere diversamente, come ricorda l’antica formula proverbiale “Morto un papa, se ne fa un altro”. In essa è racchiusa tanto il buon senso popolare quanto la fede nella continuità ininterrotta del ministero petrino. Aspetto, quest’ultimo, che tocca da vicino, o almeno così dovrebbe essere, il miliardo e oltre quattrocento milioni di fedeli cattolici sparsi per il mondo e, soprattutto, i cardinali elettori. In base a quanto ordinato da Paolo VI con il motu proprio Ingravescentem aetaetem (21 novembre 1970) e con la costituzione apostolica Romani Pontifici eligendo (1 ottobre 1975), nonché riconfermato da Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Universi dominici gregis (22 febbraio 1996), sono da considerarsi elettori quei porporati che, all’inizio della vacanza della Sede apostolica, non abbiano ancora compiuto l’ottantesimo anno di età.
Tenendo in conto che, nel caso specifico, il periodo di Sede vacante è iniziato il 21 aprile, giorno della morte di Francesco, dovrebbero essere in tutto 134 i cardinali elettori, ben al di là, dunque, del tetto massimo di 120 stabilito da Paolo VI e riconfermato da Giovanni Paolo II. Il condizionale è d’obbligo visto che il numero potrebbe salire a 135, qualora dovesse entrare in conclave anche il cardinale settantaseienne Giovanni Angelo Becciu. Costretto da Francesco nel 2020 a rinunciare alla carica di prefetto dell’allora Congregazione per le Cause dei Santi e ai «diritti connessi al cardinalato» a seguito del caso Sloane Avenue, il presule sardo non è stato mai canonicamente deposto né ha rinunciato, con il consenso del Papa, alla dignità cardinalizia. Che, giova ricordarlo, sono le due sole condizioni poste dall’Universi dominici gregis (nr. 36) per escludere un porporato infraottantenne dall’ingresso in conclave. Sulla questione, in riferimento alla quale il blog Silere non possum – e bisogna darne atto ai relativi curatori – parla da tempo nei termini di “atto inedito, senza precedenti giuridici chiari” (tanto più che l’accennata rinuncia ai diritti non è stata mai formalizzata), è chiamata a esprimersi una delle prossime Congregazioni generali preparatorie.
In quella odierna, ossia la quinta in ordine di tempo, è stato decisa, in ottemperanza a quanto previsto dal motu proprio di Benedetto XVI Normas nonnullas (22 febbraio 2013), la data d’inizio conclave, vale a dire il 7 maggio.
Giunti a questo punto, è opportuno però riflettere su cosa sia precisamente il conclave e come si è evoluto a grosse linee nel tempo un tale istituto ecclesiastico. Derivato dal latino classico conclave-is, che significa stanza o camera, il termine assunse, solo a partire dal XIII secolo, l’accezione propria di luogo sottochiave e rigorosamente chiuso agli esterni, in cui si riunisce il Collegio dei cardinali per procedere all’elezione del Romano Pontefice. Con esso si sarebbe indicato sin da subito la stessa adunanza di porporati, riuniti in clausura, per provvedere alla designazione del nuovo vescovo di Roma. Benché se ne possano già ravvisare gli antecedenti nelle riunioni del 1198 o del 1216, che portarono alle rispettive elezioni di Innocenzo III e Onorio III, il conclave nel senso odierno della parola fu introdotto da Gregorio X con la costituzione apostolica Ubi periculum, promulgata il 16 luglio 1274 durante il II Concilio di Lione. Il pontefice si era deciso a un tale atto dopo che la sua elezione in Viterbo era avvenuta, l’1 settembre 1271, a quasi tre anni, cioè, dall’inizio della Sede vacante per la morte di Clemente IV (24 novembre 1268): ad accelerare i tempi, si fa per dire, erano intervenuti gli stessi viterbesi, che avevano prima rinchiuso i cardinali nel locale palazzo vescovile e messi gli stessi a pane e acqua, quindi scoperchiato il tetto della grande sala dove quelli erano riuniti. A questo punto è necessario però ricordare, data l’importanza che rivestirà in tutta la normativa conclavaria successiva, il precedente disposto riguardante l’elezione papale a opera esclusiva dei cardinali senza distinzione di ordine – Niccolò II aveva stabilito nel 1059 che tale compito spettasse ai soli cardinali vescovi – e con i due terzi di voti degli stessi: a sancire ciò era infatti stato Alessandro III con la costituzione Licet de vitanda del marzo 1179.
Le severe norme stabilite da Gregorio X suscitarono agli inizi un largo malcontento tra i cardinali, tanto da essere prima sospese da Adriano V nel 1276, quindi abrogate in quello stesso anno dall’immediato successore Giovanni XXI, con il conseguente ritorno a prolungate elezioni fatte al di fuori del conclave. A ripristinarle ci avrebbe pensato, sullo scorcio del 1294, Celestino V con tanto di riconferma, di lì a poco, da parte di Bonifacio VIII. Tali norme, come quelle successivamente emanate in materia di elezione papale, furono unificate per la prima volta da Pio IV con la costituzione apostolica In eligendis (9 ottobre 1562), che prevedeva, fra l’altro, l’ammissione in conclave anche dei cardinali sottoposti a censura o scomunicati. Ma per la codificazione di una legislazione organica al riguardo, che tranne alcune successive e piccole modifiche sarebbe rimasta tale fino agli inizi del XX secolo, si dovette attendere Gregorio XV con le due costituzioni Aeterni Patris (15 novembre 1621) e Decet Romanum Pontificem (12 marzo 1622). Tra le disposizioni gregoriane quella sicuramente più celebre riguarda il divieto assoluto di autoelezione da parte di qualsiasi cardinale.
Un’opera di sapiente revisione dell’intera normativa in materia fu attuata da Pio X, che con la costituzione apostolica Vacante Sede Apostolica (25 dicembre 1904) introduceva delle importanti innovazioni, tra le quali bisogna almeno menzionare l’assoluta segretezza su quanto avvenuto in conclave e l’eliminazione, tra le forme d’elezione, dell’accessus, sostituito con un secondo scrutinio tanto al mattino quanto al pomeriggio. Va inoltre ricordata, secondo quanto già ordinato dallo stesso pontefice con la Commissum nobis del 20 gennaio 1904, la proibizione assoluta del diritto di veto, o ius exclusivae, da parte di potenze laiche nei riguardi di un candidato loro sgradito e la comminazione della scomunica latae sententiae ai relativi trasgressori. Conseguenza immediata di quanto successo proprio nel conclave del 31 luglio – 4 agosto 1903, durante il quale il porporato Jan Puzyna aveva comunicato il veto d’esclusione contro il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro da parte dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Altre modifiche alla legislazione conclavaria furono successivamente apportate da Benedetto XV, Pio XI, Pio XII e Giovanni XXIII. Ma le più importanti sono quelle contenute nei documenti, già più volte citati, di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.
Bisogna soltanto ricordare tra le novità più importanti stabilite dall’Universi dominici gregis, le cui norme hanno completamente sostituito tutte quelle fino ad allora emanate, la definitiva abolizione delle due antiche forme di elezione per acclamazione o ispirazione e per compromesso (restando, dunque, unicamente quella per scrutinio segreto) e l’indicazione della Domus Sanctae Marthae come luogo d’alloggio dei cardinali riuniti in conclave, non più sistemati in anguste celle allestite all’occorrenza nel Palazzo apostolico. Si deve, infine, a Benedetto XVI (motu proprio De aliquibus mutationibus dell’11 giugno 2007) il ripristino assoluto della maggioranza qualificata dei due terzi dei voti per l’elezione papale anche dopo il trentaquattresimo scrutinio, laddove Giovanni Paolo II aveva permesso, a partire da quella votazione, una designazione del vescovo di Roma per maggioranza assoluta. Il resto è storia dei nostri giorni. Per sapere chi sarà il 267° Papa della Chiesa cattolica, non resta che attendere la tradizionale fumata bianca e l’Annuntio vobis gaudium magnum, che sarà dato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti dalla loggia centrale della basilica di San Pietro. Si starà a vedere.

Conclave, chi sarà il nuovo Papa?
SEIDISERA 23.04.2025, 18:00
Contenuto audio