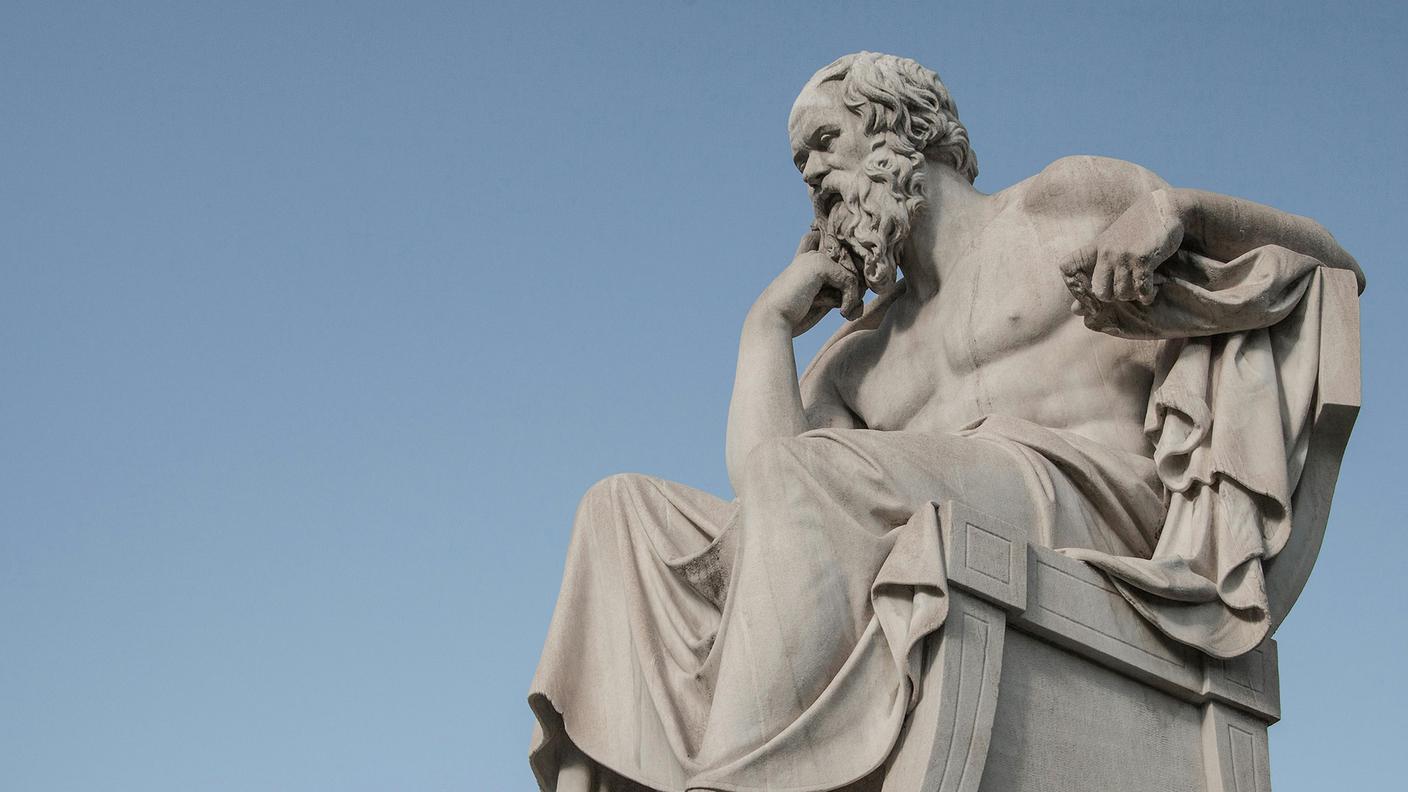In quanto esseri umani siamo dotati di una capacità di immaginazione, rielaborazione e analisi pressoché illimitata. Tuttavia, quelle stesse caratteristiche che ci rendono unici nel genere animale e che hanno determinato il successo della nostra specie attraverso le epoche e gli avvenimenti, diventano anche un nostro limite. Se è vero che la mente è quello strumento che ci permette di comprendere e interpretare la realtà, è altrettanto vero che tende a confinarci nella nostra prospettiva individuale e soggettiva, con il rischio di ridurci a prigionieri della nostra interpretazione della realtà. Infatti attraverso questa nostra visione non vediamo il mondo com’è, quanto piuttosto ciò che la nostra mente limitata ci permette di percepire. Anziché avere davanti a noi un’immagine nitida e in alta definizione di ciò che è, vediamo una frammentazione offuscata di ciò che sembrerebbe essere e che la nostra immaginazione accetta come realistica e veritiera.
Acquisendo consapevolezza dei limiti della nostra prospettiva univoca (inevitabilmente parziale e fallibile) possiamo mantenerci aperti a nuove prospettive, ma ciò richiede uno sforzo di apertura e umiltà. In questo sembra riecheggiare a gran voce il buon vecchio Socrate, quando afferma che la sua unica saggezza sta nel “sapere di non sapere”, e cioè nel riconoscere la propria ignoranza. Seppure tutti noi conosciamo almeno per sentito dire quella celebre citazione faremmo bene a ricordarla ogni volta in cui ci sentiamo fossilizzati su un’idea.
Le idee: preziose quanto pericolose
Tutti noi abbiamo delle idee, sempre, continuamente, su ogni cosa, che ne siamo consapevoli o meno. Non appena incontriamo qualcosa di nuovo formiamo istantaneamente un’idea al riguardo. Le idee sono uno strumento per ridurre l’enorme complessità della vita a un nocciolo comprensibile e intellettualmente digeribile. Le idee portano conforto, ci fanno sentire al sicuro, ci permettono di mettere a tacere le domande della coscienza e ci fanno dire che sì, siamo brave persone e sì, le cose stanno proprio così come pensiamo. Amiamo le nostre idee a tal punto da identificarci con esse, fino a cogliere una critica alle nostre idee come una critica alla nostra persona, al pari di un insulto. Identificarsi con le proprie idee è tuttavia un pericolo, ci porterà ad avere scambi solamente con persone che condividono la nostra stessa opinione. Il che di per sé non è un problema, passare del tempo con chi condivide i nostri interessi è fantastico, ma lo può diventare se non siamo consapevoli del rischio di chiuderci in una limitata bolla cognitiva, creando nella nostra mente un noi e un loro, una distinzione tra chi la pensa come noi e chi no. Si sa che l’essere umano è di natura gregario e tribale, e una volta che si identifica con un gruppo finisce troppo facilmente per provare ostilità verso gli altri, basti guardare qualsiasi sistema politico, qualsiasi tifoseria, qualsiasi nazione, per osservare l’astio tra gruppi di persone.
E non solo gli appartenenti a tali gruppi di pensiero vedono gli altri come “sbagliati”, ma sempre di meno permetteranno a loro stessi e agli altri membri del gruppo di cambiare opinione su un determinato tema, anche all’emergere di nuove informazioni. Il cambiare opinione, specialmente su questioni di etica e di politica, è generalmente poco tollerato. Ma non è forse un segno di virtù e saggezza, avere il coraggio di cambiare opinione in seguito all’acquisizione di nuove conoscenze? La scienza stessa, il metodo di indagine per eccellenza in quanto apertura al cambiamento, è restia all’inclusione di nuove scoperte, e si va avanti a insegnare e predicare per anni e anche decenni conoscenze già rivelate come obsolete. Perché? Perché persino la scienza è in mano a esseri umani, e gli esseri umani, come già discusso, si identificano morbosamente con le loro idee.
Il dialogo: uno strumento fondamentale al processo di crescita
Il dialogo, per quanto possa sembrare banale e scontato dirlo, rappresenta un reale strumento per ampliare la propria visione del mondo. Quando due o più parti si confrontano con reale apertura e con il desiderio comune di approssimarsi alla verità, anziché spingere ognuno le proprie opinioni (e il proprio ego) sugli altri, o fare un’azione propagandistica (specie nel dibattito pubblico) si crea la reale possibilità di cambiare opinione. Il dialogo in questo senso non è più dunque un mero atto di comunicazione, ma un vero e proprio atto di scoperta. Le nostre opinioni, per quanto possano essere consolidate e il frutto di anni di ricerca, non sono e non saranno mai verità assolute. La verità, se di verità al singolare si tratta, può essere solo avvicinata per approssimazione, e non può essere incisa in un dogma.
Se accettiamo la nostra visione della realtà come inevitabilmente parziale e limitata, comprendiamo che la chiave per un pensiero più ampio risiede nella messa in questione e dunque, nel dialogo.
Più forme di dialogo possibili
Il dialogo non è solamente quello che si affronta a due persone, nell’espressione verbale. Il dialogo come strumento per ampliare il proprio punto di vista può essere esplorato in più forme. Ecco qui di seguito alcuni esempi. Scrittori di ogni genere e epoca hanno scelto la scrittura come metodo di dialogare con sé stessi, come metodo di investigazione della propria realtà morale. Attraverso la scrittura, anche di un diario, abbiamo la possibilità concreta di confrontarci con il potere delle nostre idee, e metterne in questione la loro correttezza. L’atto di scrivere ci costringe a esprimere con chiarezza ciò in cui crediamo, e ci permette di osservare con prospettiva chi siamo, con i benefici della distanza obiettiva della terza persona singolare. La terapia verbale è un altro metodo efficace nel prendere coscienza non solo del nostro modo di vedere il mondo, ma anche della nostra stessa identità. La terapia efficace e professionale non è quella che afferma e rinforza l’idea che abbiamo di noi stessi, bensì quella che la mette in questione, per non ridurci a essere solamente il risultato della nostra storia passata. Si può inoltre scegliere di assumere un approccio ancora più elevato, nel dialogo con il nostro concetto di Dio, o Vita, o Universo, o Spirito, o Morale, o come altro si voglia chiamare la nostra idea di Bene e Male. Abbiamo una capacità cognitiva talmente alta come specie che nel più delle situazioni, ponendoci la semplice domanda “come agirei se fossi una persona che fa del Bene?” riusciamo a evadere l’abitudine del nostro consueto agire per consentire a un concetto più alto di manifestarsi tramite noi.
Vorrei concludere dicendo che sì, la nostra visione del mondo è inevitabilmente parziale, ma non per questo siamo condannati a rimanere ingabbiati nelle nostre idee. Il dialogo onesto, in qualsiasi sua forma, diventa uno strumento di espansione e liberazione. Se ci arrendiamo a riconoscere il nostro non-sapere e a metterci sinceramente in discussione possiamo rinnovarci ogni giorno, con apertura e umiltà.
Homo ignorans!
Moby Dick 19.01.2018, 16:30
Contenuto audio