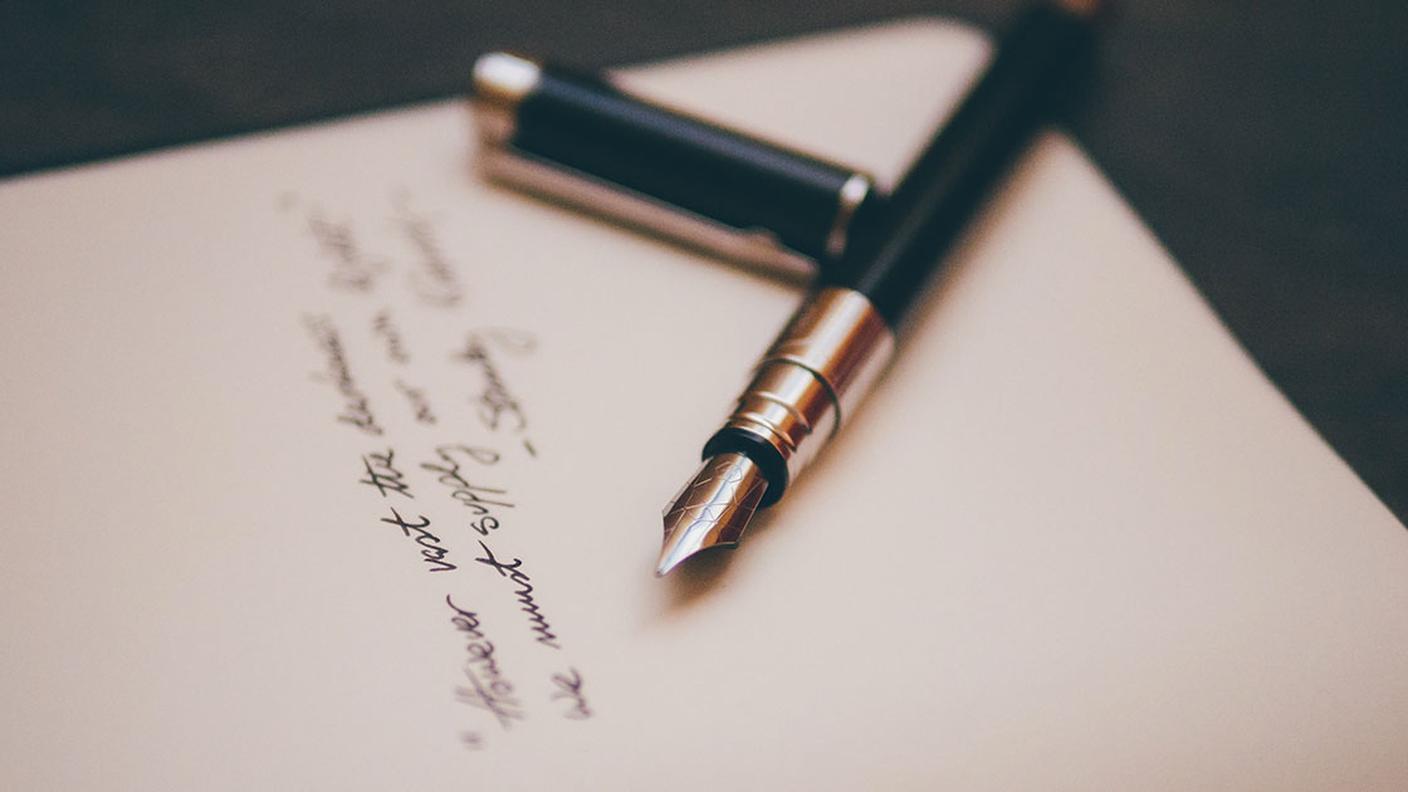Sabato 13 settembre verrà assegnato a Venezia il Premio Campiello, tra i più importanti riconoscimenti della letteratura italiana. Il settimanale radiofonico letterario di Rete Due Alice ha ospitato i cinque scrittori finalisti in altrettante interviste, che qui riproponiamo nella versione integrale. Dopo quella con Fabio Stassi, è il turno di Alberto Prunetti, autore di Troncamacchioni (Feltrinelli).
Un romanzo storico con molta storia vera dentro, sulla nascita del fascismo. O meglio, ambientato durante la nascita del fascismo. Ma qui non si parla di figure singole, apicali, che rimangono nei libri di storia, da Mussolini in giù. Qui ci sono protagonisti di estrazione socioeconomica bassa o bassissima: minatori, facchini, calzolai, mezzi criminali.
Appaiono prima durante la Prima guerra mondiale: disertori, gente che non ha voluto combattere, che si è data alla macchia, oppure magari a una vita di espedienti. Poi però diventano anche quelli che, negli anni successivi, in qualche modo si oppongono al nuovo che avanza. Il nuovo che avanza, nell’Italia degli anni Venti del Novecento, ha la camicia nera, ed è destinato a conquistare il potere.
“Troncamacchioni“
Alice 06.09.2025, 14:35
Contenuto audio
«Troncamacchioni – spiega Alberto Prunetti – è un’espressione del gergo ristretto dei boscaioli, dei carbonari dell’entroterra maremmano, quindi della Toscana meridionale. Probabilmente non arriva neanche a Firenze. Dunque, il fatto è che la macchia mediterranea è di basso fusto, composta di arbusti dove è facile tagliarsi. Nel bosco ci vuole umiltà, nel senso che in qualche maniera bisogna piegarsi, e non si può andare dritto. La maggior parte delle persone, almeno, non segue una linea dritta quando si muove nei boschi.
Invece le persone più esperte, i cacciatori, i bracconieri – quelli che vivevano nel bosco ai primi del Novecento – riuscivano come di forza a rompere la macchia col petto. C’è solo un’attestazione scritta di questa espressione, utilizzata in un memoriale di un di un patriota del Risorgimento, che racconta di quando Garibaldi rompeva il bosco col petto. Significa un farsi avanti di forza nella vita, un po’ di prepotenza, un po’ per la giustezza delle proprie ragioni. Questa espressione è usata tutt’oggi, anche in chiave un po’ vernacolare, ecco».
Michele R. Serra: Queste storie si svolgono negli anni Venti del Novecento. Perché quello è stato un momento cruciale? E perché valeva la pena guardarlo da questa prospettiva provinciale?
Alberto Prunetti: Io sono un provinciale, che vive in quei posti, o li attraversa. La provincia è spesso percepita come periferia lontana, eccentricità. Però Luciano Bianciardi sosteneva che uno scrittore dovrebbe vivere in provincia, perché in provincia quei fenomeni che altrove sono colti in maniera più faticosa, qui li trovi netti, concentrati, più chiari. Non so se sia poi davvero così, ma di fatto mi sono ritrovato a vivere tutta la mia esistenza in provincia.
Qui ho cercato di saltare dalla provincia a una chiave più globale, di partire dalla Provincia per raccontare un momento fondamentale del Novecento: in un contesto come quello rurale vediamo questo passaggio di generazione, di servi della gleba che a un certo punto alzano la testa e iniziano – appunto – a muoversi un po’ a troncamacchioni. Poi arriva il fascismo che gliela fa abbassare. Quindi ho pensato che era un altro modo di raccontare la genesi del fascismo. Scurati è partito da Milano, altri dal confine orientale, Trieste. Poteva essere interessante anche provare a capire cos’era successo in luoghi un po’ più distanti dai centri del potere, della cultura.
“Troncamacchioni“ di Alberto Prunetti, Feltrinelli (dettaglio di copertina)
Il sottotitolo di Troncamacchioni è: Novella nera con fatti di sangue. Poi quando cominci a leggere, si capisce che siamo dalle parti del racconto storico. Di cosa si tratta esattamente? Il genere è importante?
Oggi le storie più interessanti sono quelle che, più che dentro a un genere, si pongono un po’ sui margini, al crocevia di generi diversi. Da un lato qui c’era una dimensione di romanzo storico, poi probabilmente l’idea di Gadda del Pasticciaccio come forma ibrida, anche linguisticamente, per provare a raccontare un pezzo del Novecento. Poi c’è l’inchiesta storica archivistica, il tentativo di far emergere un cold case, in qualche maniera.
Ho provato a raccontare questa storia con un escamotage: partire dal lavoro negli archivi, ma poi offrire la storia nelle mani di due narratori un po’ inattendibili, che la raccontano a modo loro. Anche in maniera diversa da come, forse, l’avrei raccontata io.
Gli eroi di Troncamacchioni sono ovviamente antieroi, per diversi motivi: perché sono persone violente, ignoranti, difficili da maneggiare. Ma sono anche un simbolo di libertà e di ribellione.
Questi personaggi li seguo da tantissimi anni, e ho provato a raccontarli a più riprese. Personalmente, sono passato dalla fascinazione giovanile a una maggiore distanza. Oggi i personaggi a cui mi sento più agganciato sono personaggi minori, quelli che compaiono magari in maniera episodica, occupando la RAM del lettore in maniera molto marginale.
La cosa interessante è quella che spiega anche Calvino nel Sentiero dei nidi di ragno, quando racconta in maniera fiabesca dei personaggi che forse raccontati da una prospettiva adulta sarebbero stati complicati. Calvino dice anche che c’è una parte giusta, che riesce, anche con il materiale umano più complicato, a fare quello che il momento storico richiede. Ecco, probabilmente è una percezione che ho avuto anch’io: ci sono personaggi che escono da un senso di subalternità che era stato dell’antico regime, e che poi probabilmente nella loro lotta contro il fascismo sbagliano, nel senso che probabilmente avrebbero potuto prendere altre vie, quelle delle lotte popolari. Non con una lotta che sembra una vendetta privata.
Io racconto, ad esempio, di un figlio che cerca di vendicare il padre ammazzato dai fascisti, e nell’uccidere il più ricco del Paese, che associa al fascismo, uccide anche uno che non c’entrava nulla. È una storia complicata, difficile da raccontare anche oggi in posti dove non sembra sia stata digerita né dalla giustizia né dal senso comune.
Era difficile trovare dei personaggi poetici, avventurosi, eroici, come altri bravissimi hanno fatto: Penso a Paco Ignacio Taibo II, a Pino Cacucci… la Maremma non mi offriva personaggi così brillanti, cristallini, trasparenti. Mi dava da un lato degli sgherri, dall’altro dei personaggi un po’ rivoluzionari, un po’ briganti, un po’ malfattori, un po’ ladri di galline.
Ho cercato di mettere insieme questo materiale umano, questi pezzi di mosaico novecentesco fatto da un lato di violenza, ma dall’altro anche di aspirazioni idealistiche utopiche, alcune addirittura quasi di tipo ereticale. In quelle parti ci sono state anche alcune delle ultime eresie Ottocentesche… è un territorio complicato. Non potevo raccontarlo con personaggi facili, tutto qui.
Ogni capitolo comincia con introduzioni che giocano con citazioni letterarie altissime, a partire da Omero. Al di là dell’effetto comico paradossale, c’è anche qualcosa di simbolico: si può fare epica partendo dal basso?
È proprio quello, il mio tentativo: arrivare a un’epica un po’ farsesca, un po’ stracciona, rovesciando i registri dell’alto e del basso. Da un lato non è una cosa così paradossale, perché in realtà c’è sempre stata questa tradizione sul territorio, in particolare nella poesia a braccio estemporanea, una forma di poesia orale, e anche molto agonistica, che si faceva un tempo nelle osterie, ora in certi circoli Arci; prima era una cosa tra pastori, ora magari lo fanno l’operaio o i contadini, che riprendono la forma metrica dei versi della Commedia di Dante o dell’Ariosto, e la portano verso la realtà.
Quindi avevo questo bagaglio strano, che mescolava il rurale e il cortese, e ho provato appunto un po’ a lavorarci, a mettere in tensione continuamente l’alto e il basso. Lo faccio anche con i documenti d’archivio che ho trovato, che hanno questa lingua barocca, la lingua morta della burocrazia, l’anti lingua di cui parlava Calvino. È la lingua che ho trovato nei carteggi dei tribunali, a contrasto con quel poco che sono riuscito a trovare di lingua popolare.
La lingua serve anche a cozzare un po’ con lo storytelling della Maremma da cartolina che adesso va di moda: i vini, i menu, con personaggi tipo i briganti, che sostanzialmente son venduti alla carta dai ristoratori nel turismo mordi e fuggi dell’estate. Ho provato a mettere in tensione invece questa Maremma novecentesca, che aveva caratteristiche completamente diverse perché era diverso il sistema produttivo, ma anche perché c’era un immaginario completamente diverso da quello dei nostri giorni. Su questo gioco di contrasto ideologico e linguistico, ma anche politico, si regge un po’ tutta la
La Maremma al telefono
Geronimo 07.10.2020, 11:35
Contenuto audio