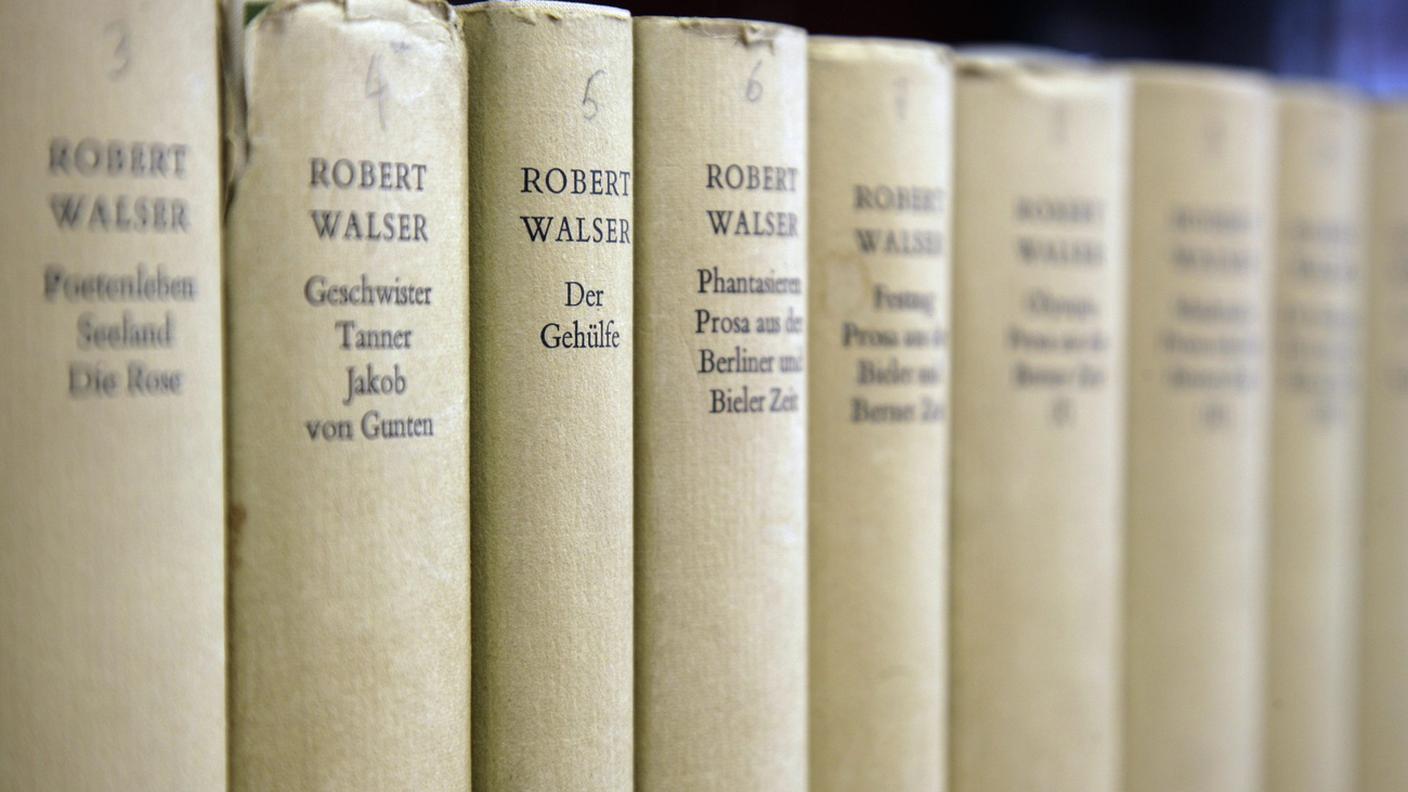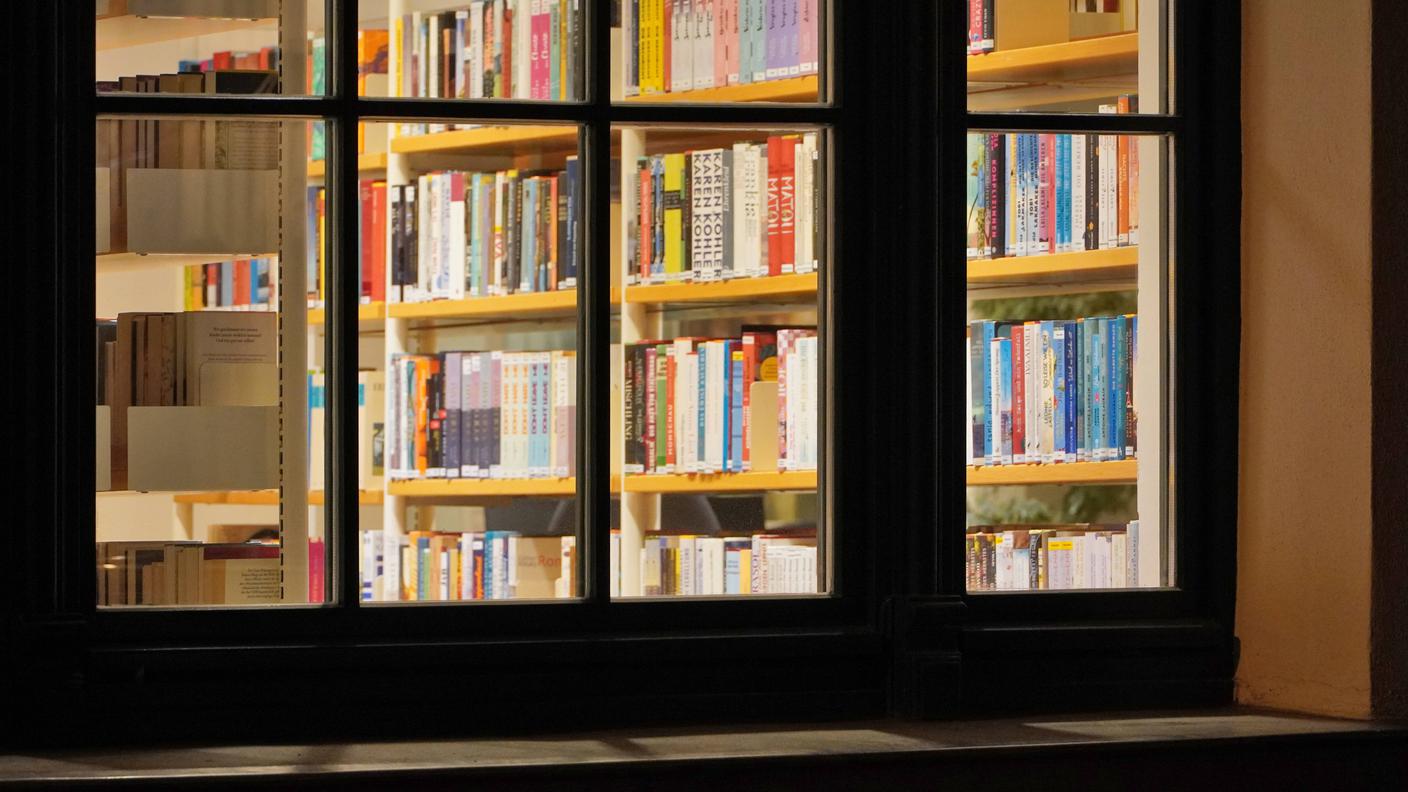Alcuni anni fa il politologo (superstar) Robert D. Putnam ha teorizzato il concetto di “capitale sociale”. Per Putnam la densità e la durata dei legami di un individuo definiscono la compattezza e la resistenza del suo “tessuto sociale” in due maniere: c’è chi fa da “ponte” e chi fa da “legante”. I ponti servono a estendere il proprio spazio, ad aprirsi verso realtà divergenti e magari salire qualche gradino della scala sociale. I leganti invece servono per cementare i gruppi e consolidare le posizioni raggiunte. Ponti e leganti, che quindi svolgono funzioni complementari, contribuiscono a costruire un ordine sociale in tutte le comunità umane.
Il capitale sociale, di cui tutti siamo forniti seppur in modo diverso, è un’arma potente che tuttavia presenta anche un rovescio della medaglia: quando un elemento portante non funziona più, il gruppo crolla; quando un individuo si allontana troppo e disequilibra la struttura, i ponti si devono tagliare… ma a che costo? Che spazio c’è per le verità scomode? Quando la comunità è instabile come cambia il concetto di giustizia? E si può parlare di etica se la possibilità di scelta è limitata?
“Pregate per ea”
Alice 25.10.2025, 14:35
Contenuto audio
Queste domande se le è poste anche lo scrittore e musicista Massimo Zamboni all’interno del suo romanzo storico Pregate per ea, uscito a metà ottobre per Einaudi.
A Monteorsaro, un piccolo paese sull’Appennino emiliano di cui Zamboni è originario, la comunità è fragile; sono montagne su c’è poco lavoro e poco cibo, ci si conosce tutti e si ha bisogno dell’aiuto di tutti per sopravvivere. Così, quando Maria Domenica Gebennini viene assassinata, in un giorno di giugno del 1870, la comunità tace: bisogna proteggere il colpevole, addossare tutta la responsabilità alla vittima, fare finta che non sia successo nulla di straordinariamente grave, dimenticare perché tutto torni a funzionare come prima. Gliene facciamo una colpa? Sulle montagne le cose vanno così; «le radici hanno bisogno di oscurità per prosperare», scrive Zamboni.
Il libro di Zamboni cerca di recuperare le tracce di un passato che è stato volutamente taciuto. Di Domenica, a Monteorsaro, rimane solo una lapide nascosta nei boschi, una pietra con un nome e un invito alla preghiera. Zamboni, che rivela subito il colpevole dell’omicidio, ricostruisce la sua vicenda con meticolosità e straordinaria polifonia riportando le dichiarazioni degli abitanti del luogo e gli atti del processo conservati nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia.
Massimo Zamboni
RSI Showcase 12.03.2024, 08:30
Quello che è interessante, in Pregate per ea, è come Zamboni utilizza il paradigma indiziario tipico del romanzo giallo all’interno del romanzo storico: le testimonianze non servono a scovare il colpevole, ma a mettere insieme i frammenti della storia con le sue luci e le sue ombre. Una volta incollati i cocci, la crepa è ben visibile, e tuttavia il vaso non fa più acqua da tutte le parti.
In questo senso, attraverso la descrizione romanzesca delle circostanze, Zamboni recupera una dimensione etica: si percepisce la necessità del silenzio e si umanizzano vittime, carnefici e testimoni. Il nostro sguardo sui fatti diventa meno severo, più empatico, più rispettoso della verità.
Così, quando si ricostruisce la vicenda di Domenica, non solo si deve tenere conto delle condizioni estreme di una comunità montana alla fine del XX secolo, ma anche del concetto di giustizia all’interno della società rurale all’alba dell’unità d’Italia.
Zamboni mostra chiaramente come lassù valga ancora un ordine ferino, ancestrale e crudele, lo stesso codice che adottano le greggi quando un membro del gruppo muore: lo abbandonano, ricorda Zamboni. La legge dello Stato italiano, nato solo da una decina d’anni, è letteralmente incomprensibile da parte di chi è abituato a comunicare solo nel proprio dialetto. La lingua della giurisprudenza di Pregate per ea fa eco al latinorum manzoniano: è strumento di esclusione e mezzo per esercitare dei rapporti di forza; comunque non fa piena giustizia alla vittima o alla comunità.
Il filosofo e storico polacco Leszek Kołakowski diceva che «la fede è valida e l’ateismo è valido, ed entrambi sono necessari» alla società. In Pregate per ea la precisione storica chiarisce la verità, il romanzo le dà un volto umano, ma è solo la preghiera che, per Zamboni, aiuta a metabolizzare fatti che altrimenti non comprenderemmo appieno.
Del resto, si può davvero capire un omicidio? La preghiera è una forma acritica e astorica di rispetto: nell’epoca delle cose che cambiano in fretta, dei giudizi lampo, dei rapporti liquidi, ogni tanto, forse, dovremmo solo starcene in silenzio.
Massimo Zamboni
Dieci autori ripercorrono la loro infanzia per Alphaville
Contenuto audio
Lessico personale (1./5)
Alphaville 07.07.2025, 12:05
Lessico personale (2./5)
Alphaville 08.07.2025, 12:05
Lessico personale (3./5)
Alphaville 09.07.2025, 12:05
Lessico personale (4./5)
Alphaville 10.07.2025, 12:05
Lessico personale (5./5)
Alphaville 11.07.2025, 12:05