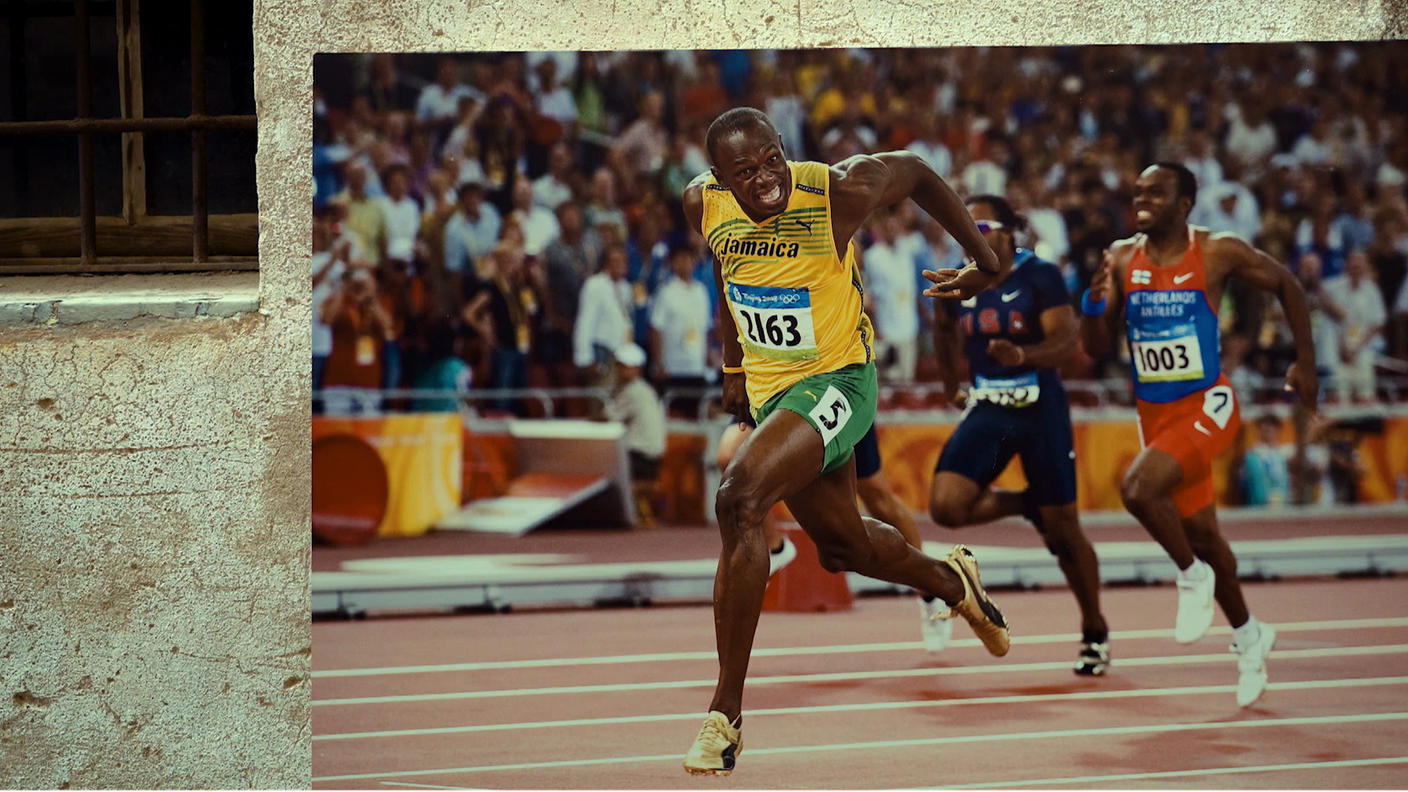C’è stato un tempo in cui l’apice della virilità consisteva nel piangere sotto la pioggia cantando Quit playing games (with my heart) in cinque voci perfettamente armonizzate. Un tempo in cui bastava una frangetta mèchata e una camicia sbottonata per far tremare milioni di cuori. Le boyband, quelle creature mitologiche composte da giovani maschi coordinati nel look e nei sentimenti, non sono solo un fenomeno musicale: sono un laboratorio vivente di genere, identità, ma soprattutto di marketing. Una macchina culturale che ha insegnato ai ragazzi a piangere, alle ragazze a sognare e agli studiosi di genere a prendere appunti. E se pensate che sia solo “musica per ragazzine”, preparatevi a ricredervi. Dietro ogni I’ll be there for you c’è una costruzione precisa di mascolinità. Non quella virile e muscolare, ma quella pop: vulnerabile, romantica, estetica. I gender studies ci insegnano che dietro ogni coreografia sincronizzata c’è una produzione culturale della mascolinità e dietro ogni falsetto, un’intera teoria queer che scalpita.
Backstreet Boys
Facciamo una band? 23.04.2025, 06:10
Contenuto audio
Le origini: da barbershop a Backstreet
Le boyband non sono nate negli anni ’90, anche se è lì che hanno raggiunto l’apice commerciale. Georgina Gregory, nel suo saggio Boy Bands and the Performance of Pop Masculinity (Routledge, 2019), traccia una genealogia del fenomeno che affonda le radici nei gruppi vocali afroamericani degli anni ’40 e ’50, come i The Ink Spots e i The Platters, che già proponevano armonie vocali, coreografie coordinate e un’estetica curata. Questi ensemble, spesso nati in contesti di segregazione razziale, offrivano una mascolinità elegante e controllata, pensata per piacere a un pubblico ampio e rassicurare: quello bianco.
Negli anni ’60 e ’70, con l’arrivo dei Jackson 5, la formula si perfeziona: giovanissimi, talentuosi, stilizzati, capaci di incarnare sia l’innocenza infantile che il desiderio adolescenziale. Michael Jackson, in particolare, diventa il prototipo dell’idolo pop maschile: vulnerabile, magnetico, performativo.
Negli anni ’80 e ’90, la formula viene industrializzata: New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys e NSYNC portano la boyband nell’era del marketing globale, con un’estetica sempre più curata e una narrazione emotiva pensata per le adolescenti. Infine, con One Direction negli anni 2010, il modello si aggiorna all’era dei social media, dove l’interazione diretta con i fan e la costruzione di identità individuali diventano centrali.
La Gregory ci spiega come questi gruppi performano una mascolinità “filogina”, cioè costruita per piacere al pubblico femminile, caratterizzata da vulnerabilità emotiva, estetica curata e romanticismo esplicito. Ogni membro della band incarna archetipi maschili accessibili: il romantico, il timido, il leader. In questo modo ogni fan può scegliere il suo preferito e proiettare sogni, desideri e poster in cameretta. Ma sotto questa apparente leggerezza, si nasconde una costruzione precisa e controllata della figura maschile. Le boyband performano una mascolinità “sicura”, come scrive Susan Bordo in The Male Body (1999): il corpo maschile è mostrato, ma mai sessualizzato, è desiderabile, ma non minaccioso, è romantico, ma non erotico. È, in fondo, un prodotto pensato per il consumo femminile e queer. I testi romantici, le coreografie emotive e l’estetica curata offrono un’alternativa ai modelli virili dominanti, creando uno spazio sicuro dove il desiderio può esprimersi liberamente. Come mostrano i gender studies, questa mascolinità performativa — teorizzata da Judith Butler - permette a fan giovani, donne e persone queer di identificarsi, reinterpretare e co-creare significati di genere attraverso il fandom, trasformando il pop in un laboratorio identitario.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/societa/Da-Star-Trek-a-Fifty-Shades-of-Grey--1996289.html
Il fandom come spazio femminile e queer
Il fandom delle boyband è da tempo uno spazio privilegiato per l’immaginazione femminile e queer, dove il desiderio può esprimersi liberamente e il genere può essere reinventato. Henry Jenkins, nel suo classico Textual Poachers (1992), spiega come il fandom diventa uno spazio di produzione culturale attiva. Lì, le fan non si limitano a consumare contenuti, ma li creano. Scrivono fanfiction, creano universi alternativi, reinterpretano le dinamiche tra i membri delle band (spesso in chiave sessuale) secondo logiche affettive e identitarie che sfuggono all’eteronormatività. Un esempio emblematico è After di Anna Todd, nata come fanfiction su Harry Styles degli One Direction e diventata una saga bestseller tradotta in oltre 30 lingue, con adattamenti cinematografici di successo. Un altro caso recente è The Idea of You, film con Anne Hathaway tratto dal romanzo omonimo di Robinne Lee, ispirato anch’esso ad Hazza che racconta la storia d’amore tra una donna quarantenne e un giovane cantante di una boyband. In queste narrazioni, il fandom diventa uno spazio queer e femminile dove il pop non è solo intrattenimento, ma anche strumento di agency, sogno e sovversione. Come nota Henry Jenkins, il fan è un textual poacher: ruba, riscrive, reinventa. E nel caso delle boyband, lo fa con passione, glitter e una buona dose di gender theory.
Poi arrivano i BTS e il gioco cambia
Nel panorama delle boyband, i BTS non sono solo un gruppo musicale: sono il punto di svolta che ha ridefinito il genere, il pubblico e il linguaggio stesso del pop. Il vero punto di svolta del K-pop è l’estetica: le boyband coreane adottano uno stile fluido, androgino e altamente curato. Trucco, moda genderless, espressioni emotive e narrazioni complesse diventano parte integrante dell’identità artistica. Questo tipo di mascolinità si discosta radicalmente dai modelli occidentali tradizionali e si rivela particolarmente inclusivo per il pubblico queer e femminile. Come sottolinea la studiosa Sun Jung in K-pop Idols, Social Media, and the Remaking of the Korean Wave (2011), il K-pop offre modelli alternativi di genere che sfidano le norme egemoniche e creano nuove possibilità di identificazione. Inoltre, il K-pop non si limita alla musica: costruisce veri e propri universi narrativi. I video musicali sono pieni di simbolismi, riferimenti letterari e trame che si sviluppano nel tempo, creando un coinvolgimento simile a quello delle serie TV o dei fandom fantasy. I BTS, in particolare, hanno saputo trasformare ogni album in un capitolo di una storia più ampia, dove il pubblico non è solo spettatore, ma parte attiva del racconto.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/musica/speciali/La-storia-del-K-Pop-1010--2001290.html
Le boyband sono molto più di un prodotto musicale. Sono specchi culturali che riflettono e modellano le nostre idee di mascolinità, desiderio e identità. I gender studies ci aiutano a vedere oltre il scintillio, a capire che ogni passo di danza è anche un passo politico. E se oggi un ragazzo può piangere in pubblico, indossare eyeliner e scrivere poesie su Instagram senza essere deriso, forse in qualche modo lo dobbiamo anche ai Backstreet Boys.