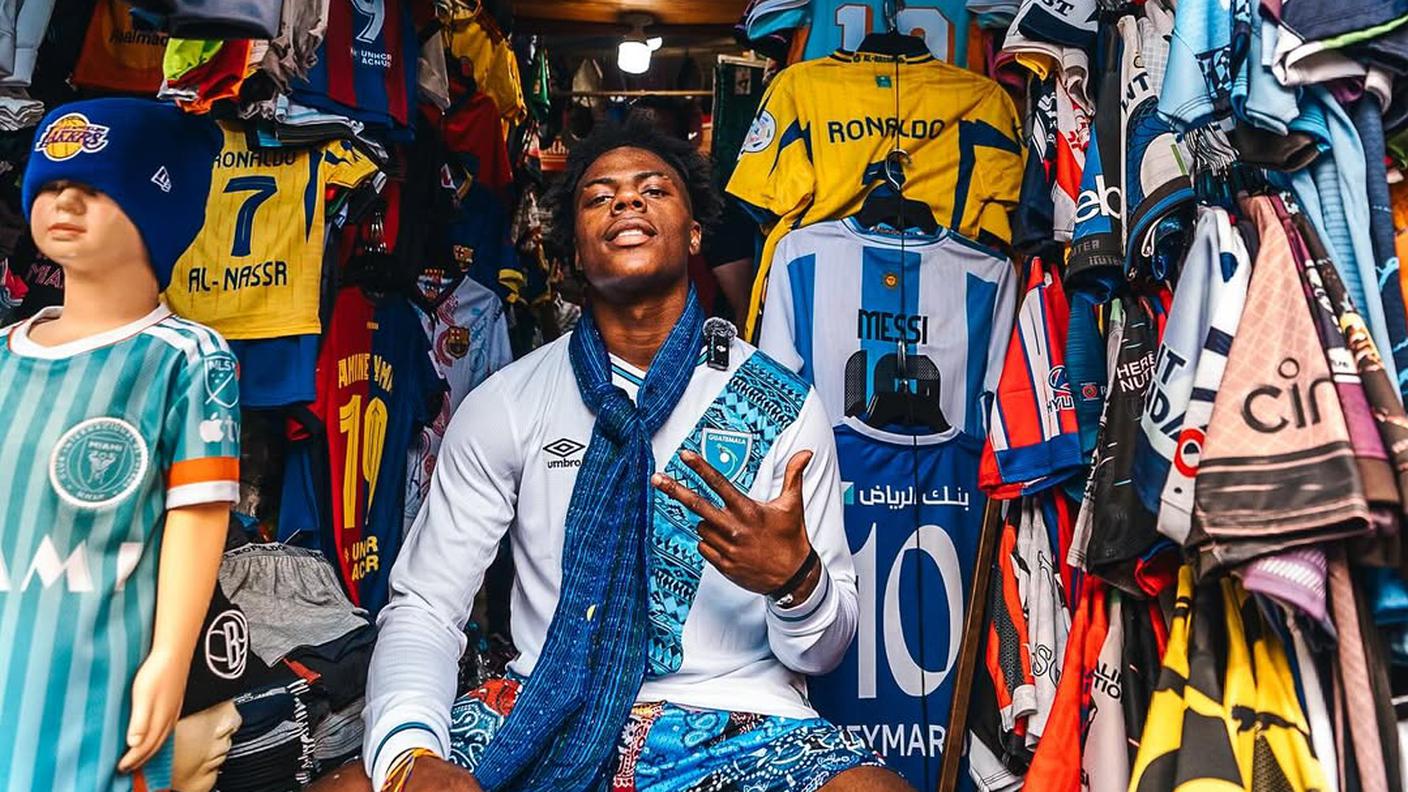Sudario è l’immagine iconica del ghiacciaio del Rodano, protetto da teloni riflettenti nel tentativo di rallentarne la fusione. Una immagine scelta a manifesto de L’Uomo e il clima, il festival diffuso nel tempo e nello spazio che ha preso il via il 21 di novembre e che durerà fino a maggio 2025. Cinque mostre, un evento, una rassegna cinematografica e una serie di conferenze per esplorare il rapporto tra l’umanità e il cambiamento climatico, in una sorta di viaggio conoscitivo nella storia del clima che cambia, dall’ultima glaciazione ad oggi.
Quando mi sono trovato di fronte a questo ghiacciaio e ho visto questo tessuto galleggiante, dove il corpo deposto era sparito lasciando solo un sudario vuoto, ho visto noi, ho visto l’ umanità e il suo futuro… e mi sono accorto che non bastava fotografarlo; bisognava capire, raccontare, condividere.
Gianluca Bonetti
Così Gianluca Bonetti, fotografo di ghiacciai, curatore di mostre e ideatore de L’Uomo e il clima. Il progetto nasce dunque da un’urgenza, quella di informare e diffondere in modo accessibile i risultati della scienza, per creare consapevolezza di fronte a un problema che riguarda noi e ancora di più i nostri discendenti.
L’Uomo e il clima è un festival che si avvale dell’accompagnamento scientifico di Cristian Scapozza del Centro competenze cambiamento climatico e territorio, e soprattutto del sostegno di un Comitato d’onore composto da scienziate e scienziati e di personalità di rilevanza internazionale che hanno accolto l’invito ad aderire al progetto e si propone come un percorso di riflessione che, intrecciando antropologia, geologia, scienze naturali, arte, teatro, fotografia e cinema, intende dare una visione d’insieme sulla complessa tematica dei cambiamenti climatici; perché se è vero che se ne parla spesso, raramente si va a vedere cosa si cela dietro questi cambiamenti.
Da qui la scelta del tempo lungo come prospettiva principale del festival: perché conoscere il clima passato ci permette di comprendere meglio quello presente, di capire dove stiamo andando e di conseguenza di sollecitare quella transizione energetica ed ecologica che si fa sempre più urgente.
Emergenza Terra; l’Acqua che verrà. Tanti gli ospiti, tra cui Luca Mercalli
Tra le righe 25.11.2024, 15:30
Contenuto audio
Non è un caso che sia il mammut l’emblema del festival: l’animale più iconico e possente della preistoria recente e dell’ultimo periodo glaciale aveva sviluppato un folto e lungo manto peloso per resistere al freddo della glaciazione, ma non sopravvisse al riscaldamento olocenico e all’azione dei nostri antenati
.Anche l’Uomo si trova ora confrontato con una sfida ambientale epocale. Il continuo rilascio di gas serra nell’atmosfera e il conseguente riscaldamento rischia infatti di riportare la temperatura del pianeta a livelli analoghi a quelli di milioni di anni fa, quando i mari erano più alti di alcune decine di metri.
La Terra ha vissuto ciclicamente alterazioni climatiche e meteorologiche estreme, alternando glaciazioni profonde a periodi di riscaldamento. Tuttavia, dalla rivoluzione industriale in poi, l’azione umana ha profondamente destabilizzato questi fragili equilibri naturali, con effetti ormai chiaramente visibili.

Coppia di zanne di Mammut, 20'000 a.C.
Come la scienza ci dimostra ormai da molto tempo, l’aumento esponenziale delle emissioni di CO2 nell’atmosfera (la concentrazione della CO2 atmosferica non ha mai superato le 280 ppm nell’ultimo milione di anni, ma dalla seconda metà dell’Ottocento ha cominciato a crescere, fino ad arrivare dagli anni ‘90 in poi a quota 420 ppm), assieme ad altri gas a effetto serra, è la causa diretta dell’aumento di temperatura – che a sua volta è all’origine di eventi estremi come alluvioni e siccità.
La prospettiva del tempo lungo, con le numerose variazioni climatiche che si sono succedute sul pianeta, potrebbe contenere una insidia: il clima è sempre cambiato, perché preoccuparsi ora?, qualcuno potrebbe pensare. È vero, il clima è sempre cambiato, ma tutti i cambiamenti climatici del passato anche remotissimo erano dovuti a cause naturali: dipendevano dal livello dell’attività solare, dalla tettonica delle placche, dal vulcanismo. E soprattutto avvenivano sull’arco di centinaia di migliaia, se non milioni, di anni: un’eternità, al confronto degli appena 100 anni che hanno determinato i cambiamenti di temperatura di cui siamo oggi testimoni, e responsabili.
Se infatti una volta erano le variazioni climatiche a dettare le leggi dell’evoluzione, oggi avviene il contrario: è l’uomo che determina le variazioni climatiche. E con una velocità mai vista in tutta la storia del Pianeta.

Il deserto che avanza, Marocco meridionale, Gianluca Bonetti, 2021
Il Festival vuole così mettere in luce la preziosità della finestra climatica relativamente stabile e mite dentro la quale ci ritroviamo da circa 10’000 anni, che non a caso ha permesso il fiorire della civiltà come la conosciamo oggi. Ora con le nostre emissioni che intensificano l’effetto serra (scoperto ben 200 anni fa) stiamo scardinando questa finestra climatica eccezionale, creando i presupposti per grandi cambiamenti dalle conseguenze molto pesanti come un nuovo innalzamento del livello dei mari, l’inaridimento di vaste regioni del pianeta e l’intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi.
Le mostre al Museo delle culture, alla Biblioteca cantonale di Lugano e al Museo di storia naturale raccontano proprio questo, mettendo a confronto la stabilità degli ultimi 10’000 anni con le grandi oscillazioni del passato. E a raccontare il rapporto fra l’umanità e il clima saranno di volta in volta l’arte, gli animali, i libri, le fotografie…
L’Uomo e il Clima, al MUSEC
Alphaville 23.11.2024, 12:00
Contenuto audio
La prima mostra, che prende il nome dal Festival, L’Uomo e il clima, è stata inaugurata al Musec il 21 di novembre e costituisce un po’ l’albero maestro da cui si diramano le altre esposizioni. Propone un viaggio a ritroso nel tempo che conduce sino all’ultima glaciazione (tra 110’000 e 11’700 anni fa), vale a dire il periodo climatico che vide la maturazione cognitiva della nostra specie.
Il rapporto fra l’essere umano e i cambiamenti climatici del passato è descritto per mezzo della scienza, del mito (quello del Diluvio universale) e soprattutto dell’arte. In mostra vi sono infatti anche alcune piccole, preziosissime sculture che costituiscono i primi manufatti artistici dell’umanità. Furono realizzate oltre 40’000 anni fa, e rappresentano un mammut (delle cui zanne proviene l’avorio di cui sono fatte), un leone, un bisonte e un cavallo.

Coppia di zanne di Mammut, 20'000 a.C.
La narrazione continua alla Biblioteca cantonale di Lugano, (3 dicembre-15 febbraio 2025) con le pubblicazioni di quegli scienziati che a partire dal Seicento hanno scoperto il passato climatico della Terra, e hanno raccontato come hanno capito ciò che oggi sta accadendo, e perché. Tra questi un pioniere come il premio Nobel svedese Svante Arrhenius, il quale a fine ‘800 evidenziò per primo la correlazione tra il tasso di CO2 nell’atmosfera e la temperatura media della Terra.
Nella mostra La mano del Clima e la mano dell’Uomo, al Museo cantonale di storia naturale (21 febbraio 2025-21 febbraio 2026), a raccontare l’evolversi della fauna per mano del clima che cambia e poi dell’uomo saranno gli animali, i grandi mammiferi vissuti negli ultimi 200’000 anni tra Canton Ticino e Lombardia, dove si è passati da leoni, rinoceronti e ippopotami a specie glaciali come i mammut, fino alla fauna odierna.

A completare il percorso espositivo, una mostra di immagini e libri fotografici presso la Fondazione Artphilein di Paradiso dedicata alla fusione dei ghiacciai. Con il titolo Lost Ice, dal 27 novembre al 26 aprile 2025, proporrà il lavoro di 60 fotografi internazionali sulla fusione dei ghiacciai alpini, marini e polari; un tema fondamentale perché è proprio l’osservazione dei ghiacciai che nell’800 permise di comprendere che il clima cambia.
Alla Galleria Repetto di Lugano (20 febbraio-11 aprile 2025) saranno opere di grandi artisti contemporanei, da Beuys a Penone, a illustrare e a riflettere sui rapporti dell’uomo con l’ambiente e con il clima.

Carolina Maria Nazar, Senza titolo (di fatto una interpretazione contemporanea del Diluvio che verrà), 2023-2024, olio, pigmento e acrilico su tela
Non solo mostre, ma anche un evento – L’acqua che verrà (30 novembre 2024), dedicato a uno degli agenti principali del sistema climatico sul territorio –, una rassegna cinematografica presso il Lux di Massagno (Cinema e clima, dal 15 gennaio al 5 febbraio 2025) e una serie di conferenze.
Linguaggi diversi per parlare di un unico tema, il rapporto fra l’umanità e il clima che cambia, con il coinvolgimento di diversi attori: sette istituzioni pubbliche e private e associazioni attive sul territorio. Perché mai come oggi, che ovunque sembra perdere terreno la consapevolezza dell’urgenza della transizione ecologica, è importante fare rete, e cercare di creare un contagio positivo e moltiplicativo: un po’ come succede con la Ola negli stadi. Il festival si inserisce proprio in questo contesto poco incoraggiante per le sorti climatiche, con lo scopo di sensibilizzare il più possibile il grande pubblico. Nella convinzione che, per citare Jonathan Safran Foer, se noi siamo il diluvio, siamo anche l’arca da cui può venire la salvezza. Costruendo soluzioni e navigando verso un domani sostenibile.
La mostra “L’uomo e il clima”
RSI Cultura 01.03.2025, 19:00