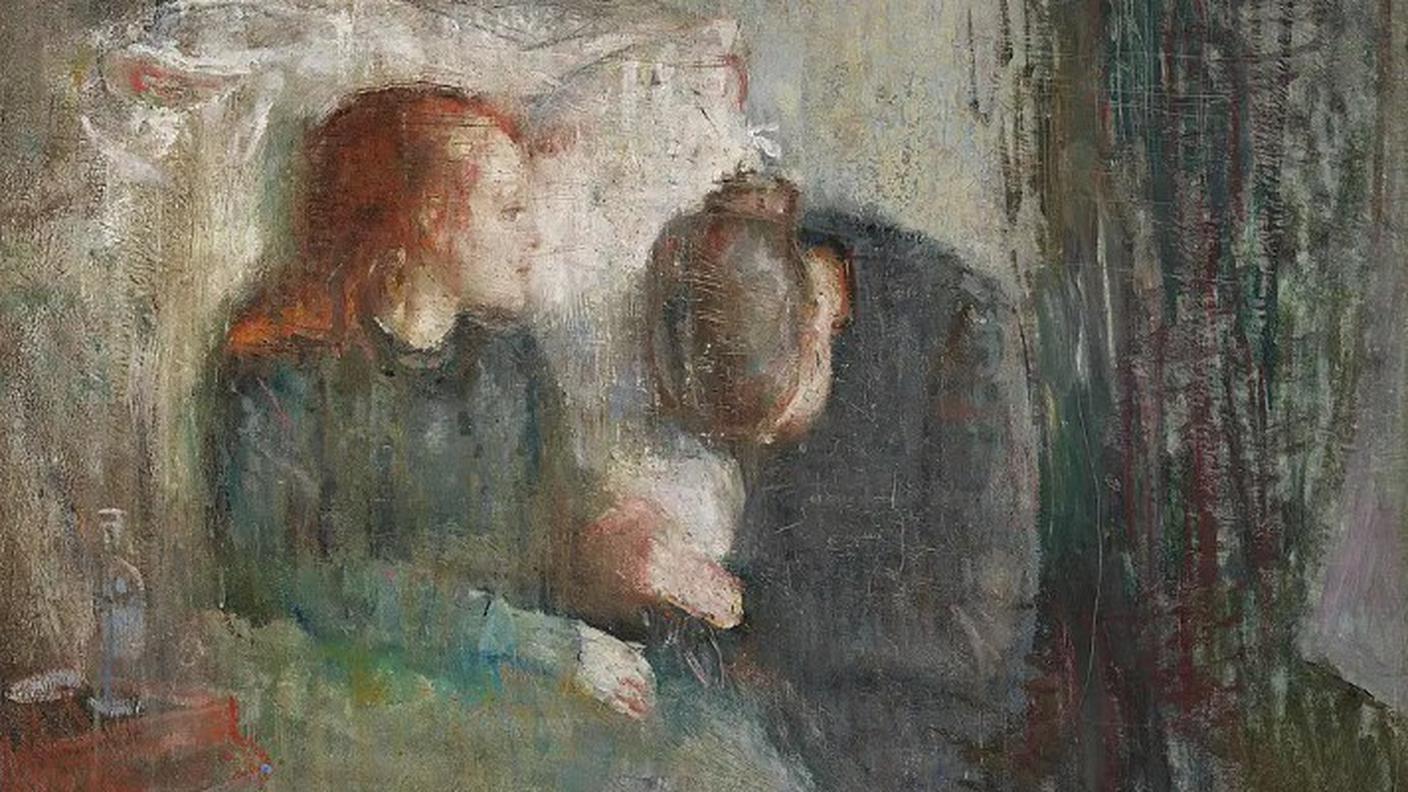Il Maxi Processo a Cosa Nostra fu un atto di rottura nella storia italiana, un momento in cui lo Stato mostrò di poter sfidare apertamente la mafia. Dal 10 febbraio 1986 al 16 dicembre 1987, nell’aula bunker costruita accanto al carcere palermitano dell’Ucciardone, si giudicarono 475 imputati per omicidi, traffico di droga, estorsioni e associazione di stampo mafioso. Giuseppe Ayala, che sostenne la pubblica accusa, ricorda ancora quel peso: «Mi sono ritrovato a sostenere l’accusa nei confronti di 475 imputati dei reati più gravi che si possano immaginare». La sua voce, quarant’anni dopo, conserva la stessa lucidità: «Quel processo ha dato la sensazione che lo Stato, quando decide di esserci, lo sa fare».
L’aula bunker – che il giornalista Giampaolo Pansa ribattezzò “l’astronave verde” – nacque dalla necessità e dall’urgenza. Non esistevano modelli, né architettonici né logistici, in grado di ospitare un processo di quelle dimensioni e di assicurare adeguati standard di sicurezza. L’architetto Francesco Martusciello, incaricato alla fine del 1984, lavorò senza sosta. «Non c’era al mondo un esempio simile. Abbiamo lavorato un anno senza fermarci; le ultime pitture furono fatte poche ore prima dell’inizio del processo», racconta. Per dare forma a qualcosa che non esisteva, guardò oltre l’edilizia giudiziaria e trovò ispirazione in modelli lontani, come il teatro italico e il panottico: «Serviva un rapporto visivo continuo tra giudici e imputati, un senso quasi sacrale dell’aula». Le 30 gabbie, capaci di contenere fino a venti detenuti ciascuna, furono disposte in modo che la Corte potesse vederle tutte. Anche le sedute interne furono progettate a scalare, così che nessun imputato sfuggisse allo sguardo.
La costruzione fu una corsa contro il tempo, con soluzioni ingegnose e a volte improvvisate: travi prefabbricate usate normalmente per i viadotti stradali divennero la struttura portante della sala. «Non si poteva perdere nemmeno un giorno», ricorda l’architetto.
Visitare oggi l’aula bunker, accompagnati dal funzionario giudiziario Rosario Zarcone, significa entrare in un luogo che conserva una memoria fisica della lotta alla mafia. «Chi entra per la prima volta capisce subito che questa è una pietra miliare della lotta alla mafia», dice Zarcone. È qui che Tommaso Buscetta, il collaboratore di giustizia le cui rivelazioni resero possibile il processo, affrontò in un celebre confronto l’imputato Pippo Calò. Per Ayala fu un momento decisivo: «Dopo il primo confronto, tutti gli altri avvocati rinunciarono. Ho capito che il processo non si poteva perdere».
Il Maxi Processo fu anche un test umano. Ayala ricorda il giorno in cui concluse la requisitoria: «Ho parlato per otto giorni in piedi. Quando ho finito, l’adrenalina è svanita: non riuscivo più ad alzarmi». Due carabinieri lo aiutarono a uscire dall’aula, mentre l’aula si svuotava e gli imputati venivano riportati in carcere. «La paura l’abbiamo provata tutti. Il punto è non cedere alla paura».
La sentenza definitiva arrivò il 30 gennaio 1992 con la conferma della Cassazione: 19 ergastoli e più di duemila anni di carcere. Ma oltre ai numeri, ciò che resta è la conoscenza acquisita grazie ai collaboratori di giustizia e al lavoro del pool antimafia: «In quella sentenza c’è tutto quello che c’è da sapere sulla mafia», ricorda Ayala. Ancora oggi, mentre l’aula bunker attraversa una nuova fase di ristrutturazione, quel luogo continua a raccontare cosa accadde quando lo Stato decise davvero di esserci.

L’ora del giudizio
Laser 09.02.2026, 09:00
Contenuto audio