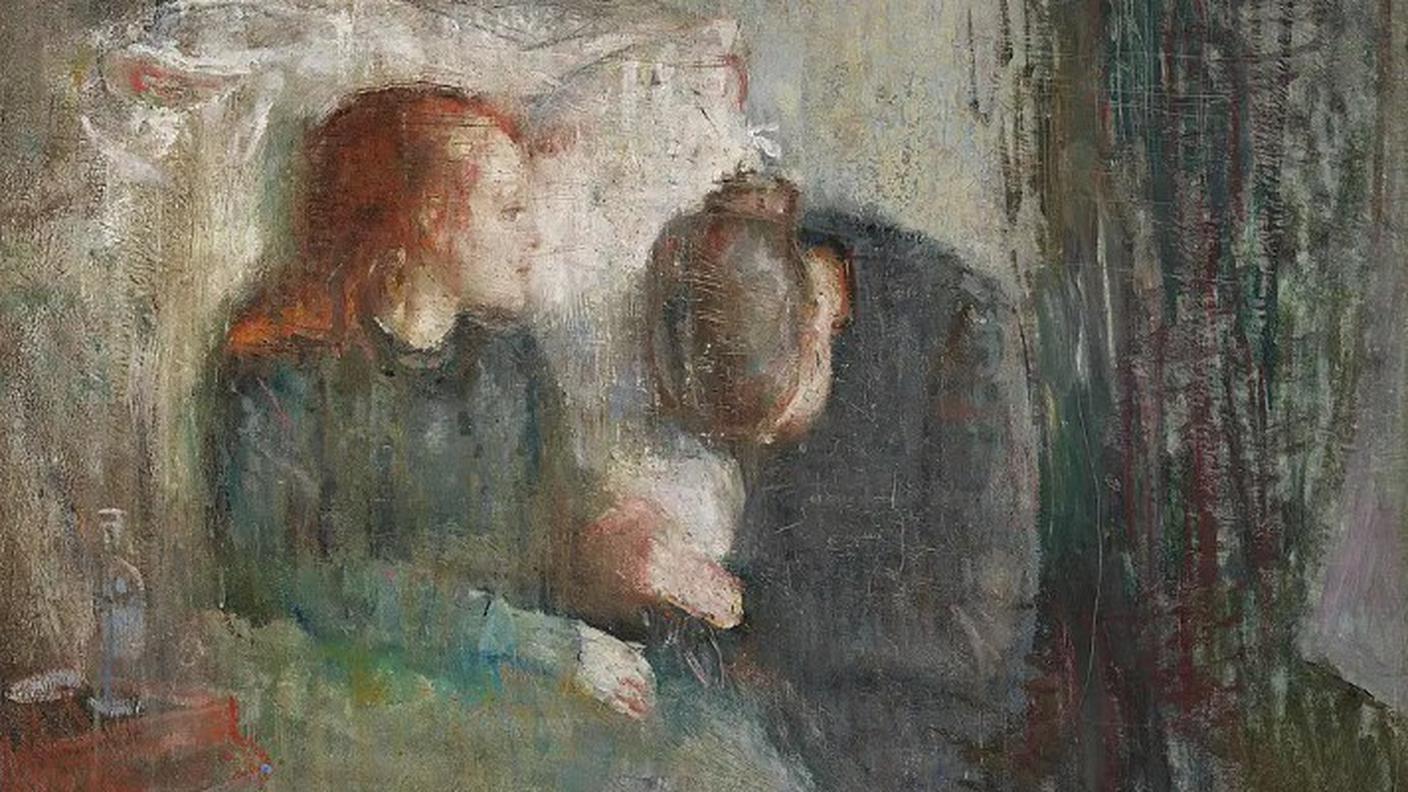La guerra civile in Sudan, in corso da quasi tre anni, ha precipitato il paese in una crisi umanitaria senza precedenti, definita da molte organizzazioni internazionali come la più grave al mondo. Il conflitto, esploso tra l’esercito regolare sudanese (SAF), guidato dal generale Abdel Fattah al‑Burhan, e le milizie paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF), un tempo alleate, ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione, sofferenza e sfollamenti di massa.
Le cifre sono drammatiche: si stimano 150.000 morti e oltre 10 milioni di sfollati, metà dei quali bambini. La fame è dilagante, gli stupri vengono usati come arma di guerra e la mancanza di cure mediche adeguate sta decimando la popolazione. Ospitato in Alphaville da Barbara Camplani e Cristina Artoni, Vittorio Oppizzi, responsabile dei programmi di Medici Senza Frontiere in Sudan, ha sottolineato come la guerra sia «dimenticata» e come non esista un conteggio accurato delle vittime, a differenza di altri conflitti. Oppizzi ha evidenziato che la linea del fronte resta attiva, con spostamenti quasi quotidiani, soprattutto negli Stati del Kordofan, una delle aree più trascurate del paese.
I mille giorni di guerra civile in Sudan
Alphaville 03.02.2026, 12:05
Contenuto audio
La crisi umanitaria è aggravata dalla scarsità di aiuti, in un paese che già prima della guerra dipendeva dall’assistenza internazionale. Le priorità, spiega Oppizzi, sono «sostenere gli sfollati nel Kordofan» — regione quasi irraggiungibile — e intervenire nel Darfur, dove il sistema sanitario è crollato e il rischio di epidemie cresce per la mancanza di vaccinazioni. Anche la sicurezza alimentare è in caduta libera: l’interruzione dei flussi commerciali sta facendo precipitare una situazione nutrizionale già fragile.
Il conflitto affonda le radici nel passato recente. Come ricorda Giorgio Musso, nel 2019 una rivoluzione civile rovesciò il trentennale regime di Omar al‑Bashir, ma i militari si impossessarono della transizione. SAF e RSF, nate come milizie parallele, sono poi entrate in collisione per il controllo del potere, dopo che l’esercito ha imposto alle RSF di integrarsi nei suoi ranghi, un’offerta «respinta». La guerra è esplosa nell’aprile 2023 a Khartoum, devastando la capitale e disgregando lo Stato.
Secondo Irene Panozzo, la riapertura dell’aeroporto di Khartoum da parte dell’esercito è un tentativo di mostrare «una parvenza di normalità» e accreditarsi come governo legittimo. Ma la linea del fronte continua a muoversi, soprattutto nel Kordofan. La popolazione vive in un’ambiguità dolorosa: nelle aree centrali l’arrivo delle SAF è percepito come liberazione dalle razzie delle RSF, mentre in parti del Darfur e del Kordofan le RSF restano radicate come potere locale.
Il motore economico della guerra è l’oro. Il Sudan è il terzo produttore africano e l’estrazione — spesso artigianale — alimenta un flusso verso il Golfo, soprattutto gli Emirati Arabi Uniti, dove il metallo viene «ripulito» prima di entrare nel mercato globale. Un circuito che trasforma il conflitto in un «investimento» per chi ne trae profitto.
Le prospettive restano cupe. Nessuna delle due parti vuole fermarsi e i negoziati sono falliti. La linea delle SAF è chiara: «non negoziare, dobbiamo vincere». Ma sul terreno domina un equilibrio instabile che rende improbabile una vittoria totale. Intanto la guerra si è regionalizzata: gli Emirati Arabi Uniti sostengono le RSF, mentre Egitto e Arabia Saudita appoggiano le SAF. Il timore crescente è che il Sudan possa seguire la traiettoria della Libia, divisa in due con governi ed eserciti paralleli.