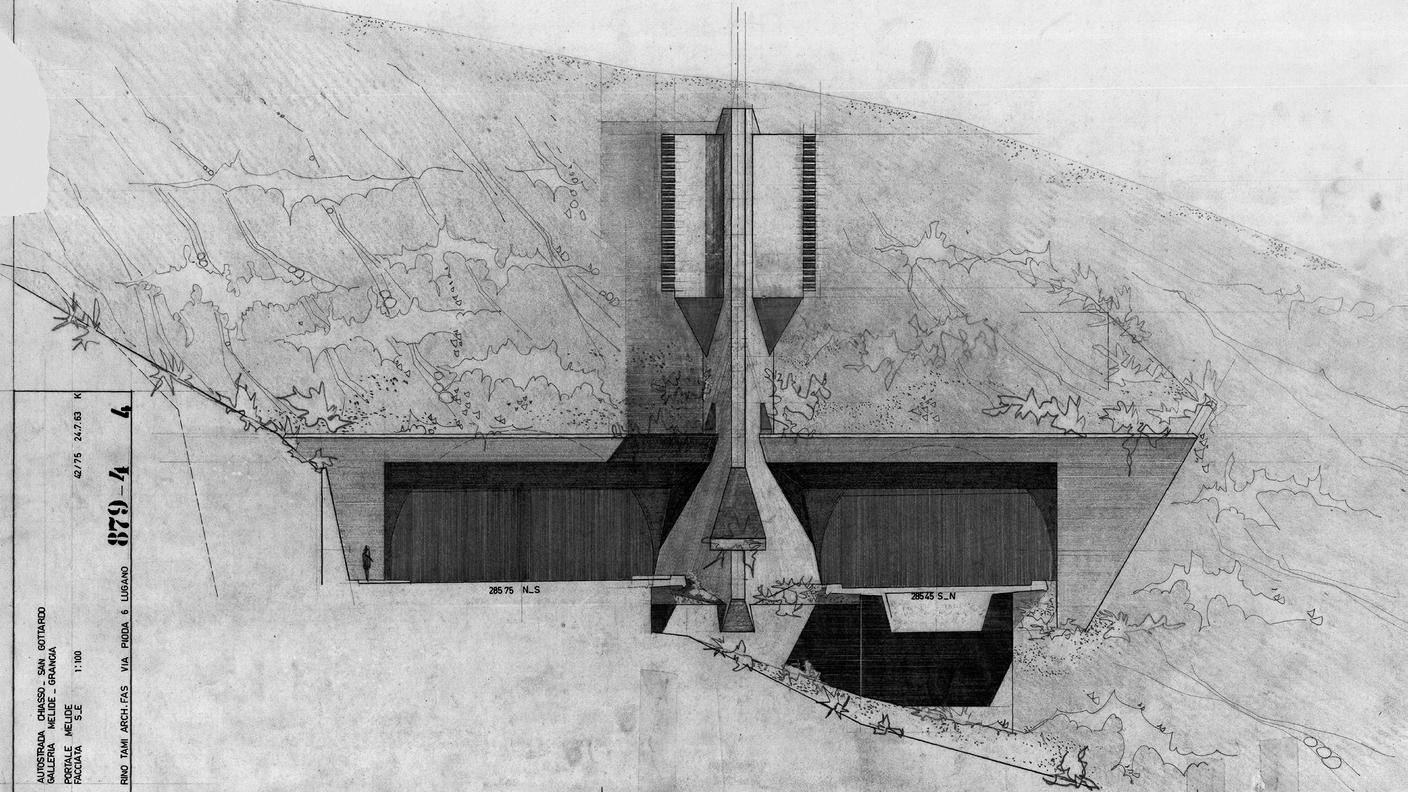Per la portata politica che assunse nel tempo, la battaglia del Morgarten rappresenta uno degli episodi fondanti della storia svizzera. Come ricorda Annina Michel nel volume La battaglia del Morgarten – Storia e mito (Edizioni ESG, 2014), gli scontri ebbero luogo il 15 novembre 1315 e costituirono l’apice di un più ampio conflitto sviluppatosi tra il 1310 e il 1320 (guerra del Morgarten).
Da quella data nacque anche la celebre “Lettera del Morgarten”, o “Patto di Brunnen”, firmata il 9 dicembre 1315 da Uri, Svitto e Untervaldo. Redatto in tedesco, fu il primo documento a utilizzare il termine “confederato” e sancì un’alleanza più strutturata rispetto a quella del 1291, come sottolineano Marco Jorio e Hans Stadler nel loro testo Difesa nazionale (DSS, 2008): un accordo che definiva i doveri di reciproca assistenza in caso di guerra e delineava persino elementi di politica estera comune.

La Battaglia di Morgarten
RSI Shared Content DME 09.11.2021, 15:02
Secondo la tradizione, lo scontro vide un piccolo esercito di fanti svittesi infliggere una schiacciante sconfitta alle truppe austriache del duca Leopoldo I d’Asburgo. Quest’ultimo, reduce da una campagna militare in Svevia, aveva radunato le proprie forze a Zugo prima di muovere verso Sattel attraverso la valle dell’Ägeri, diretto a Svitto (Guerra Morgarten, Josef Wiget, 02.12.2015). Gli Svittesi lo affrontarono nei pressi di Schornen, all’estremità superiore del lago, costringendo l’esercito nemico alla fuga dopo un breve ma violento combattimento.
Le fonti medievali non permettono di stabilire con precisione la dinamica dello scontro né il numero dei caduti: le cifre riportate, spesso esagerate, restano incerte. È tuttavia probabile che l’armata asburgica comprendesse cavalieri aristocratici e truppe a piedi provenienti dai territori di Argovia, Zurigo, Zugo e Lucerna, mentre i Paesi forestali – Uri, Svitto e Untervaldo ossia la Svizzera primitiva – disponevano di forze più ridotte ma meglio radicate nel territorio. Ciò che è certo è che le ostilità erano ufficialmente iniziate nel giugno 1310
Raffigurazione della battaglia del Morgarten (1315) dove i fanti svizzeri sconfissero la cavalleria austriaca.
Gli antecedenti di Morgarten affondano nelle tensioni politiche dell’epoca. A differenza degli Asburgo, il re Enrico VII di Lussemburgo aveva confermato ai Paesi forestali l’immediatezza imperiale, ossia la dipendenza diretta dal Sacro Romano Impero, esentandoli da qualsiasi dominio signorile. I tre cantoni furono così riuniti in un baliaggio imperiale affidato al conte Werner von Homberg. Questa decisione accese il risentimento asburgico e deteriorò i rapporti con Svitto.
Lo storico Josef Wiget individua tre livelli di conflitto che portarono allo scontro: di trono, di marca e nobiliare. Il primo nacque dal caos seguito alla morte di Enrico VII: i principi elettori non trovarono un accordo e nominarono due re, Ludovico il Bavaro e Federico I d’Asburgo (detto “il Bello”, fratello del duca Leopoldo I). Gli Svittesi appoggiarono Ludovico, sperando di veder confermate le “libertà” del 1240, e furono premiati nel 1316 con la ratifica della loro autonomia interna.
Il secondo, il conflitto di marca, riguardava i contrasti territoriali con il convento di Einsiedeln. All’inizio del Trecento, il monastero aveva convertito le proprie terre all’allevamento di grosso bestiame, minacciando l’economia dei piccoli contadini svittesi. Le tensioni culminarono il 6 gennaio 1314 con l’assalto al convento, descritto nel poema Cappella Heremitana di Rudolf von Radegg – insegnante presso la scuola monastica e testimone oculare – come un episodio di brutale violenza (ed. e trad. P. J. Brändli, 1975).
Il terzo conflitto, di natura nobiliare, oppose il duca Leopoldo I che deteneva i diritti di avogadria ecclesiastica sul convento, al balivo imperiale Werner von Homberg, deciso a consolidare la propria influenza sui baliaggi della regione. La battaglia del Morgarten può dunque essere letta anche come una faida aristocratica per il controllo politico ed economico della Svizzera interna.
Dopo l’attacco al monastero, gli Asburgo cercarono di riaffermare la loro autorità marciando lungo la valle dell’Ägeri, ma trovarono la resistenza decisa dei Paesi forestali, schierati con Ludovico il Bavaro e colpiti dal Bando Imperiale di Federico il Bello. La mattina del 15 novembre 1315, Leopoldo radunò le sue truppe nella cittadina asburgica di Zugo e marciò verso Sattel attraversando la valle; gli Svittesi reagirono con decisione, attaccando l’esercito in movimento nella zona di Schornen, all’estremità superiore del lago di Ägeri, e costringendolo alla fuga dopo un breve ma sanguinoso scontro.
Murale raffigurante la battaglia del Morgarten sulla facciata del municipio di Svitto.
Come ricorda ancora Wiget, Morgarten fu la prima battaglia per l’indipendenza combattuta dalla Confederazione, poiché anche se non pose fine ai contrasti, rafforzò l’alleanza tra i tre cantoni (La guerra del Morgarten, J.Widget, 02.12.2015). Il nuovo patto stipulato a Brunnen nel dicembre 1315 consolidò infatti una politica comune che avrebbe influenzato per secoli la storia elvetica. La “Lettera del Morgarten” divenne così simbolo di libertà, virtù e coesione, e fu identificato dalle cronache come l’atto di fondazione della Confederazione elvetica fino alla fine del XIX secolo. Un accordo che ancora oggi è custodito al Museo dei Patti Federali di Svitto, rimanendo una delle testimonianze più alte dell’identità svizzera.
Cappella del Morgarten
Fino al Novecento, il ricordo della guerra del Morgarten si custodì soprattutto in piccole feste locali nei cantoni di Svitto, Zugo e Uri. Dal tardo Medioevo la memoria si espresse poi soprattutto in riti religiosi locali, ai quali con il tempo si affiancò una cultura laica del ricordo: furono istituiti giorni e cerimonie commemorative, fu eretto un monumento sul Buchwäldli di Oberägeri nel 1908 e prese avvio il tiro del Morgarten nel 1912. La celebrazione di maggior rilievo, e anche di maggiore impegno economico, si tenne per la prima volta nel 1939 e si ripeté periodicamente nei decenni successivi. Ancora oggi, a Schornen — luogo della cappella che marca la memoria — si tiene ogni anno una manifestazione sostenuta dal comune di Sattel, dal relativo distretto e dal cantone di Svitto, con la collaborazione del Canton Zugo.
L’importanza simbolica della battaglia ha tuttavia alimentato anche controversie locali. A partire dal dibattito sulla localizzazione precisa dello scontro si è instaurata una lunga disputa tra Zugo e Svitto, che ha provocato malumori soprattutto fra gli abitanti di Oberägeri (Cantone Zugo) e di Sattel (Cantone Svitto) al momento di decidere dove posare il monumento commemorativo. Le fonti attestano che lo scontro ebbe luogo nei pressi di Sattel e che la cosiddetta Letzi — la fortificazione in muratura menzionata già nel 1322, eretta per impedire al nemico di penetrare nella valle — corre su una dorsale rocciosa che attraversa la valle. La sua torre fu collocata nel punto più basso, nei territori di Schornen (frazione di Sattel), ma si trova comunque all’ingresso sudorientale della valle di Ägeri, lato oggi attribuito al Canton Zugo. Di conseguenza, entrambe le comunità rivendicano la paternità del luogo: una contesa priva, sinora, di una soluzione definitiva.
Vista sulla fortificazione (Letzi) del Morgarten.
È invece indubbio il valore paesaggistico e storico dell’area: oggi la valle è tra le meglio conservate del Cantone Svitto, dominata da verdi prati, affacciata sul lago e costellata da fattorie di notevole qualità architettonica risalenti al Settecento. Il luogo, epico sin dal Trecento, resta avvolto in una nebbiosa zona di confine tra storia e leggenda.
La battaglia del Morgarten è così diventata un racconto fondativo, intriso di simboli di libertà e resistenza all’oppressione asburgica. La memoria popolare ha trasformato poi gli eventi in racconti vividi: nella valle di Ägeri i bambini, ancora oggi, ascoltano aneddoti sui cavalieri morti che infesterebbero questi luoghi; si narra che, nella notte dell’anniversario, il lago si tinga di rosso e che l’armata dei cavalieri asburgici sorga dalle acque per vendicarsi. Queste storie, fra mito e folklore, testimoniano la vitalità di una memoria collettiva che ha plasmato l’identità del territorio.
Gli Svizzeri: Werner Stauffacher e la battaglia del Morgarten
RSI Notrehistoire 03.11.2013, 00:00