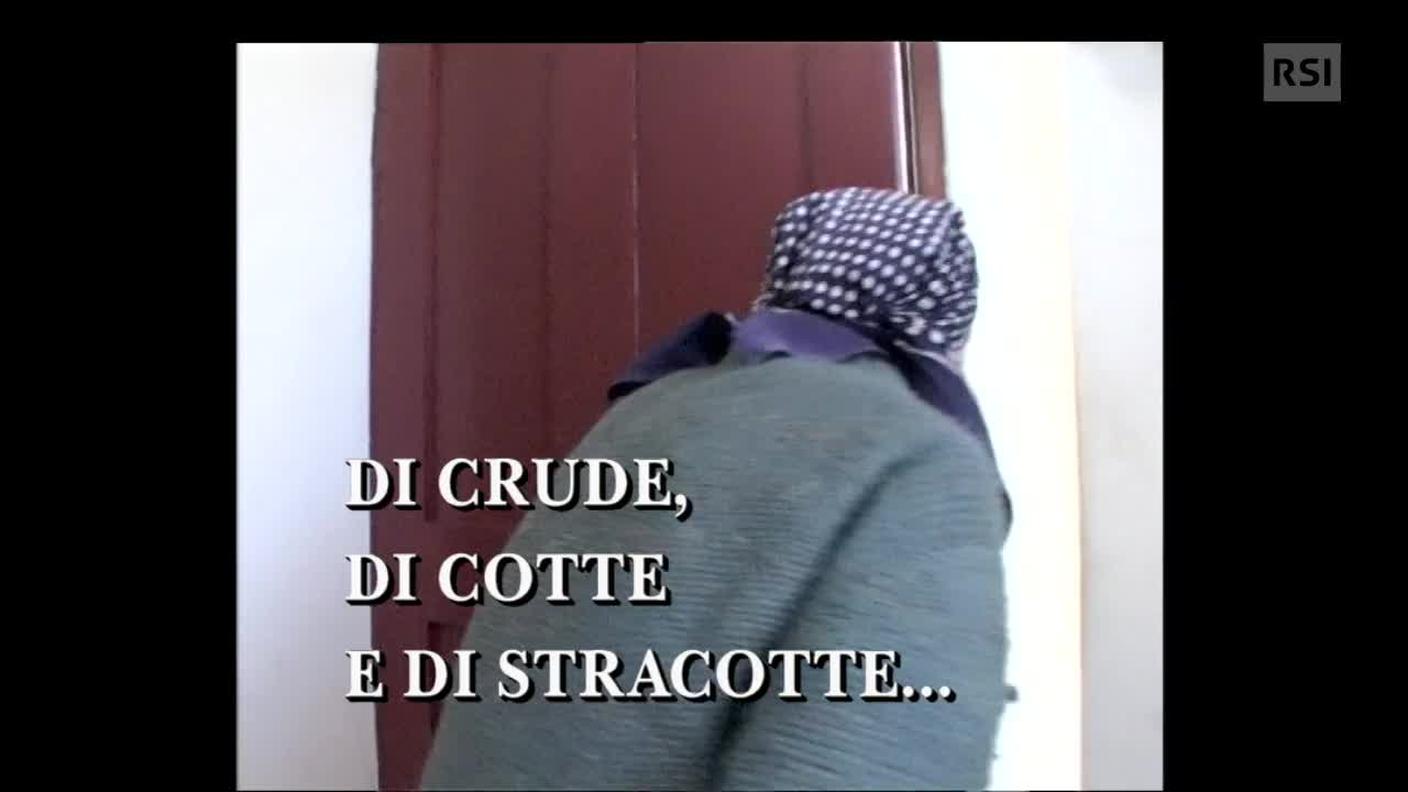La globalizzazione è un fenomeno ormai universale, che risale secondo alcuni storici addirittura alla scoperta dell’America, e che negli ultimi decenni ha subito un’accelerazione fortissima, portando in Occidente più inquietudine che speranza. Inquietudine per i posti di lavoro, per la deindustrializzazione, ma anche per questioni identitarie. È un tema scivoloso, che riguarda naturalmente anche la politica.
Un luogo dove spesso, anche a nostra insaputa, la globalizzazione è da sempre una realtà – nonostante il fatto che noi regolarmente pensiamo che lì si custodisca invece la nostra identità, appunto – è il piatto.
Globalizzazione culinaria
Kappa e Spalla 31.10.2025, 17:35
Contenuto audio
È appena uscito nelle librerie francesi un saggio scritto da una settantina di storici, dal titolo significativo: L’Épicerie du Monde. Épicerie che in italiano è la drogheria, il negozio di alimentari, dove un tempo si vendevano anche le spezie all’ingrosso: ecco che, seguendo la storia della lingua, si arriva all’origine della globalizzazione alimentare.
Il libro si apre con una citazione di Honoré de Balzac, che già a metà ‘800 aveva definito l’épicier, cioè il droghiere, «ministro dell’Africa, delle Indie e dell’America». È una definizione molto azzeccata, perché afferma che il negozio di alimentari è una sorta di “negozio del mondo”.
Identità locale e cibo internazionale si rincorrono da sempre: ogni popolo si identifica con un cibo, con diversi cibi, lo considera suo, ma l’identità del cibo è in realtà quasi sempre cosmopolita, risultato di contaminazione, di incontri, di modifiche. Il cibo non ha mai smesso di viaggiare nel mondo, e i percorsi che ha seguito, ricostruiti dagli storici, spesso sono sorprendenti.
Il curry è indiano o inglese?
Ad esempio, il curry, di cui da un paio di secoli si dibatte sull’origine: indiana o inglese?
È un tema che risale, secondo gli storici, al 1747, quando una cuoca inglese, Anna Glass, scrisse un libro di ricette in cui figurava il “Curry all’indiana”. Ma già nel XV secolo i portoghesi parlavano di una salsa dal nome simile, originaria della regione del Tamil Nadu, dunque nel sud dell’India. Però in inglese, nel vecchio inglese, sappiamo che curry significa semplicemente cuocere, dal francese cuire. Quindi, già la filologia complica le cose. E ancora: il peperoncino è spesso tra gli ingredienti del più noti del curry, ma viene dall’America, dunque è molto tardivo. È stato portato in India dall’impero Mughal, di matrice turco-mongola. Un’altra influenza.
Oggi il curry è un prodotto globalizzato: chi è stato a Berlino, sa che uno dei cibi più berlinesi al mondo è il currywurst. Intanto, gli inglesi pensano che sia indiano, mentre gli indiani, che sia un retaggio inglese: a Calcutta, durante il festival culinario annuale Taste of Britain, il curry è stato presentato come uno dei 50 piatti-simbolo britannici. Quindi?
Il kebab è turco, greco o libanese?
Pensiamo ora al kebab. Gli storici hanno trovato la prima fotografia conosciuta di un doner (in turco, “girare”) kebab: risale al 1855, durante l’Impero ottomano. Ma troviamo la stessa pietanza nel mondo arabo col nome di shawarma, e poi in Grecia, naturalmente, dove viene chiamato gyros. La prima testimonianza conosciuta della presenza del kebab risale al 1666: un testo scritto da un viaggiatore in Crimea, che descrive un kebab orizzontale.
Il doner kebab arriva in Europa come gyros all’inizio del Novecento, subito dopo la Prima guerra mondiale, portato in Francia dai greci dell’Anatolia cacciati dai turchi. Inizialmente dunque era percepito come un prodotto greco, però poi i turchi si sono ripresi la paternità del kebab, a partire dalla Germania degli anni Settanta. Ma se spostiamo lo sguardo verso l’America Latina, quello che noi conosciamo come doner kebab ha ovunque il nome arabo di shawarma, ed è considerato un prodotto libanese, non turco. Anche qui, è complicato arrivare a una soluzione definitiva.
Lo yogurt: dalla Cina alla Francia, e poi al mondo
Un esempio di prodotto davvero globale è infine lo yogurt: risale a Stamen Grigorov, medico bulgaro che all’inizio del ‘900 presenta all’Institut Pasteur di Parigi la sua scoperta: il fermento lattico che dà acidità trasformando lo zucchero del latte, cioè il lattosio, in acido lattico. A livello artigianale lo yogurt era già molto diffuso in Bulgaria e l’Istituto Pasteur aveva notato che c’era un legame tra la longevità della popolazione – dunque, la speranza di vita – e il consumo di yogurt. Il Lactobacillus bulgaricus – così fu chiamato – si dimostrò molto efficace anche per la regolazione intestinale, in particolare dei bambini, e Grigorov fu insignito del Nobel per la sua scoperta.
Però il latte fermentato aveva già una lunga tradizione, ce ne sono tracce in Cina già nel VI secolo prima di Cristo. Il termine yogurt invece è verosimilmente di origine turca. La moderna globalizzazione dello yogurt come prodotto è invece legata a Isaac Carasso, imprenditore ebreo di Salonicco, che a inizio ‘900 comincia a produrre lo yogurt, dapprima vendendolo in farmacia, poi creando una sua azienda, che chiama con il nomignolo che usava per il figlio Daniel: Danòn. Oggi Danone è un’azienda multinazionale presente in 120 Paesi, e produce circa 51 miliardi di vasetti di yogurt ogni anno.
Dunque, è molto interessante riflettere sul contrasto tra aspetto identitario e aspetto globale del cibo, che spesso tracima nella politica. La nostra fondue, noi pensiamo che sia svizzera, mentre i francesi pensano che sia savoiarda. La pasta cinese è diventata un marchio identitario italiano, anche se pare fu portata in Italia solo nel XIII secolo.
In fondo il cibo è un po’ come noi esseri umani: come genetica e come cultura siamo tutti risultato della storia, delle migrazioni, degli incontri di persone, popoli, viaggi.
https://www.rsi.ch/s/3062516