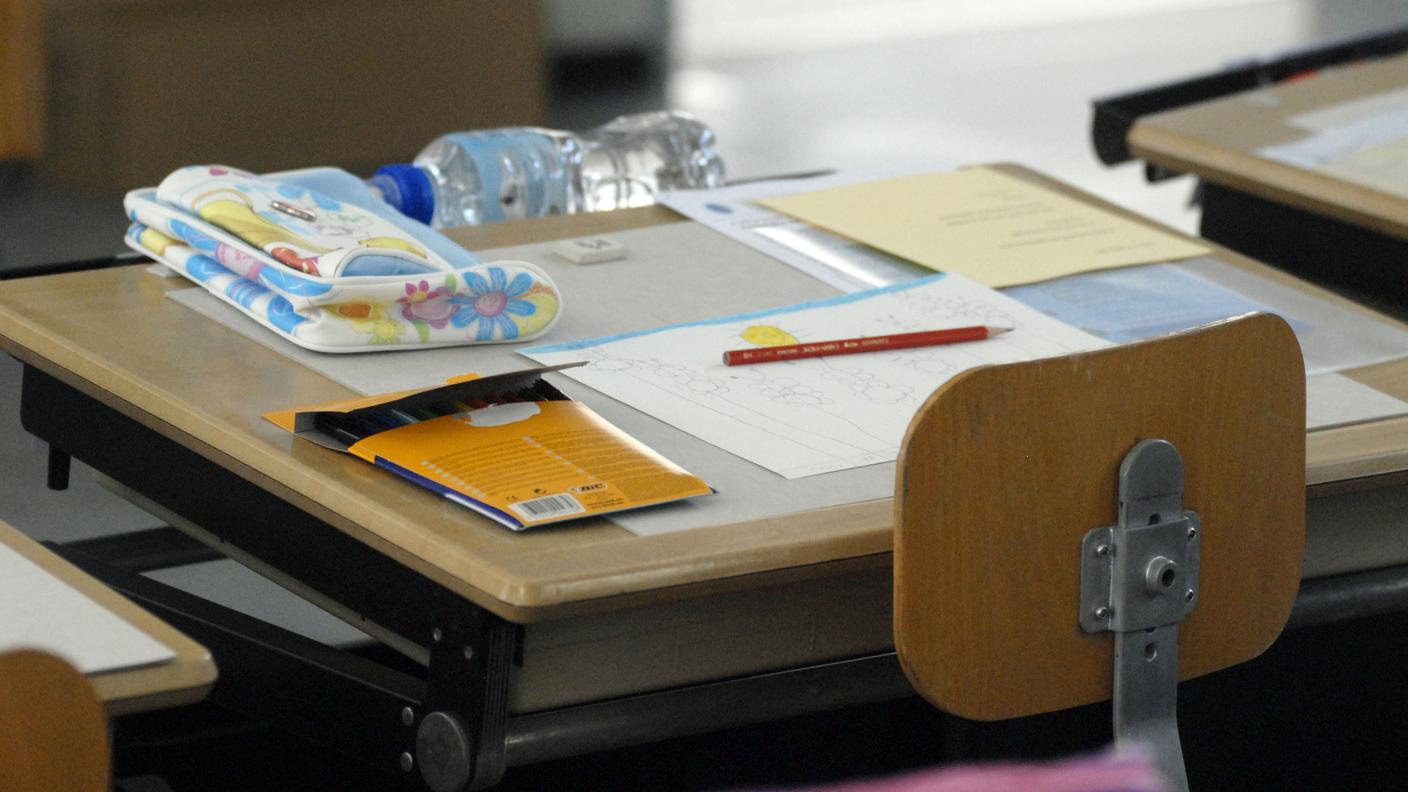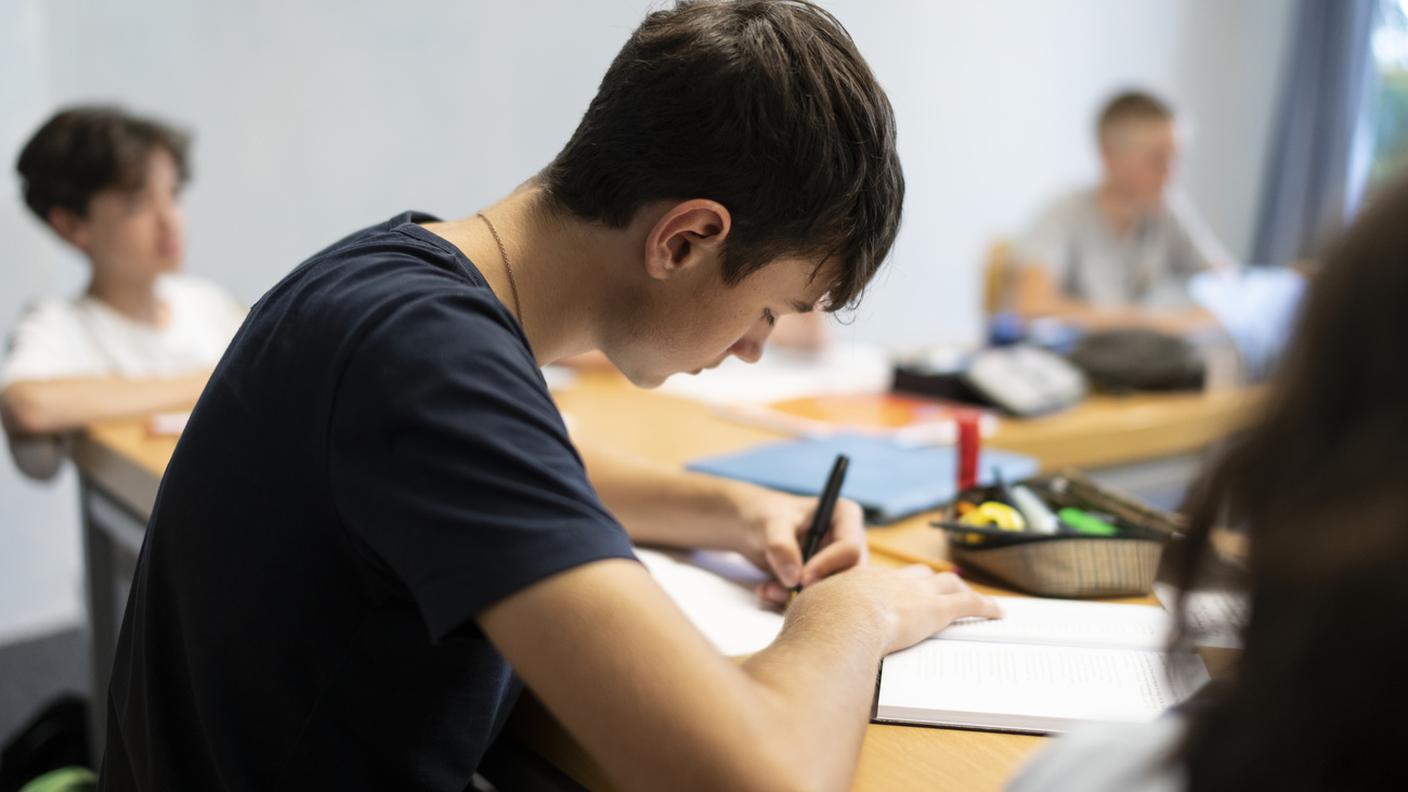Era il 1975 quando, in un’epoca di profondi cambiamenti sociali e culturali, nasceva in Ticino un nuovo modello di educazione speciale destinato a lasciare un’impronta indelebile nel panorama educativo dell’intera regione. Quest’anno, quel modello che ha portato alla nascita della Scuola speciale ticinese, festeggia il suo 50° anniversario, un traguardo che invita a riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. Sostenuta da iniziative associative private, la nuova visione dell’educazione speciale in Ticino in quegli anni pose al centro i concetti di inclusione e integrazione. Il primo regolamento per l’educazione speciale segnò l’inizio di un’era in cui l’attenzione si spostava verso un approccio più inclusivo, ma anche più personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali.
Per comprendere meglio l’evoluzione di questo modello pionieristico e il suo impatto nel corso degli anni, la trasmissione SEIDISERA ha incontrato due figure chiave di questo percorso: Mattia Mengoni, attuale capo della sezione della pedagogia speciale, e Mauro Martinoni, psicologo e pedagogista, primo capo dell’Ufficio dell’educazione speciale e tra i fondatori di Atgabbes, l’associazione ticinese Genitori e Amici di bambini bisognosi di educazione speciale.
Un nome che ha segnato un cammino
Mauro Martinoni ricorda quei giorni iniziali, di costruzione del progetto come un periodo di “grandi entusiasmi”, a partire dalla scelta del nome che avrebbe identificato un cammino lungo 50 anni. Il nome scelto era “bisognosi di educazione speciale”. “Ricordo - spiega a SEIDISERA Martinoni -, che la legge federale a quel tempo parlava ancora di invalidi, distinguendoli in invalidi scolarizzabili, i bambini, e invalidi inetti. Per cui parlare di bisognosi di educazione era un tentativo di dire ‘sono bambini come gli altri che hanno qualche bisogno in più’”. Lo stesso fondatore spiega alla RSI che senza il supporto di Atgabbes, dunque, senza la spinta delle associazioni private, non si sarebbe arrivati ad un risultato del genere.
Per quanto riguarda la spinta del modello Basaglia nel campo educativo, questa, precisa, è arrivata più tardi. “Storicamente Basaglia ha avuto il primo impatto col disturbo psichico grave, riprende, coi malati gravi, mentre le prime inclusioni dirette nelle scuole normali in Italia, nelle visite che ho fatto a Bologna, a Milano per esempio, purtroppo non erano sufficientemente preparate. Spesso veniva inserito il bambino con anche disabilità di una certa importanza, senza che la scuola fosse pronta ad accoglierlo. Però sicuramente questi due impulsi sono stati importanti. Ecco, tra Nord Italia e Svizzera non c’era nessuna differenza: l’Istituto era la soluzione normale”.
Classi inclusive e istituti specializzati: il doppio binario del Ticino
Due impulsi importanti, dunque, che hanno portato ad una concezione ticinese che si è un po’ allontanata da quella più in auge nella Svizzera tedesca, maggiormente legata proprio a un modello separativo. Mengoni ha spiegato cosa è rimasto oggi di quell’idea originaria a 50 anni di distanza, di quel famoso regolamento da cui poi tutto è partito.
“Rimane parecchio - argomenta l’attuale capo della sezione della pedagogia speciale -. Anche perché quel regolamento ai nostri occhi è stato abbastanza lungimirante. Noi lavoriamo oggi ancora su quei principi, con una scuola speciale che si articola all’interno della scuola regolare; quindi, con delle classi che sono ubicate negli istituti scolastici - siano essi comunali o cantonali - con delle offerte di scuole speciali che proprio si rivolgono e si sviluppano in questi contesti. Pensiamo alle nostre classi inclusive, oppure alle classi a effettivo ridotto. Abbiamo anche la realtà istituzionale perché il nostro modello pensa e crede fortemente che per alcune alunne e alunni, una risposta più mirata e protetta sia ancora necessaria. Ed è per questo che la collaborazione con gli istituti che già lavoravano negli anni ’70, e che hanno lavorato prima del regolamento della scuola speciale, continua. Abbiamo ancora oggi quattro istituti per minorenni nel Cantone con i quali collaboriamo e al quale indirizziamo le alunne e gli alunni che hanno dei bisogni specifici più importanti”.

50 anni di Scuola Speciale
Prima Ora 16.09.2025, 18:00
Numeri che raccontano un grande lavoro
Il sistema scolastico ticinese presenta una notevole variabilità nell’applicazione del modello inclusivo tra i diversi ordini scolastici. Nella scuola dell’infanzia, l’approccio inclusivo trova terreno importante: ben 130 alunni frequentano sezioni inclusive, mentre 26 sono inseriti in classi a effettivo ridotto. Questo evidenzia come l’ambiente della scuola dell’infanzia si presti particolarmente all’inclusione. La situazione si equilibra nella scuola elementare, dove 114 alunni sono in contesti inclusivi contro 160 in classi a effettivo ridotto. Questo bilanciamento suggerisce una maggiore diversificazione delle esigenze educative in questa fascia d’età. La scuola media presenta una realtà più complessa. L’implementazione di classi inclusive risulta più articolata rispetto alle scuole comunali, con 55 alunni in percorsi inclusivi e 200 in classi a effettivo ridotto. Nel post-obbligo, rappresentato dai cicli di orientamento, non sono previsti percorsi inclusivi. Questo settore accoglie circa un centinaio di alunni, evidenziando un approccio diverso per gli studenti più grandi.
Oltre i costi: l’importanza strategica della pedagogia specializzata in Ticino
Il capo della sezione della pedagogia speciale Mattia Mengoni riconosce le preoccupazioni relative ai costi generati nell’ambito della pedagogia specializzata. Tuttavia, sottolinea l’importanza di comprendere e affrontare queste sfide con l’attuale richiesta di risposte più articolate da parte della scuola, in particolare per far fronte alle crescenti fragilità degli alunni, spesso legate a situazioni familiari complesse. Lo sviluppo della scuola speciale, secondo Mengoni, ha portato a una collaborazione sempre più stretta con la scuola regolare, in linea con le aspirazioni del primo regolamento. Nonostante le preoccupazioni finanziarie, lo stesso ritiene che sia assolutamente necessario investire in questo ambito, considerando le esigenze emergenti degli studenti e l’importanza di fornire risposte adeguate alle loro necessità educative.
Le due sfide della pedagogia speciale, dall’esperienza passata alla distinzione pratica
La sfida principale per il futuro della pedagogia specializzata è quella di capitalizzare l’esperienza accumulata negli ultimi 50 anni, focalizzandosi su una popolazione potenzialmente a rischio, ovvero gli alunni con bisogni educativi particolari. L’obiettivo è tradurre queste esperienze in una didattica inclusiva che si rivolga a tutti gli studenti, considerando le diverse necessità individuali.
Mengoni sottolinea l’importanza di non limitarsi a un approccio “per difetto”, concentrandosi solo sugli alunni con difficoltà, ma di considerare anche le esigenze di coloro che presentano forti sensibilità o un funzionamento cognitivo molto elevato. “Una vera didattica inclusiva - dice - deve essere in grado di fornire risposte adeguate a tutti gli studenti”.
Vi è poi una sfida più “interna”, come ha riferito il fondatore di questo pensiero. Martinoni solleva infatti una questione fondamentale nel campo della pedagogia speciale: la distinzione tra disfunzione, disabilità e handicap. Utilizzando un esempio personale, ha illustrato come una disabilità visiva e motoria non necessariamente si traduca in un handicap in tutti i contesti. Sottolinea l’importanza di valutare attentamente quando una disabilità impatti significativamente sulla vita di una persona, richiedendo quindi un supporto specifico.
50 anni di scuola speciale in Ticino
Millevoci 16.09.2025, 10:05
Contenuto audio