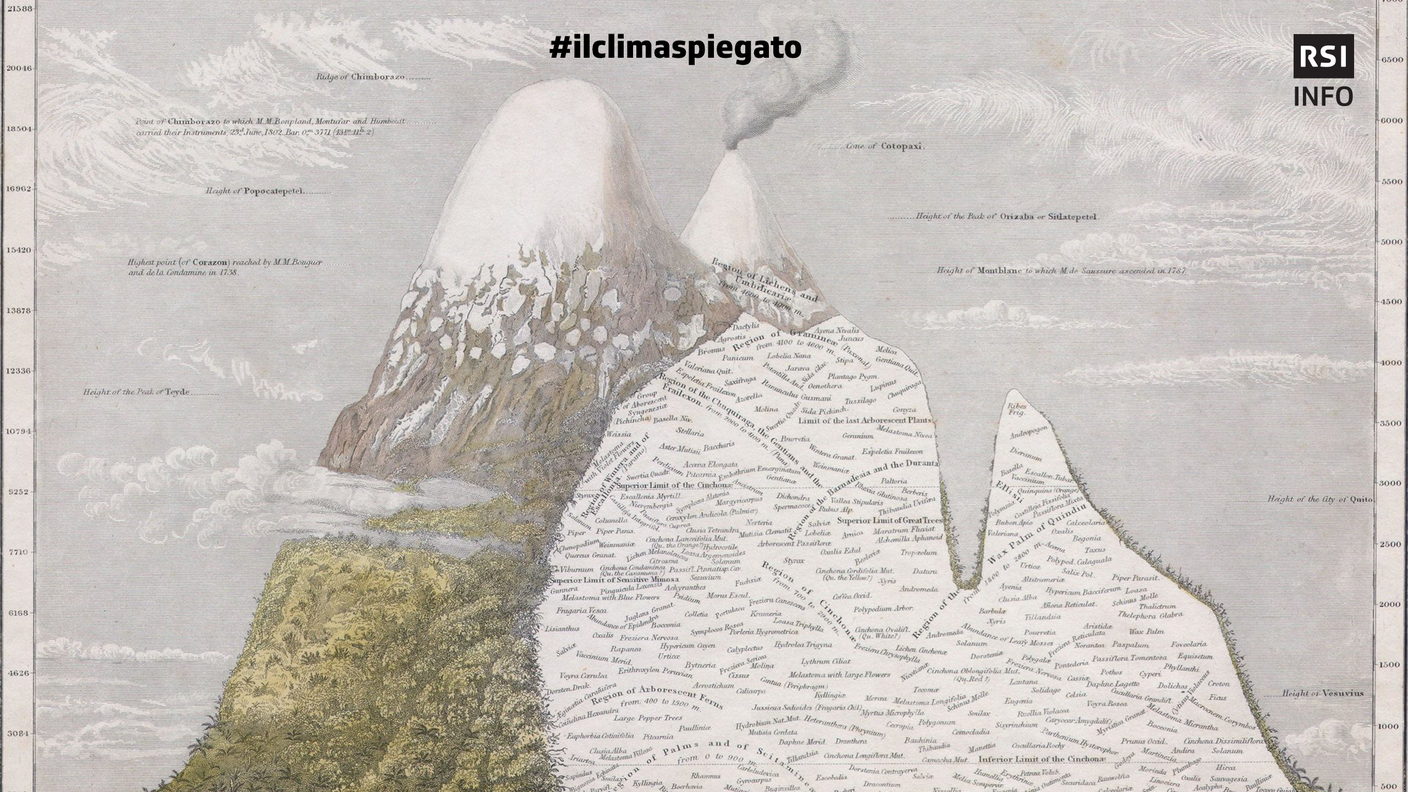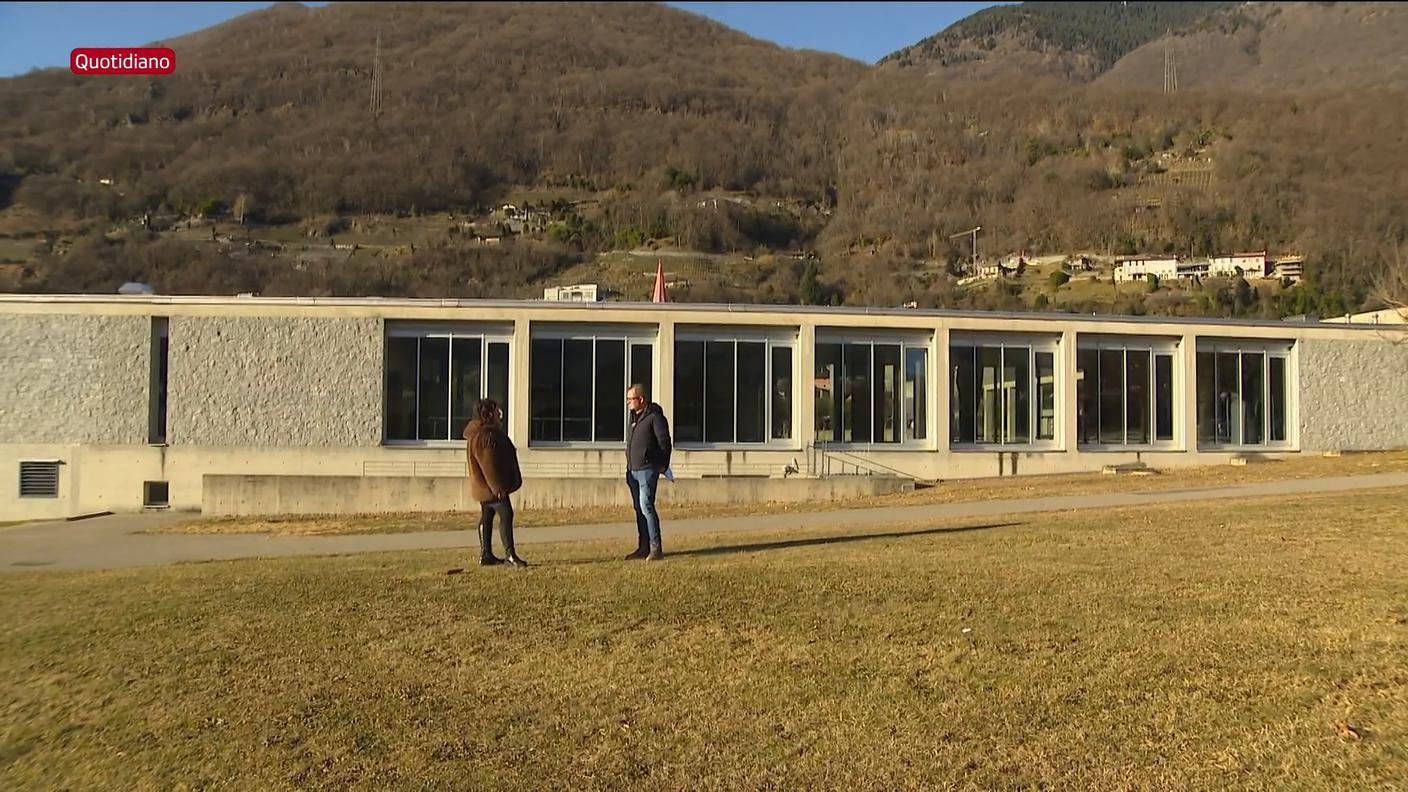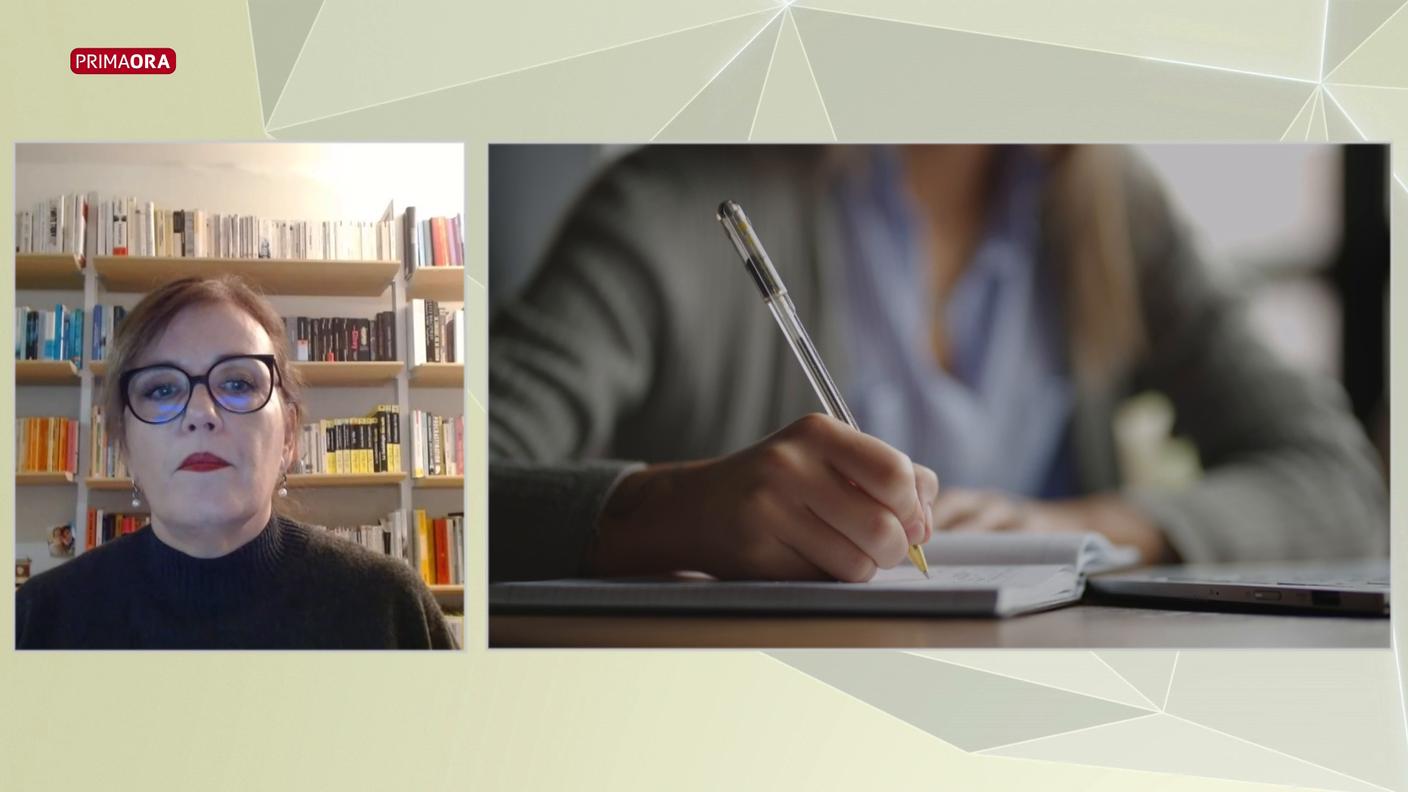I laghetti alpini ticinesi stanno lentamente recuperando dall’acidificazione, ma il processo è ancora incompleto e complicato dal cambiamento climatico. È quanto emerge dall’ultimo rapporto biennale del programma ICP Waters (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of the Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes), che da oltre 40 anni monitora l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulle acque superficiali. Il centro di coordinamento è situato in Norvegia e il Ticino rappresenta la Svizzera nel programma dal 2000.
Sandra Steingruber, collaboratrice scientifica della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Canton Ticino, spiega che il programma, istituito nell’ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza delle Nazioni Unite, è gestito in Svizzera dal Cantone per conto dell’Ufficio federale dell’ambiente. “Dal 2000 vengono monitorati sistematicamente venti laghetti alpini, un’attività avviata in realtà già negli anni ‘80 - seppur in maniera più sporadica -quando l’acidificazione delle acque superficiali aveva raggiunto il suo picco”, afferma Steingruber. Era infatti l’epoca delle cosiddette piogge acide.

L'interno dell'elicottero con i campioni delle acque prelevati
Oltre ai 20 laghetti alpini la chimica delle acque è poi anche monitorata nel fiume Verzasca e in altri sette siti di deposizione umida (6 nel Sopraceneri, uno nel Sottoceneri). Noi ci concentreremo però sui laghetti che, a causa delle loro piccole dimensioni, i laghetti sono molto suscettibili ai cambiamenti e perciò sono ottimali per raccogliere dati in ambito di monitoraggio ambientale.
L’area di studio nel nord-ovest del Ticino è particolarmente vulnerabile per due ragioni principali: “La regione è caratterizzata da rocce povere di carbonati, quindi con una limitata capacità tampone contro le deposizioni acide”, spiega Steingruber. “Inoltre, le abbondanti precipitazioni provenienti dal Mediterraneo si arricchiscono di inquinanti passando sulla Pianura Padana, soprattutto ossidi di azoto e ammoniaca, prima di riversarsi sul versante sud delle Alpi”. La fascia nordoccidentale del Ticino è infatti tra le regioni svizzere che registrano i quantitativi medi di precipitazioni più alti.
Il successo e l’importanza degli accordi internazionali
Il rapporto evidenzia alcuni successi significativi: “La riduzione delle emissioni di zolfo e azoto ha portato alla diminuzione delle concentrazioni di solfati e nitrati e un aumento dell’alcalinità nella maggior parte dei laghi, che risultano quindi meno acidi “, afferma Steingruber. Questo miglioramento è il risultato diretto di politiche ambientali efficaci, come l’uso di combustibili privi di zolfo e l’introduzione di catalizzatori e filtri sui veicoli, che hanno ridotto significativamente le emissioni inquinanti. “Oggi la maggior parte dei laghi presenta un pH considerato sicuro per gli organismi più sensibili”.
Le analisi dei trend dei principali parametri coinvolti nel processo di acidificazione evidenziano una significativa diminuzione delle concentrazioni di solfato nella maggior parte dei laghetti, (15 su 20) e di nitrato (20 su 20) e un significativo aumento dell’alcalinità totale (19 su 20) e del pH (18 su 20) .I 20 laghetti analizzati sono: Lago del Starlaresc da Sgiof; Lago di Tomè; Lago dei Porchieirsc; Lago Barone; Laghetto Gardiscio; Lago della Capannina Leit; Lago di Morghirolo; Lago di Mognòla; Laghetto Inferiore (Sassolo); Laghetto Superiore; Lago Nero; Lago della Froda; Laghetto d’Antabia; Lago della Crosa; Lago d’Orsalìa; Schwarzsee; Lago dei Pozzöi; Lago di Sfille; Lago di Sascòla; Lago d’Alzasca.
Un aumento di solfati, ma accompagnato da un aumento anche di cationi basici (elementi che favoriscono l’alcalinità), è stato osservato nei laghi: Porchieirsc, Leit, Morghirolo, Mognola e Nero. Ad eccezione di quest’ultimo, gli altri quattro subiscono tutti gli effetti dello scioglimento di ghiacciai rocciosi. I laghi considerati più acidi sono Starlaresc da Sgiof, Tomè e Gardiscio. Il monitoraggio biologico si era finora concentrato sui primi due laghetti.
“Nessun chiaro segnale di ripresa biologica”
Tuttavia, il quadro è più complesso per quanto riguarda proprio il recupero biologico. “Non abbiamo osservato chiari segnali di ripresa nella fauna di macroinvertebrati”, spiega Steingruber. Le ragioni potrebbero essere molteplici: il recupero potrebbe essere avvenuto prima dell’inizio del monitoraggio biologico nel 2000, le specie monitorate potrebbero non essere particolarmente sensibili all’acidificazione, o gli effetti del cambiamento climatico potrebbero mascherare i segnali di recupero. Inoltre, dato l’isolamento di questi ecosistemi alpini, le specie estinte potrebbero avere difficoltà a ricolonizzare l’area.

Il Lago di Tomè - uno dei più acidi - durante un sorvolo di una campagna di analisi passata
Il cambiamento climatico sta infatti complicando ulteriormente il quadro. Steingruber evidenzia diversi effetti: “Lo scioglimento dei ghiacciai rocciosi sta alterando la composizione chimica delle acque, aumentando le concentrazioni di minerali e potenzialmente di metalli pesanti, questi ultimi sicuramente più preoccupanti. L’innalzamento delle temperature sta anche modificando i cicli idrologici e delle precipitazioni, andando a influire sulla composizione della flora e fauna nei bacini imbriferi dei laghetti. Dinamiche che possono generare possibili effetti indiretti sulle concentrazioni di azoto nei laghi.”
Il nemico rimasto, l’azoto, e i tagli federali
Nonostante i miglioramenti, è comunque improbabile un ritorno completo alle condizioni pre-acidificazione. “Le deposizioni di azoto superano ancora significativamente i carichi critici”, sottolinea Steingruber. “Il recupero completo è quindi strettamente legato alla volontà globale di ridurre ulteriormente le emissioni di azoto.”

In volo sopra Robiei, nell'angolo in basso a destra si intravvede il Lago Nero, oggetto di campionamento
Al problema delle emissioni di azoto, se ne aggiunge anche uno di ordine pratico: a causa dei tagli della Confederazione per il periodo 2025-2029, è stato interrotto il monitoraggio biologico e dimezzato il numero di laghi sotto osservazione, che saranno quindi 10. “Il futuro dipende dall’intenzione dell’UFAM di proseguire con il finanziamento del progetto”, spiega Steingruber. “Abbiamo cercato di mantenere gli aspetti più informativi del monitoraggio, concentrandoci sui laghi meno influenzati dal cambiamento climatico e quindi più sensibili ai cambiamenti negli inquinanti atmosferici.”
Nonostante le sfide, il programma ICP Waters rimane uno strumento fondamentale per valutare l’efficacia delle politiche ambientali internazionali e per comprendere le complesse dinamiche che influenzano gli ecosistemi alpini.
Per chi volesse approfondire maggiormente l’argomento, ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina dell’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI).

Uno dei prelievi effettuati

I laghetti alpini si sono ripresi
Il Quotidiano 09.12.2022, 20:00