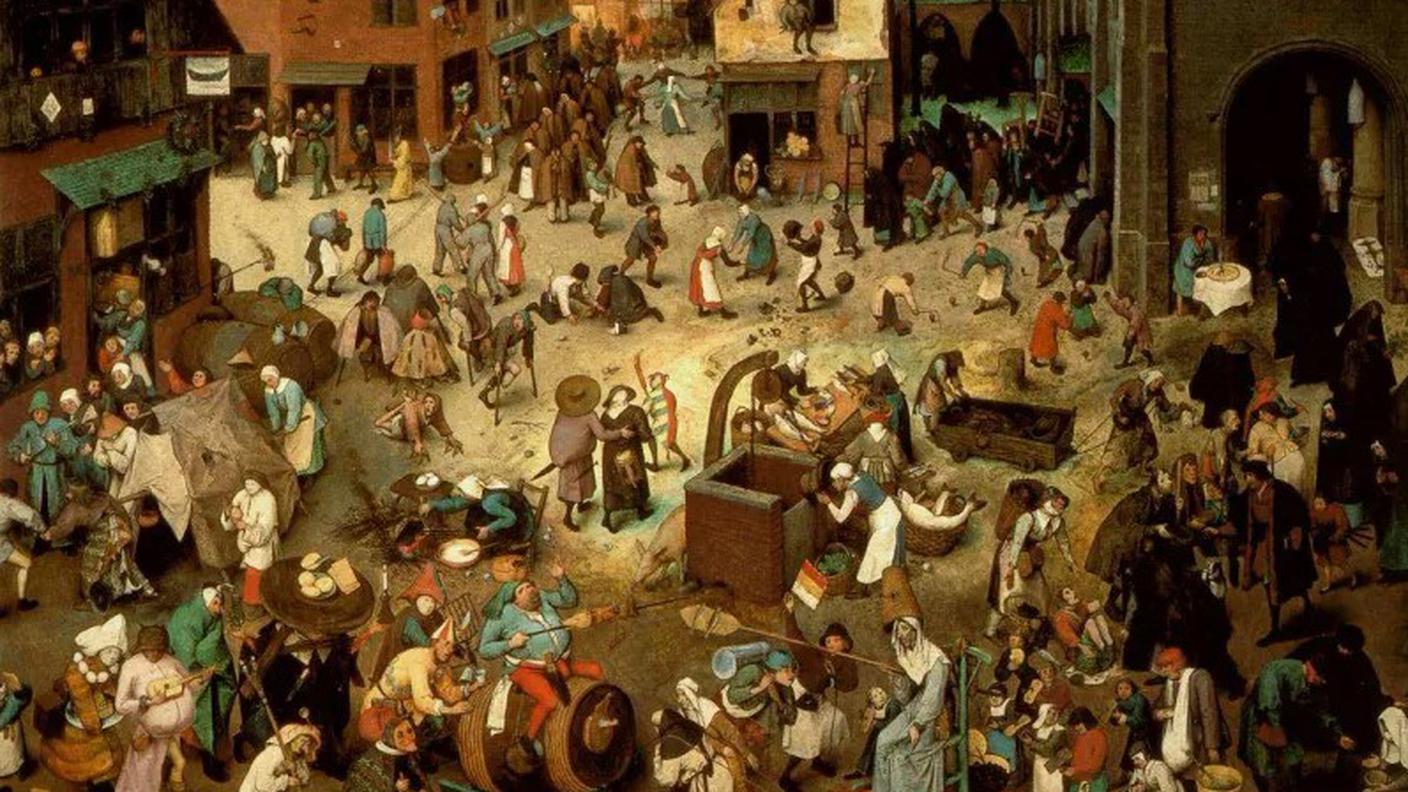«La disabilità non è una condizione personale, ma emerge quando le caratterist[ich]e psicofisiche delle persone si scontrano con una società non progettata per includerle», dice l’attivista Sofia Righetti a Barbara Rachetti di Donna Moderna. Era il 2021 e non avevo mai pensato alla disabilità in questi termini, che sono il fondamento del modello sociale della disabilità. Perché, come la maggior parte della gente, sono cresciuta immersa in quello che Nick Walker definisce “paradigma della patologia” (Neuroqueer. Autismo e futuri postnormali, ETS, 2025).
Questo paradigma si basa su due assunti che raramente mettiamo in discussione. Il primo è che esista un modo “giusto”, “normale” o “sano” in cui il corpo e la mente devono funzionare. Il secondo, conseguenza del primo, è che se il tuo funzionamento diverge da questo standard dominante, allora c’è qualcosa che non va in te.
Il cosiddetto “modello medico” della disabilità permea il linguaggio che usiamo per disabilità e neurodivergenza: parliamo di “sintomi”, “trattamenti”, “epidemie”. Eleonora Marocchini, in Neurodivergente (Tlon, 2024), ci ricorda che “neurodivergenza” è un concetto politico, non medico - anche se oggi va di moda anche in contesti clinici. È una riappropriazione dell’atipicità. Quando ci ostiniamo a usare un linguaggio “accessorio” (dire “persona con autismo” invece di “persona autistica”), stiamo cercando di separare la persona da una condizione che, forse inconsciamente, riteniamo indesiderabile. Dire “sono autistica” o “neurodivergente” o “disabile” significa quindi rivendicare un’identità politica, rifiutando il dominio clinico sulla propria esistenza. Significa vedere il mondo attraverso il “paradigma della neurodiversità”.
Questo rivendicare un’identità ci riporta al punto di partenza: il modello sociale della disabilità. La disabilità non è una caratteristica intrinseca della persona. È qualcosa che accade quando una persona incontra un ambiente ostile. Come spiega Walker, nel modello sociale «quando diciamo che una persona è disabile, intendiamo che la società non è pensata per consentirne la partecipazione, e invece è spesso strutturata in modo tale da creare barriere alla sua inclusione».
E qui arriviamo a un altro punto dolente. Continuiamo a riempirci la bocca della parola “inclusione”. Ma l’inclusione, come rileva Fabrizio Acanfora (In altre parole, effequ, 2021), presuppone che ci sia un “noi” che detiene il potere, che, con magnanimità, apre la porta a “loro”, a patto che si comportino in “modo accettabile”. Acanfora propone di usare “convivenza delle differenze”. Perché non puoi vincere la partita se il regolamento è stato scritto apposta per farti perdere. Non devi imparare le regole meglio degli altri: devi ribaltare il tavolo.
Lo stesso approccio paternalistico che troviamo nell’“inclusione” è evidente nella gestione delle risorse. Spesso i fondi non vanno a sostenere l’autodeterminazione delle persone disabili e neurodivergenti, ma finiscono nelle tasche di chi le assiste: famiglie, o istituti. Le 14 proposte della petizione Disabilità e inclusione, adesso! puntano proprio qui: basta istituzionalizzazione, basta segregazione. Bisogna finalmente applicare davvero il principio «Niente su di noi, senza di noi».
Le persone neurodivergenti e disabili non hanno bisogno di essere “curate”. Hanno bisogno di una società che non le consideri versioni rotte, da aggiustare, di persone “normali”. Hanno bisogno di accessibilità, non di pietà. Di autodeterminazione e diritti, non di favori.