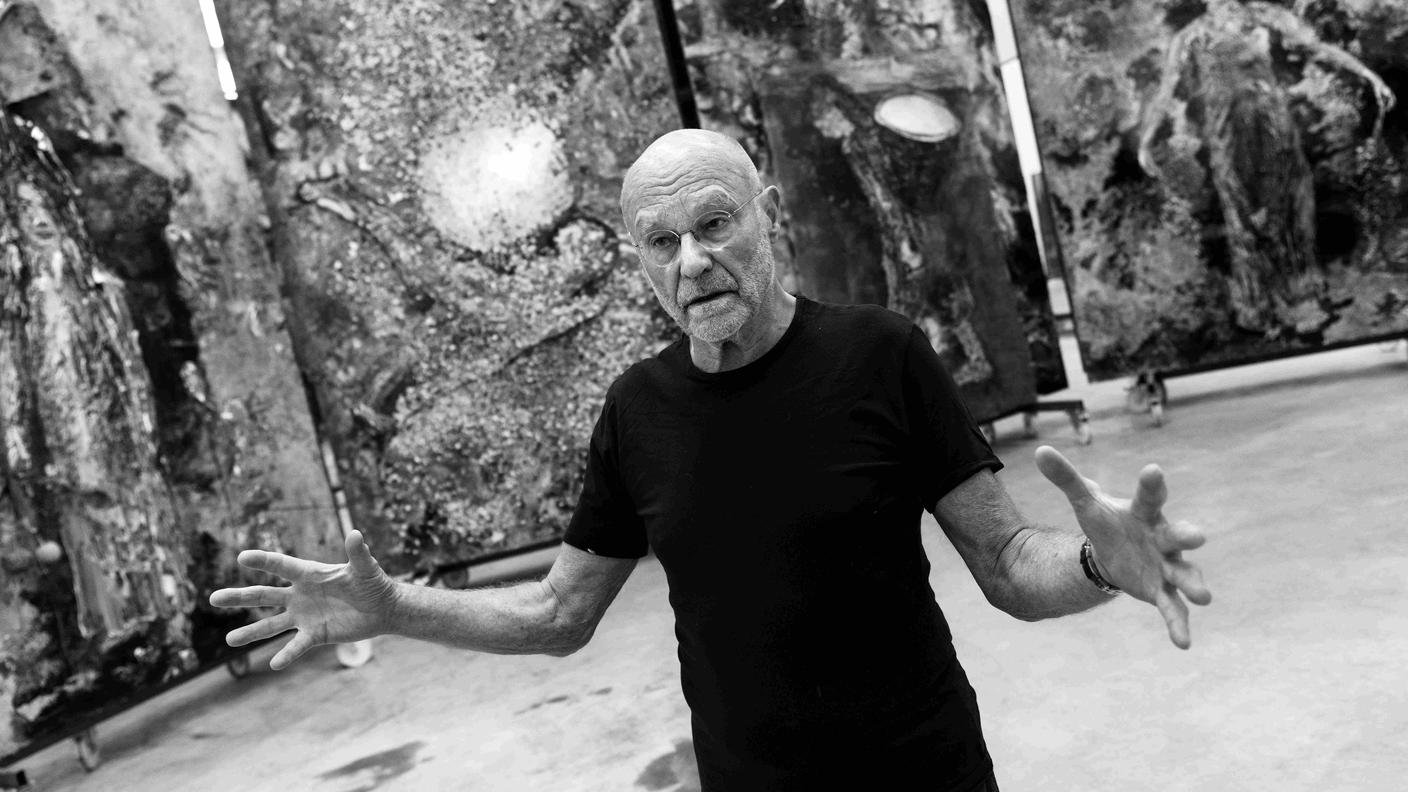C’è un luogo che non può essere disabitato, ma che da sempre viene sorvegliato, disciplinato, violato: il corpo. Corpo nero, corpo queer, corpo migrante, corpo disabile. Il corpo come confine e come frontiera, come archivio e come campo di battaglia. Ma anche — oggi più che mai — come linguaggio. Nell’arte contemporanea, il corpo non è più solo rappresentato: è agito, esposto, politicizzato. È il punto da cui si parte per riscrivere il mondo.
La centralità del corpo nelle pratiche artistiche contemporanee trova riscontro in una produzione teorica che ne indaga la dimensione biopolitica. A partire da Michel Foucault, che ha mostrato come il potere moderno si eserciti attraverso la gestione della vita e dei corpi, fino agli sviluppi più recenti della teoria queer e transfemminista, il corpo è stato riconosciuto come luogo di sapere e di contestazione. Judith Butler, in Bodies That Matter (1993), ha evidenziato come il corpo non sia un dato naturale, ma il risultato di pratiche discorsive che lo rendono leggibile all’interno di un sistema di genere. Più recentemente, Jasbir Puar ha ampliato questa prospettiva, mostrando come il corpo queer, disabile o razzializzato sia al centro di dispositivi di controllo che operano attraverso sorveglianza, medicalizzazione, spettacolarizzazione. In The Right to Maim (2017) Puar analizza come lo Stato neoliberale non escluda i corpi marginalizzati, ma li gestisca attraverso forme di violenza che mirano alla vulnerabilità permanente.
Negli studi più attuali, il corpo emerge come interfaccia critica tra estetica e potere. Roberta Sassatelli, nel corso “Corpo, genere e società” (Università di Bologna, 2024–2025), lo descrive come soggetto attivo di pratiche sociali e simboliche, continuamente riscritto da norme e sguardi. La rassegna “I poteri sul corpo” (Università di Parma, 2025), curata da Martina Giuffrè e Sabrina Tosi Cambini, ha esplorato il corpo come zona di tensione tra controllo istituzionale e resistenza creativa. In questo contesto, il corpo queer, razzializzato o disabile non è più solo “altro”: è corpo che eccede, che disarma, che interroga.
Una delle retrospettive più potenti ospitate dalla Tate Modern è stata quella dedicata a Zanele Muholi, artista e attivista sudafricana. La mostra ha raccolto oltre trecento opere, tra cui i celebri autoritratti della serie Somnyama Ngonyama. In queste immagini, Muholi si mette in scena con sguardo fiero, adornata di oggetti quotidiani — spugne, mollette, pneumatici — trasformati in corone, armature, reliquie. Ogni fotografia è un atto di resistenza visiva, un sabotaggio dell’immaginario coloniale, un monumento alla dignità delle persone nere LGBTQIA+. Muholi non chiede di essere vista: guarda. E nel farlo, ci costringe a rivedere tutto.

Tania Bruguera, lo scorso anno, ha dato vita a performance estrema: Where Your Ideas Become Civic Actions, una lettura collettiva e ininterrotta di cento ore de Le origini del totalitarismo di Hannah Arendt. Il corpo, qui, è strumento di pensiero ma anche di fatica, di durata, di esposizione. Bruguera, che ha pagato con l’arresto le sue azioni in patria, ha trasformato la vulnerabilità in linguaggio politico. Non ha rappresentato il dissenso: lo ha incarnato.

Figura di spicco in Italia di questa arte del corpo è Silvia Calderoni, che con MDLSX, spettacolo cult del collettivo Motus, ha dato vita a un viaggio teatrale che mescola autobiografia, teoria queer e dj set, dove il corpo narrante si fa specchio, detonatore, zona di transito. Calderoni non interpreta: abita. E nel farlo, dissolve i confini tra genere, identità, appartenenza. Il suo corpo in scena non è simbolo: è presenza.
Sul piano teorico, Paul B. Preciado è la voce più radicale. In un articolo su El País, ha criticato il musical Emilia Pérez per il suo sguardo binario e colonialista, ribadendo che «il corpo non è un dato biologico, ma una costruzione politica». E ancora: «Contro la disforia, rivendico una modalità di esistenza che non si lasci definire dalla patologia». In un’epoca in cui il controllo passa attraverso algoritmi, confini, dispositivi biometrici, il corpo torna a essere il primo luogo della politica.
In un tempo in cui la verità è contesa e la realtà è spettacolarizzata, il corpo resta l’unico spazio che non può mentire. Ogni gesto, ogni cicatrice, ogni respiro può diventare linguaggio. E in questo linguaggio, forse, possiamo ancora trovare una forma di libertà.

L'attivismo fotografico di Zanele Muholi in mostra a Parigi
La corrispondenza 21.03.2023, 07:05
Contenuto audio