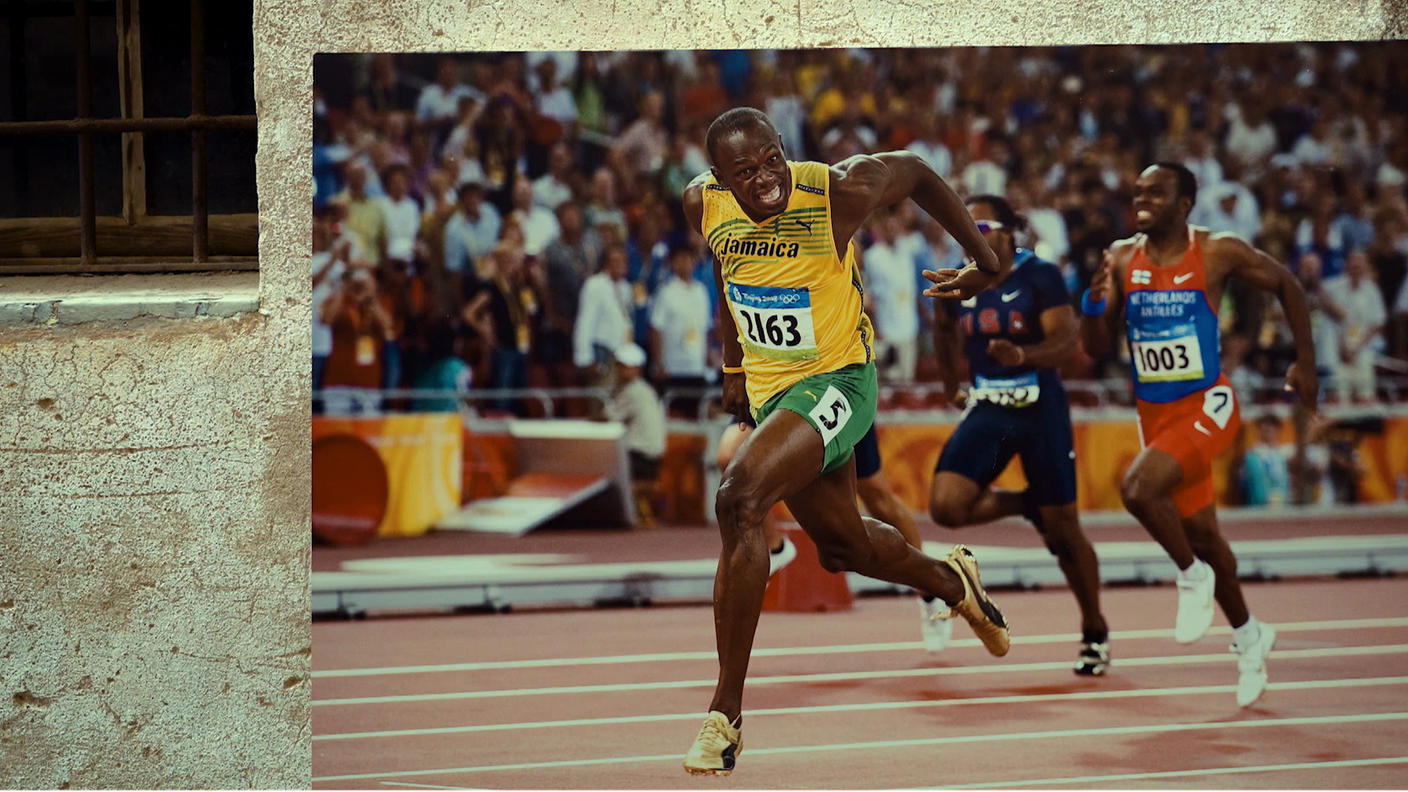Mentre in molte città del mondo migliaia di persone scendono in piazza per manifestare solidarietà al popolo palestinese e mentre Donald Trump e Tony Blair avanzano proposte per il futuro di Gaza che ricalcano logiche coloniali (traducendo il colonialismo criminale di Israele in una forma di controllo solo apparentemente più morbida, ma ugualmente problematica), al Teatro Oscar di Milano va in scena l’anteprima de La rivolta della gioia, la nuova creazione di Cristian Ceresoli. Si tratta della rivolta dei bambini e delle bambine contro lo squallore della guerra: una protesta danzante e cantata che invita il pubblico a unirsi in coro a una festa capace di cambiare la storia. Lo spettacolo è nato diciassette anni fa, quando il regista Cristian Ceresoli e l’attrice Silvia Gallerano diventavano genitori per la prima volta, mentre i media diffondevano le immagini della cosiddetta Operazione Piombo Fuso e, in particolare, quelle di cinque bambine uccise da una bomba in Palestina. È questo stridore – il principio di una nuova vita accostato all’ingiustizia della morte violenta – a costituire il seme della drammaturgia.
All’epoca della sua concezione, le barbarie dell’attuale genocidio non avevano ancora raggiunto il loro apice e, sebbene il testo sia stato ripreso nel 2023, il drammaturgo Cristian Ceresoli spiega che lo spettacolo non è vincolato alla cronaca contemporanea. L’opera vuole piuttosto mantenere un respiro universale: «Vuole muoversi con grazia e leggerezza, non è schiacciata dal contemporaneo, anche se entra a pieno titolo nel presente. Non è un’opera dedicata esclusivamente alla Palestina: è piuttosto un Vangelo che, proprio nella feroce contraddizione tra la vita e la sua negazione da parte di pochi e terribili individui, rivela quanto sia fragile e preziosa la gioia». Narrare una festa però, quando la cornice è quella di un’emergenza umanitaria, non è una scelta facile. Lo ha spiegato, per esempio, Nicola Borghesi della compagnia Kepler-452 alla XXV edizione del Festival di Narrazione di Arzo: la paura è quella di delegittimare, agli occhi di qualcuno, le ragioni di chi chiede aiuto. Un pregiudizio che nasce proprio da quel pensiero coloniale che trova conforto in un binarismo gerarchico, nel quale al proprio ruolo di salvatore si contrappone l’immagine di una vittima assoluta, ridotta a pochi tratti stereotipati. A spiegarci allora l’essenza di una festa ci pensa Nicola Ceresoli, dodici anni, tra i giovani protagonisti della cantata La rivolta della gioia, che sul palco interpreta un bambino che scrive lettere a Dio domandando come mai esiste la crudeltà. Per il giovane interprete esistono due tipi di festa: quella attesa, come possono esserlo il Natale o il compleanno, e quella inattesa, come la fi ne di una guerra o il superamento di una prova difficile. Entrambe portano gioia, ma è la seconda a sorprendere e, proprio perché inaspettata, è una gioia ancora più intensa.
Se il teatro da voce a chi una voce non ce l’ha
Charlot 07.09.2025, 14:35
Contenuto audio
Provare a tradurre questa emozione vitale, infantile, in una cantata di settanta minuti è stata una sfida, racconta l’autore: «Ho voluto scrivere una canzone che contenesse non solo un mio desiderio, ma anche le speranze condivise con le persone con le quali ragionavo all’inizio di questo viaggio. Volevamo capire se fosse possibile costruire una canzone lunghissima, portare nel mondo questo contenuto in forma di cantata. Da lì ho cominciato a lavorare su una canzone popolare, partendo proprio dagli ottonari di Bocca di Rosa di Fabrizio De André. Ho provato e riprovato, in maniera molto artigianale, a usare quella linea melodica, facendole indossare nuove parole che raccontassero una nuova storia: la storia di una rivolta dei bambini e delle bambine contro lo squallore delle guerre». Lo spettacolo che ne è nato, spiega, «mi viene sempre da chiamarlo una festa cantata, o, se vogliamo, un musical in cui i protagonisti non sono le persone del cast, ma le persone che lo ascoltano, che accolgono una danza e si ritrovano a ballare e cantare. Solo in questo senso, l’idea della lunga canzone è realmente realizzata». All’interno di questa struttura si alternano inoltre cori polifonici, momenti di parlato su musica — come quando il giovane Nicola Ceresoli legge una lettera a Dio — intrecci di voci e melodie che danno vita a un unico grande racconto.
Le influenze sono molteplici e spaziano tra generi e linguaggi diversi. Emergono gli echi di Enzo Jannacci, con la sua capacità di mescolare comicità e tragedia mantenendo una leggerezza inconfondibile. Si intravedono richiami al teatro popolare e politico di Dario Fo e Franca Rame, ma anche suggestioni provenienti dalla musica di Vinicio Capossela, in particolare dalla sua forza di scatenare il pubblico in danze. A questo si aggiunge una componente rock che imprime energia e ritmo alla narrazione, mentre sul versante classico il riferimento privilegiato è Bach, osserva Cristian Ceresoli. Le fonti letterarie, prosegue il drammaturgo, non sono da meno: Il Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante ha rappresentato una guida fondamentale, insieme alla rilettura del Vangelo, che fornisce allo spettacolo una dimensione simbolica e spirituale. Sul piano cinematografi co e poetico, infi ne, l’autore si è confrontato nella sua ricerca con Pier Paolo Pasolini, tanto con La ricotta quanto con Il Vangelo secondo Matteo. È un universo ricco, in cui questi omaggi riaffi orano in superfi cie alternandosi in maniera più o meno evidente. Il coro di voci bianche, simbolo di un’infanzia segnata dalla guerra, richiama per me quella contrapposizione che Italo Calvino mise al centro del suo primo romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Lì, come nello spettacolo La rivolta della gioia, la voce irriverente e ingenua dei bambini si intreccia con la violenza e con la Storia, off rendo uno sguardo diffi cile da ignorare. «Non c’è stata una scelta registica a priori nel decidere di coinvolgere dei bambini per stimolare una conseguenza specifi ca o per rappresentare una tematica particolare. È stato piuttosto un processo naturale: costruendo quest’opera, si è costruita insieme anche la comunità che la incarna, che la mette in scena». Questa comunità comprende fi gure professionali, come il direttore musicale Stefano Piro e la corista Francesca Risoli, ma anche presenze nate spontaneamente. C’è, ad esempio, una bambina ancora troppo piccola e timida per esibirsi, che conosce però tutta l’opera a memoria: «È come se si fosse innamorata dello spettacolo prima ancora di poter partecipare. Se troverà gioia e felicità nell’esibirsi un giorno, sarà un valore aggiunto. Non c’è stata alcuna imposizione: abbiamo semplicemente lasciato che le cose accadessero, senza forzature». Lo spettacolo nasce dunque in un contesto familiare e, nelle intenzioni registiche, si colloca in una prospettiva diversa rispetto ad altri lavori che hanno coinvolto bambini in scena, come quelli di Romeo Castellucci o il recente Medea’s Children di Milo Rau (in scena al LAC di Lugano nel marzo 2026). L’effetto sul pubblico, sul piano della ricezione, tuttavia, rimane imprevedibile, e sentimenti simili a quelli suscitati dalle opere di Rau o Castellucci possono comunque riaffi orare. L’anima politica de La rivolta della gioia la si riconosce però proprio in questa unicità: dal nucleo familiare lo spettacolo si apre, come un’onda, a una festa collettiva che travolge la sala. Una festa che non è evasione, ma resistenza allo squallore e alla barbarie; un atto di comunità che invita a difendere, insieme, la possibilità stessa dell’umanità.