Riccardo III, con la regia di Antonio Latella, è in scena il 21 e il 22 ottobre al LAC. Vinicio Marchioni e un brillante cast di dieci attori sono pronti ad ammaliare il pubblico grazie al potere performativo della parola che il Bardo ci consegna.
«Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo!» la battuta è nota a molti, ma se facessimo lo stesso esercizio che spinge Al Pacino in Looking for Richard, in pochi ci saprebbero dire, per strada, di che parla il Riccardo III. E sì, non è tra le pièces più accessibili scritte dal Bardo, è difficile e contorta, ma oggi i suoi pentametri giambici ci parlano più che mai. L’urlo disperato che chiude il Riccardo III è una delle battute più celebri del teatro, ripresa poi anche al di fuori dei palcoscenici e adattata a misura per ogni occasione. Ma cosa significa? Innanzitutto contestualizziamola, siamo all’ultimo atto della tragedia: la battaglia di Bosworth. L’esercito di Riccardo III è in rotta, lui ha perso il cavallo e combatte a piedi, accerchiato dai nemici. Quel grido, apparentemente comico, è in realtà tragico: il Re, che ha conquistato il potere con l’inganno e la parola, senza scrupoli e mietendo vittime a volontà, ora baratta il regno — simbolo del dominio assoluto — per un animale che gli permetta di fuggire o continuare a combattere. È il momento in cui l’illusione del controllo crolla: il sovrano che ha manipolato tutti si ritrova nudo, vulnerabile, umano. La battuta diventa così l’emblema della caduta del potere, della sproporzione tra l’ambizione smisurata e la fragilità concreta del corpo. Quindi, dietro quella richiesta estrema, dietro la furia e la disperazione, si nasconde furbescamente uno dei tratti di William Shakespeare: il fondere crudeltà e grottesco, la riflessione sul potere e sull’illusione, la grandezza e la miseria dell’uomo.
Ma allarghiamo un po’ il campo della nostra lente e andiamo a vedere ciò che accade al di là di queste battute, fuori dal testo e giù dal palco. Fine del Cinquecento, Londra vive una stagione teatrale febbrile. Shakespeare è un autore in ascesa e con Riccardo III – scritto intorno al 1592 – chiude il ciclo di drammi dedicati alla Guerra delle due Rose. Guerra civile ahimé lunga e distruttiva che aveva devastato l’Inghilterra tra il 1455 e il 1487, combattuta tra due rami della dinastia dei Plantageneti, la casa dei Lancaster (rosa rossa) e la casa di York (rosa bianca). Oggetto della contesa ovviamente il potere al trono, che andrà a Enrico Tudor (Enrico VII) il giorno che sconfigge Riccardo III di York (sì proprio lui) nella battaglia di Bosworth. Questi non si accontenta del potere, si prende anche l’amore, Elisabetta di York, unendo così simbolicamente le due rose nell’emblematica ‘Rosa Tudor’, segno di pace e inizio di una dinastia che porterà a Elisabetta I, la Regina al tempo del Bardo.
Fin qui la Storia, ma il dramma shakespeariano? Narra l’ascesa e la caduta sì, di Riccardo di Gloucester, ma lo fa calcando leggermente la mano (la scelta è politica, vedremo più avanti). Questi per sete di potere, mascherata a noia (abbiamo citato la fine, ma che bello anche l’inizio dell’opera: “Ormai l’inverno del nostro scontento si è fatto estate al bel sole di York, e giacciono nel seno dell’oceano tutte le nuvole che minacciavano la nostra casa.”) elimina uno a uno i suoi rivali, partendo dal fratello, poi i nipoti, fino a impadronirsi del trono d’Inghilterra. La sua corsa si interrompe sul campo di Bosworth, di cui sopra. Ma ciò che conta qui, più della vicenda storica, è la costruzione del personaggio. Riccardo parla direttamente al pubblico, si confida, si vanta, manipola, ride di sé e degli altri. «Sono determinato a essere un furfante», dichiara all’inizio, quasi con orgoglio. È uno dei primi veri villain moderni, e riesce comunque (o forse per questo?) a sedurci. Ma è anche un attore dentro l’attore: sa che il mondo è un palcoscenico e l’inganno una forma d’arte. In lui William Shakespeare porta all’estremo il tema dell’identità come finzione, del linguaggio come arma. Riccardo è l’uomo che conquista il potere con la parola, e muore quando la parola gli si spezza in gola. E tutto questo lo fa dichiarando in continuazione i propri intenti. Non è un caso che molti lo considerino un parente del Macbeth, altro tiranno condannato a perdersi nella propria ambizione. Ma se Macbeth è tormentato dal rimorso, Riccardo è puro godimento del male, lucidità che si fa ironia. Carmelo Bene – che nel 1977 ne diede una memorabile interpretazione sonora – diceva: «Riccardo III è la lingua che si deforma nel suo stesso eccesso».
La sua deformità fisica esplicitamente menzionata nel dramma, è celebre metafora: il vero male non è nel corpo, ma nella parola che mente. Come detto, dal punto di vista storico, Shakespeare piega la verità senza scrupoli. Il vero Riccardo Plantageneto non era un mostro ma un sovrano energico, un riformatore, attento alla giustizia. Avrà sicuramente avuto qualche scheletro nell’armadio pure lui, ma non ai livelli del personaggio drammatico di William Shakespeare, che ricordiamolo scriveva sotto Elisabetta I, e si sa, la propaganda politica ha sempre bisogno di un tiranno da abbattere e deridere. Nasce così un personaggio di straordinaria efficacia scenica, simbolo del potere che corrompe e della menzogna che si traveste da legittimità (niente che non possiamo capire oggi…). «Il sorriso non mi lascia mai le labbra», dice Riccardo in un passo. È il sorriso del politico, del manipolatore, del demagogo. Ma anche il sorriso del comico che sa di essere visto.
Nell’introduzione dei Meridiani Mondadori, Giorgio Melchiori scrive che Riccardo III è probabilmente il primo dramma del teatro moderno che abbia come protagonista non l’eroe tragico in quanto tale, ma l’autore stesso della trama (tessuto di parole giocato sull’ambiguità) che verrà rappresentata. La finzione teatrale è quindi inganno della parola, e quanto più ci sarà finzione, tanto più il teatro sarà vero. Riccardo III qui viene presentato anche come antieroe fascinoso con “un ampio margine di ambiguità e un irresistibile senso dello humor che ben oltre la misura del grottesco”, del resto, i cattivi ci sono sempre piaciuti.
Il fascino del personaggio è passato attraverso secoli di messe in scena. Prima abbiamo citato Carmelo Bene, che aveva trasformato Riccardo III in un esperimento linguistico, dove la voce diventava corpo e la mostruosità parola. Ma spaziando, Laurence Olivier, nel film del 1955 da lui diretto e interpretato, gli diede la voce di una vipera e la postura elegante di un aristocratico malato di potere. Ian McKellen, nel 1995, ne fece un tiranno fascista in divisa nera, in un’Inghilterra anni Trenta immaginaria: un’interpretazione che mostrava quanto la tragedia di Shakespeare potesse ancora dialogare con la storia del Novecento.
Nel 1996 poi, Al Pacino affronta il testo da attore e regista in quel bellissimo film che è Looking for Richard (Riccardo III – Un uomo, un re), un film a metà tra documentario, saggio teatrale, critica dell’opera. Pacino alterna prove, discussioni con studiosi e colleghi, scene girate per strada, riflessioni sulla recitazione e sul pubblico. Il film non spiega solo Shakespeare, ma lo cerca tra la gente. «Shakespeare parla di ciò che siamo – dice Pacino – e di ciò che fingiamo di essere.» La ricerca diventa quindi doppia: cercare Riccardo e cercare sé stessi. In fondo, il vero tema del dramma è proprio questo: la recita del potere, l’attore che conquista la realtà recitando meglio degli altri.
Alla fine, quando Riccardo grida «Un cavallo, un cavallo, il mio regno per un cavallo!», non è solo la voce di un re sconfitto: è la voce di ogni uomo che ha creduto di poter dominare il mondo con la parola ma si ritrova improvvisamente a corto di respiro.
Riccardo III nella messinscena di Antonio Latella
Sta debuttando in questi giorni il Riccardo III di Antonio Latella con la traduzione di Federico Bellini, suo fedele drammaturgo e traduttore. Si tratta di una co-produzione LAC e Stabile dell’Umbria, che vede Vinicio Marchioni (già con Latella nei panni di George in Chi ha paura di Virginia Woolf? di Edward Albee, 2021) giocare il ruolo di Riccardo di Gloucester. In questa rilettura, Latella va oltre l’immagine del mostruoso proposta da Shakespeare. Il male, oggi, secondo il regista, non si nasconde dietro un gobbo o uno zoppo ma risiede nella bellezza: il male è seduzione. La parola anche qui continua a incantare e corrompere, come il serpente nell’Eden, che nella rappresentazione di Latella viene ricreato a simbolo di bellezza assoluta e ingannevole, fatta di relazioni pericolose.
Due altri punti di rottura rispetto alla tradizione: nella nuova traduzione Bellini gioca con i registri, sfiorando toni da commedia, e poi c’è l’inserimento di un nuovo personaggio, il Custode, disposto a tutto pur di garantire la sopravvivenza del giardino dell’Eden. Il cast è formato prevalentemente da giovani: Latella, dagli anni della sua Biennale, ha visto la forza delle giovani leve che contribuisce a far crescere.
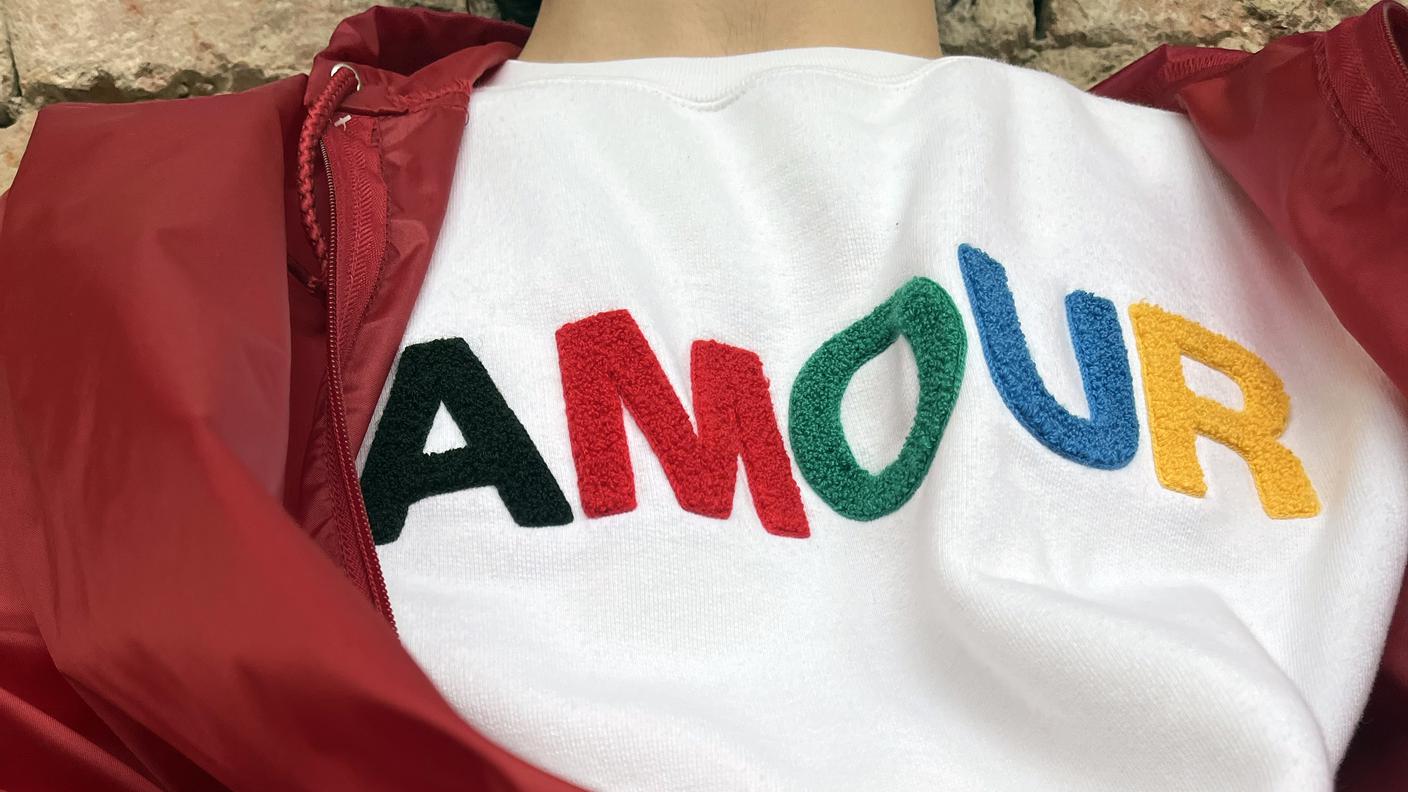
La parola si fa corpo
Charlot 19.10.2025, 14:35
Contenuto audio



