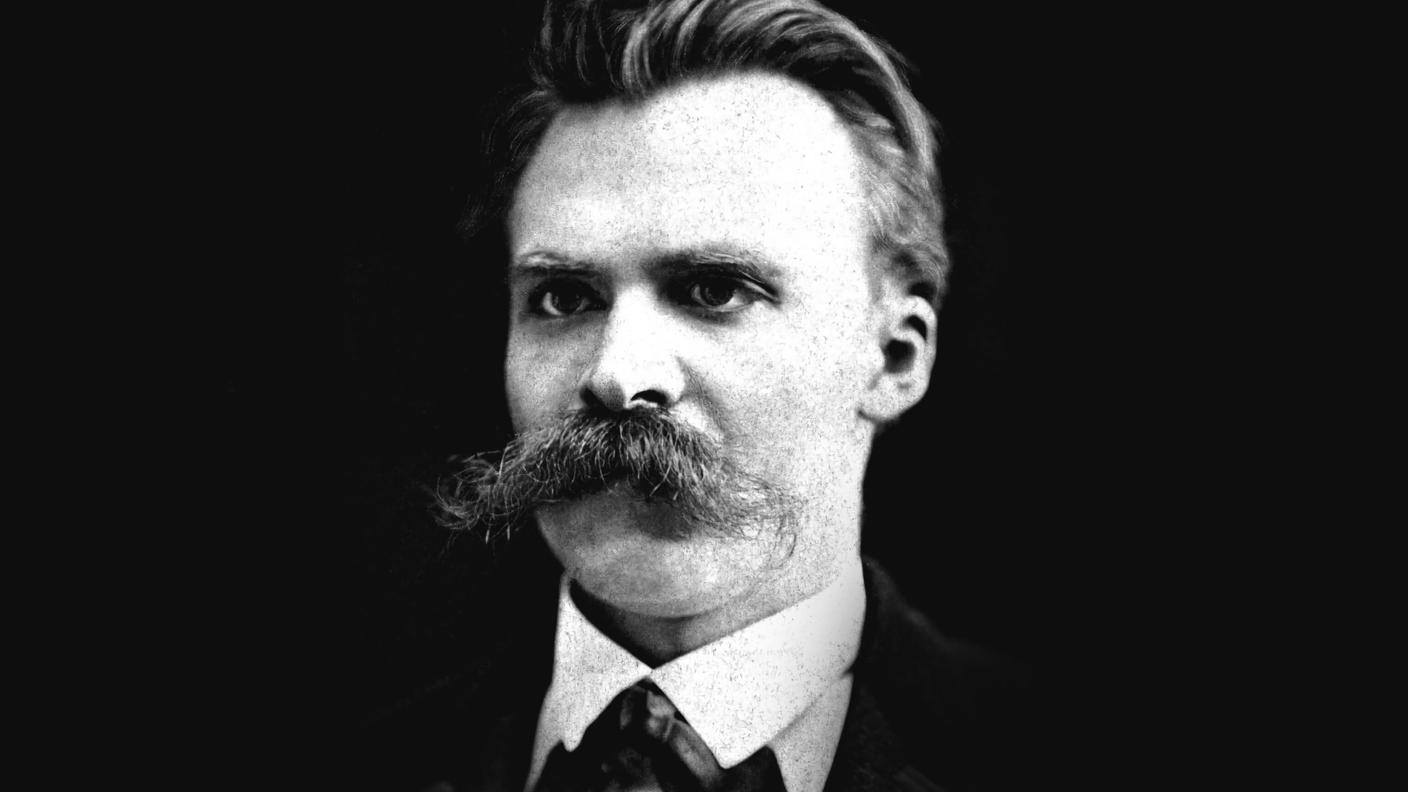La recente istituzione, da parte di papa Leone XIV, di una Messa per la Custodia della Creazione testimonia come la Chiesa cattolica, a dieci anni di distanza dall’enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune di papa Francesco, avverta con rinnovata urgenza quello che oggi appare come non più uno dei, bensì il problema fondamentale che la comunità mondiale deve affrontare: quello del cambiamento climatico, che, generato dall’attività dell’uomo, rischia ormai di metterne in pericolo, a breve, la sopravvivenza stessa. Quasi in coincidenza con la celebrazione della prima Messa per la Custodia della Creazione, un’improvvisa alluvione nel Texas ha ucciso più di cento persone, molte delle quali bambini in campeggi estivi, e questo non poteva non colpire il Papa americano, originario di quel Paese il cui governo è uscito dagli accordi internazionali per la limitazione delle emissioni nocive nell’atmosfera.
Al di là delle circostanze storiche e politiche, riflettendo sui contesti culturali, è evidente che molta acqua è passata sotto i ponti (in realtà sarebbe più opportuno dire: ci sono state molte alluvioni), da quando si poteva accettare tranquillamente il comando rivolto da Dio all’Uomo, fatto a sua immagine e somiglianza: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» (Genesi,1, 28). Che questa celebre pagina biblica, con l’affermazione della superiorità dell’uomo su tutte le creature, con l’esplicito invito a «soggiogare la terra», sia alla radice dell’ideologia dello sfruttamento della natura, è cosa ormai da più di un secolo ben nota alla sociologia della conoscenza. Proprio agli inizi dell’età moderna, infatti, si è verificato il mutamento radicale di atteggiamento nei confronti della natura: da quello prevalentemente contemplativo dell’uomo medievale, a quello attivistico del borghese, nutrito da una scienza non più teoretica, ma eminentemente pratica, tecnologica (basti pensare a Francesco Bacone).
Il passaggio dal soggiogamento della terra e degli animali alla «cura della casa comune», o alla «custodia della creazione», è indubbiamente un bel salto qualitativo, dovuto certamente agli eventi catastrofici degli ultimi tempi, ma che si basa pure sulla non mai dimenticata consapevolezza che anche l’uomo, in fondo, è una creatura. Intitolando Laudato si’ la sua enciclica (e, prima ancora, scegliendo il nome pontificale di Francesco), il Papa aveva in mente il Cantico delle Creature, in cui il santo di Assisi chiama “fratelli” e “sorelle” gli elementi della natura e “Madre” la terra. Non aveva torto, in fondo, Simone Weil a dire che san Francesco è «uno stoico puro», perché qualcosa di classico, di “pagano”, per nulla affatto biblico, c’è in questa visione dell’universo intero legato da un legame di comunanza stretta, di parentela (synghéneia, si direbbe in greco) per cui si guarda con amore alla natura.
Non si deve però dimenticare che per l’Assisiate, come poi per il Papa, la natura, e l’uomo in essa, sono il Creato, ossia qualcosa che è comunque ben distinto – ontologicamente diverso, direbbero i filosofi – dal Creatore. Non v’è dubbio che qui vi sia ancora l’eco del racconto biblico, e perciò una grande distanza dal pensiero antico, classico, in cui il concetto di creazione è sostanzialmente assente, in quanto connesso ad un’immagine antropomorficamente riduttiva di Dio, o degli dèi.
Le differenze si comprendono facendo un semplice esempio, come quello dell’inquinamento di un corso d’acqua. L’ecologia convenzionale, valutando utili e danni, lo contesta se pensa che così si fa un danno all’ambiente, e dunque anche, prima o poi, all’uomo. L’ecologia integrale, che non considera l’uomo un essere superiore agli altri viventi, separato da essi, lo contesta guardando ai danni non solo per l’uomo, ma anche per le specie animali, e in ciò è molto vicina al concetto di custodia del Creato. Nessuna di queste concezioni è però sfiorata dal pensiero che quel corso d’acqua sia sacro, come sacri sono i boschi, le montagne, ecc.; anzi, la moderna mentalità, sedicente scientifica ma in realtà ancora grettamente positivistica, sorride ironicamente di fronte al pensiero degli antichi, che vedeva ogni parte della natura abitata da divinità – naiadi, driadi, amadriadi, oreadi, ecc., per cui Iovis omnia plena, Tutto è pieno di Dio, recita Virgilio. Non comprende, infatti, che questo significava guardare agli elementi della natura nella loro pura bellezza, fuori da ogni considerazione di utilità per l’uomo, o comunque fuori da ogni finalismo - sub specie aeternitatis, dicono i filosofi – come lo esprimono mirabilmente i celebri versi di Angelus Silesius sulla rosa “senza perché”: «La rosa è senza perché; fiorisce perché fiorisce / a sé non bada; che tu la guardi non chiede».
Al di là di queste significativamente diverse valutazioni, l’elemento davvero discriminante nel problema ecologico è l’ideologia del progresso, che ha anch’essa una precisa origine biblico-cristiana. Si tratta infatti della versione laica, mondanizzata, dell’idea della storia umana come guidata da Dio, che l’ha originata e la conduce a una fine. Nell’età moderna è venuta meno la fede escatologica - fine del mondo, giudizio universale, ecc. - sostituita appunto dall’idea di progresso, nutrita dagli effettivi passi avanti compiuti dalla scienza e dalla tecnica. Questa laicizzazione non è stata però indolore, anche perché – e questo è oggi il punto – il progresso ha assunto la forma tutta economica dello sviluppo, ossia di un aumento della produzione e dei consumi, come se fosse capace di assicurare esso stesso un sempre maggiore benessere. Lo sviluppo si fonda ovviamente sullo sfruttamento delle risorse naturali, che non sono infinite, per cui l’idea di sviluppo all’infinito è assurda, al limite del demenziale, ovvero può essere sostenuta solo dalle forze economiche e politiche alla ricerca demagogica di facili consensi.
In un mondo in cui tutte le potenze, grandi e piccole, sostengono questa ideologia dello sviluppo e le voci contrarie di intellettuali e scienziati poco o nulla possono contro il dominio del mainstream mediatico, ci si deve rallegrare del fatto che almeno la Chiesa cattolica mantenga saldo il principio della custodia della casa comune, creata o no che sia.
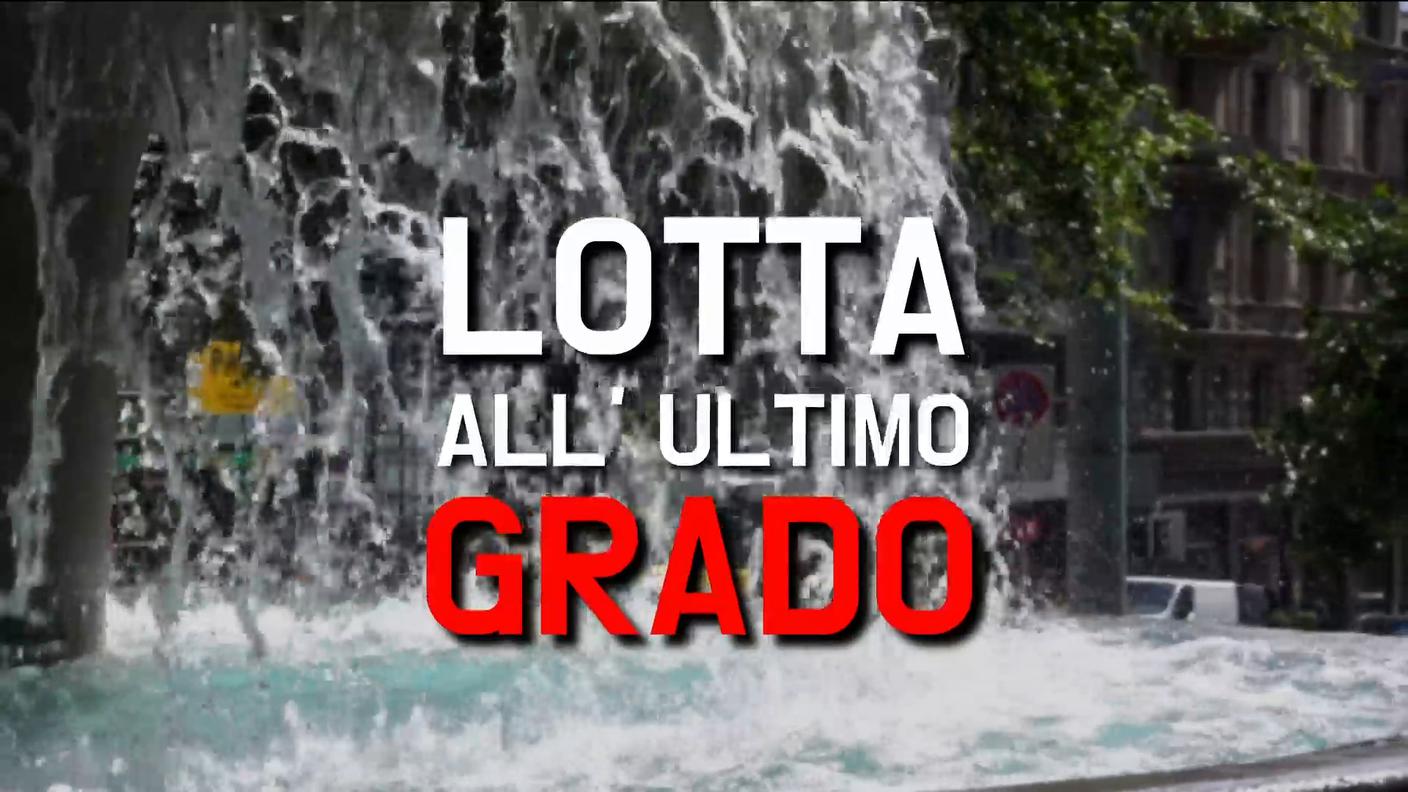
La lotta di Sion contro il caldo estivo
Telegiornale 13.07.2025, 20:00