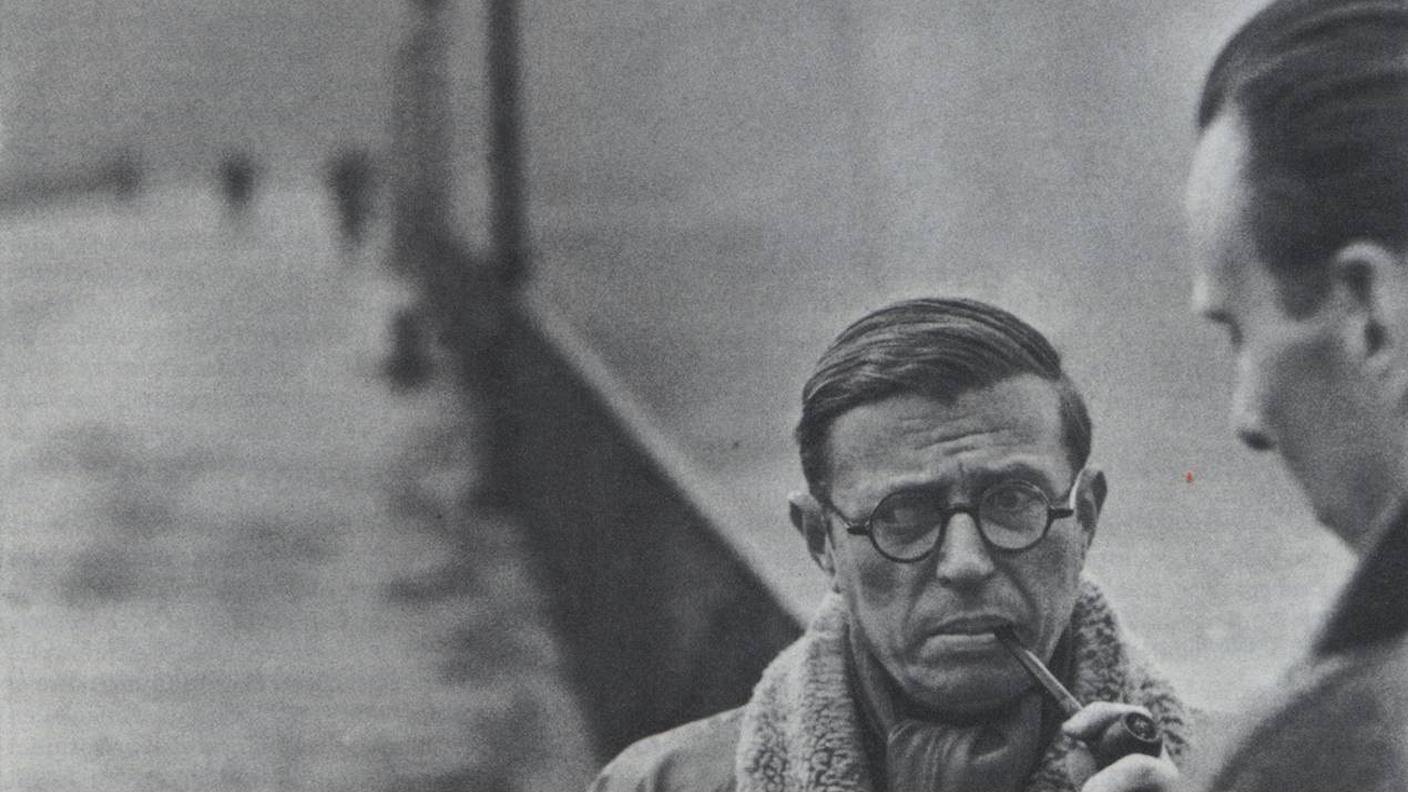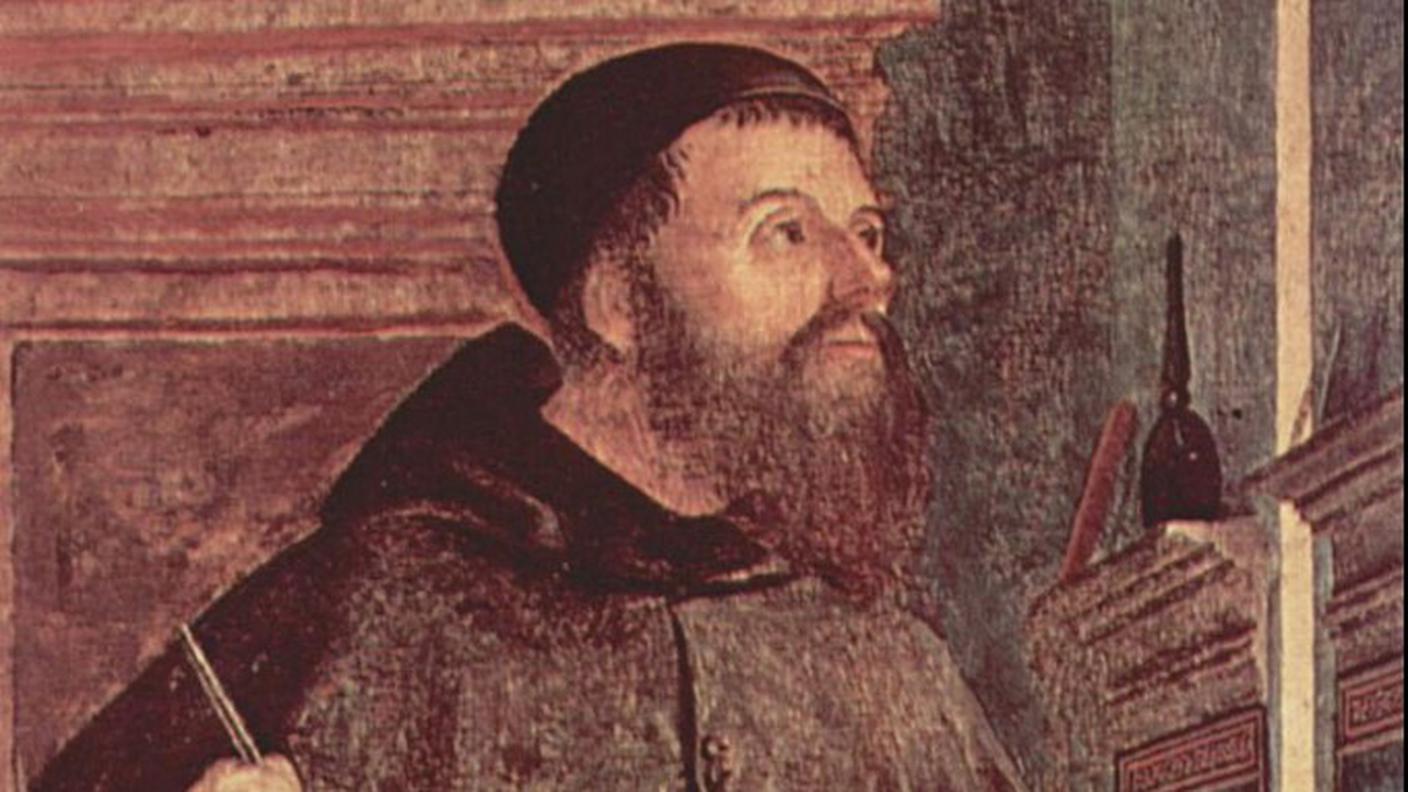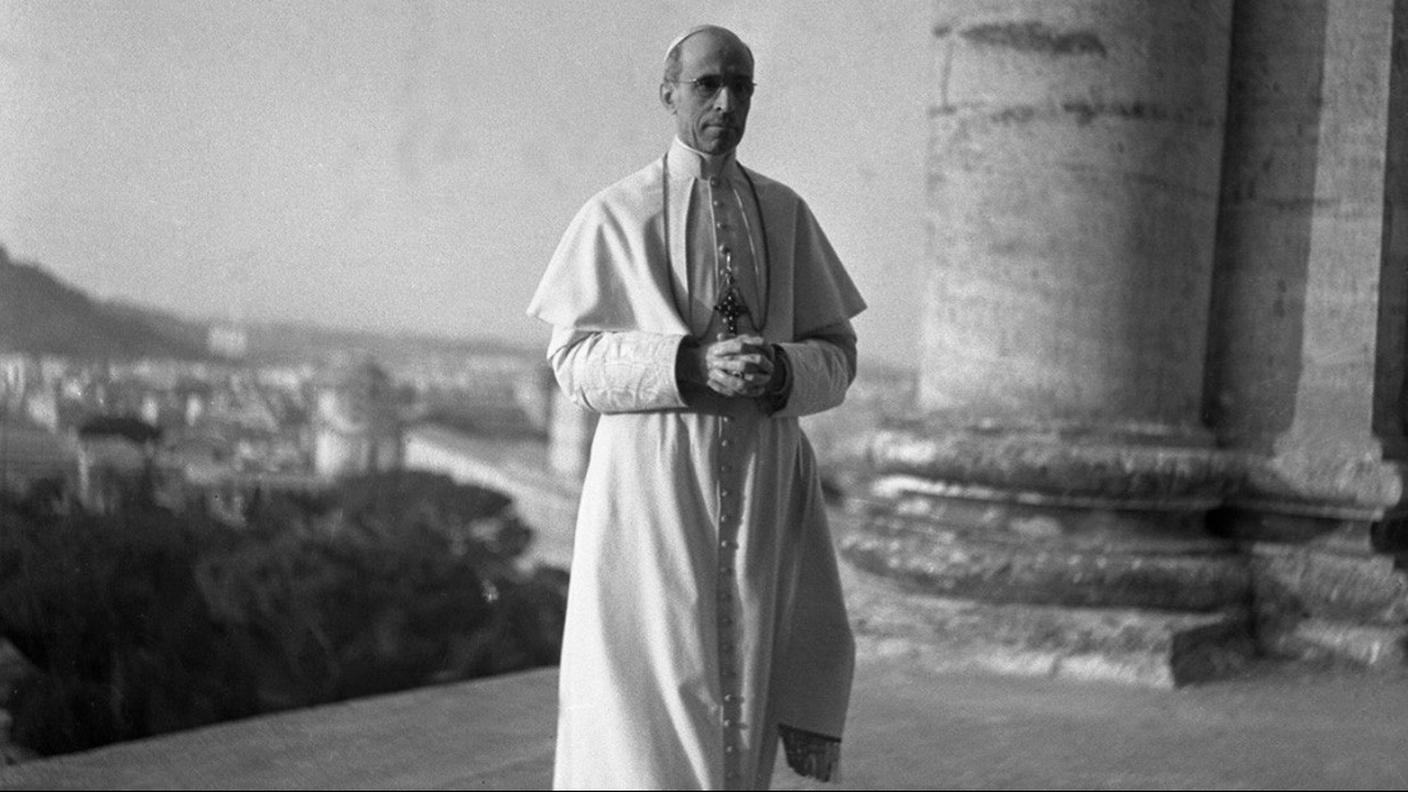Partiamo da uno dei suoi ultimi lavori, forse il più breve, quel “Tacet” (Adelphi) che, pubblicato nel 2002, l’anno della sua morte, fu come un testamento. Giovanni Pozzi (padre Giovanni dopo l’entrata nell’ordine francescano), l’italianista nato il 20 giugno 1923 a Locarno e formatosi alla scuola di Gianfranco Contini, sferza in questo testo la nostra epoca perché incapace di scegliere il silenzio. Quello stesso silenzio che fu come il fil rouge di tutta la sua vita, il silenzio di quando Pozzi studiava e leggeva per poi mettere in pagina le proprie opere. Il silenzio che deve far necessariamente parte della vita di chi con la scrittura, e la lettura, lavora: “Se nel corso di un discorso pubblico o di una liturgia s’impone una pausa di silenzio, immancabilmente uno si mette a tossire, uno fa scricchiolare il banco, uno sfoglia le carte sottomano, una apre la borsetta”, scrive. Ma “l’apice del silenzio di ascolto si ha quando la parola stessa si presenta silenziosa senza perdere alcunché della sua vitalità: nella lettura”.
C’è quindi un momento successivo, decisivo secondo Pozzi, all’interno del silenzio, ovvero al tempo della metabolizzazione di quanto letto, la pausa della memoria. “Dal silenzio contemplativo, lasciandosi guidare dal cappuccino Bartolomeo Barbieri da Castelvetro, discepolo secentesco di san Bonaventura, dalla beata Angela da Foligno e da santa Veronica Giuliani – scrisse Cesare Cavalleri in un memorabile pezzo del 2013 dedicato su Avvenire proprio all’italianista ticinese – padre Pozzi perviene alla ‘discesa annichilativa’”. Che può condurre anche alla contemplazione del nulla, certo, ma pure, come fecero Caterina da Siena, Teresa d’Avila e Faustina Kowalska, a un vuoto riempito dell’amore di Dio, del sapore del divino.
Dal silenzio al compimento
In “Tacet” c’è tutto Pozzi. Il silenzio e la solitudine intesi come mezzi per attingere al più alto dei traguardi, “la propria umanità allo stato puro”. La ricerca di solitudine degli eremiti non dà soluzione al dualismo più intimo, quello fra parola e silenzio. Solo il libro compone questo stesso dualismo, nell’unico posto cioè in cui la parola può essere silenziosa.
Il ricordo di Orelli e Martini
RSI New Articles 20.07.2002, 02:00
Pozzi scelse sempre il silenzio come stile di vita. Al rumore, al confronto polemico, preferì l'isolamento e il tacito raccoglimento. Fuggì dalla banalità quotidiana per ricercare uno spazio interiore in cui, fuggendo dal caos del molteplice, anelare di “giungere all’inseparabile”. Pozzi parla di eremiti, di stiliti, di monaci che trovano rifugio da inquietudini e turbamenti nelle proprie celle, e parla di sé come di una persona anch’essa alla ricerca dell’uno nel silenzio delle proprie giornate laboriose. Tanto che è probabilmente qui, in questo tacet, il fulcro del lavoro di Pozzi: un aprirsi di riflessioni sulle tematiche più disperate all’interno di un silenzio che sa farsi memoria. Dal buio del rumore, insomma, alla luce del silenzio. Scrive Pozzi: “Morta nel silenzio dell’ascolto, la parola rigermoglia nel silenzio fervido che l’avvolge. Assimilata e ricreata attraverso la meditazione, si delinea come un essere nuovo. Se il grano non muore non fa frutto. La morte del seme è la vita della pianta. E proprio la pianta, unico essere della natura che sia insieme silenzioso e animato, si offre a noi come l'immagine più consona di ciò che accompagna le pause dopo la lettura. Silenziosa e piena di vita, la pianta fa uscire dal seno del seme la foglia, e il fiore che si esibisce in un trionfo di forme e colore, e il frutto generoso di succhi e dolcezze”.
Interessi vastissimi
Pozzi non seguiva le mode. Le sue ricerche erano dettate da passioni personali, ed anche dall’imporsi di agende che solo nella sua mente prendevano forma. Del resto, come ha spiegato recentemente su catt.ch Stefano Prandi, direttore dell’Istituto Studi Italiani dell’USI, lo stesso Pozzi è “una figura straordinariamente originale e complessa, capace di compendiare in sé, come pochi altri studiosi, un crocevia di saperi e competenze vastissimi, che hanno trovato espressione lungo un cinquantennio di appassionate ricerche”. Quali? “Anzitutto il Barocco, un interesse che si prolunga per tutta la vita. Vengono poi le grandi edizioni di testi umanistici, Francesco Colonna ed Ermolao Barbaro, a cui Padre Pozzi lavora negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta. Poi ancora le ricerche che si ispirano allo strutturalismo e allo studio della topica letteraria, sulla linea di Ernst Robert Curtius, con una particolare attenzione rivolta all’intersezione tra parola e immagine e alle forme del linguaggio figurato. Ci sono poi gli studi sulla storia della mistica e della religiosità popolare; quelli sulla didattica dell’italiano: e si potrebbe continuare”.
L’addio all’insegnamento
RSI New Articles 25.06.1998, 02:00
Insomma, un campo di interessi vastissimi per questo studioso figlio di un titolare di un’impresa di pavimentazione e di una impiegata del settore alberghiero. Un uomo che scelse il sacerdozio a 24 anni, ma che da subito si dedicò allo studio delle lettere, a Friburgo con Giuseppe Billanovich e Contini, raggiungendo poi la laurea con una tesi sull’oratoria barocca. Quindi la libera docenza (dal 1956), poi dal 1960 professore straordinario e dal 1967 al 1988 professore ordinario di letteratura italiana sempre a Friburgo dove s’impose come saggista e critico letterario di fama internazionale.
Fra parola e immagine
Difficile dire quali siano le opere più importanti di Pozzi. Ognuna, a modo suo, ha una sua rilevanza. Ognuna scaturisce da un silenzio diverso, da una maturazione avvenuta in tempi differenti. Scrive Guido Pedrojetta nel “Dizionario storico della Svizzera” che i suoi interessi, “vertenti sin dall’inizio sui messaggi misti di parola e di immagine, sono culminati nel 1964 con l’edizione monumentale dell’‘Hypnerotomachia Poliphili’ di Francesco Colonna (1499)”. E ancora: “Sul versante teorico, con il trattato ‘La parola dipinta’ (1981) Pozzi si è imposto come uno degli specialisti più autorevoli della letteratura dell’epoca barocca, specialmente con le edizioni critiche e annotate delle ‘Dicerie sacre’ (nel 1960) e dell’‘Adone’ (nel 1976 e 1988) di ‘Giambattista Marino’”. Autore di importanti studi ed edizioni di scritture mistiche e di originali esegesi iconografiche, Pozzi ha svolto anche una notevole “opera di consulenza e di riorganizzazione di fondi librari e di archivi friburghesi e ticinesi: in primis, la biblioteca Salita dei Frati di Lugano, in cui sono confluiti i suoi libri”.
Carta bianca - Padre Giovanni Pozzi
RSI Notrehistoire 04.04.2017, 11:32
Nei suoi saggi ed edizioni critiche di testi Pozzi ricercò sempre l’assoluto. Fra i tanti lavori, unico resta il contributo dato in “L’alfabeto delle sante” (Adelphi 1996), nel quale Pozzi spiega come la dialettica del linguaggio dei mistici cerca anch’essa sempre di palesare l’infinito, l’assoluto, l’indicibile, ed è per questo che “piaccia o no, il mistico avanza sull’orlo dell’eresia e sembra non avvertirne l’insidia”.
Lezioni radiofoniche
Contenuto audio
"I sermoni nel campo" di San Bernardino da Siena
RSI New Articles 13.10.1996, 02:00
"Un pomeriggio Adamo" di Italo Calvino
RSI New Articles 03.11.1996, 01:00
"Furto in una pasticceria" di Italo Calvino
RSI New Articles 27.10.1996, 02:00
"Il Baldus" di Teofilo Folengo
RSI New Articles 20.10.1996, 02:00
La satira dell'Ariosto
RSI New Articles 02.11.1997, 01:00
Variazione della "Ninna nanna"
RSI New Articles 19.10.1997, 02:00
"Facezie", di Poggio Bracciolini
RSI New Articles 26.10.1997, 02:00
"Il diavolo a Pontelungo" di Riccardo Bacchelli
RSI New Articles 09.11.1997, 01:00
"Fede e bellezza" di Niccolò Tommaseo
RSI New Articles 20.12.1998, 01:00
"Tre croci" di Federico Tozzi
RSI New Articles 10.01.1999, 01:00
"Encomio della pazzia" di Erasmo da Rotterdam
RSI New Articles 27.12.1998, 01:00
"La ricreazione del savio" di Daniello Bartoli
RSI New Articles 03.01.1999, 01:00