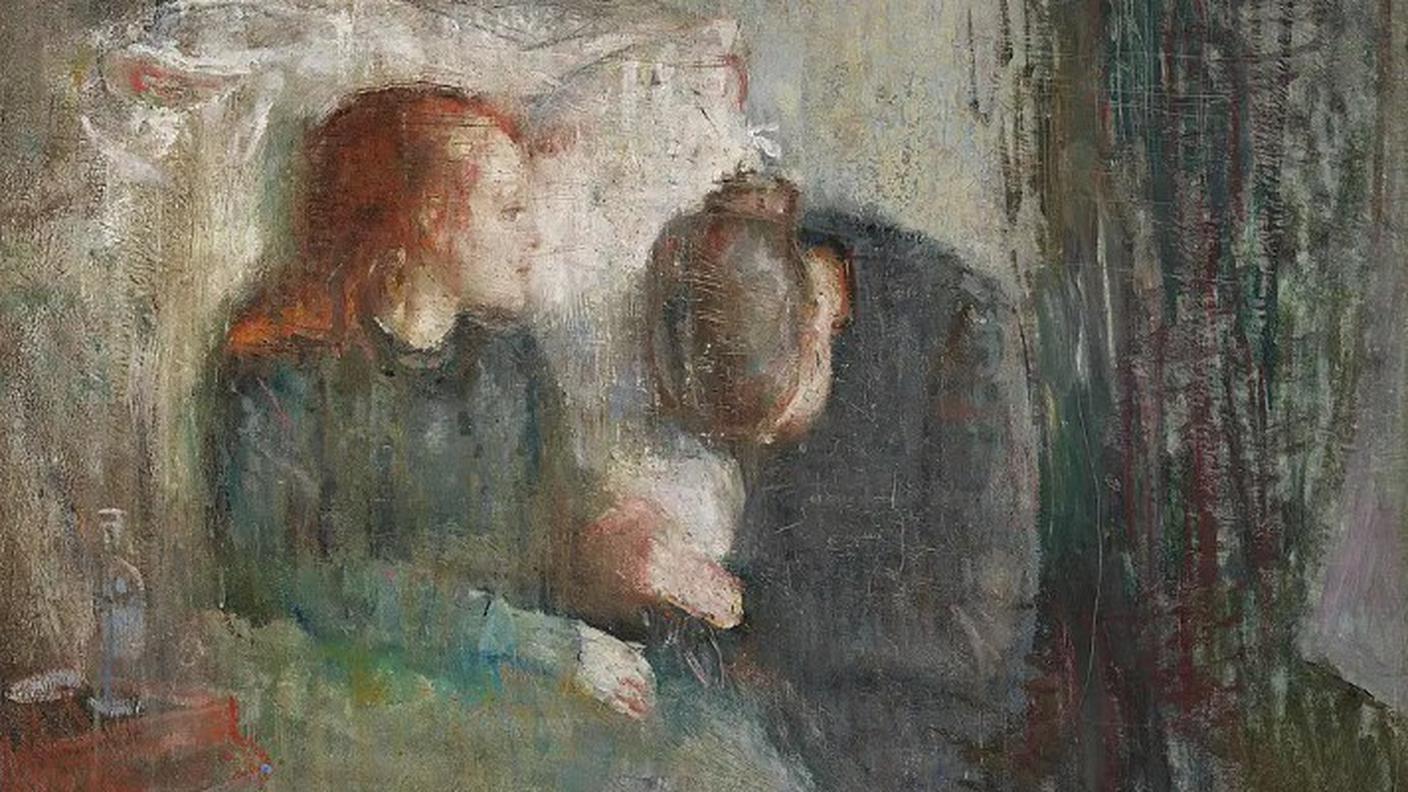Saas-Almagell, un villaggio vallesano incastonato tra le montagne, è il punto di partenza di una delle carriere più straordinarie nella storia dello sci alpino: quella di Pirmin Zurbriggen, classe 1963, 40 vittorie in Coppa del Mondo, quattro Coppe generali, otto di specialità, nove medaglie mondiali e due olimpiche, tra cui l’oro nella discesa di Calgary 1988 e il bronzo in gigante. Numeri che lo collocano stabilmente nell’Olimpo dello sci, ma che per lui non dicono tutto: “Alla fine, credo, che la fede sia un po’ la base di tutta la mia vita. Lo è ancora oggi. È la base della vita. È la ragione, la spiegazione di molte cose”.
Dall’uomo di Neanderthal ai campioni contemporanei
Tracce 04.02.2026, 14:05
Contenuto audio
Strada Regina lo incontra nell’hotel che oggi gestisce, dietro di lui le coppe di cristallo e le medaglie iridate e olimpiche compongono una specie di altare laico della sua storia sportiva. Zurbriggen le guarda con affetto, ma senza nostalgia: “Per me, non sono soltanto medaglie olimpiche: su quelle medaglie c’è inciso il volto di un indiano. E da bambino ero un grande appassionato di indiani; per me rappresentavano la base della vita, i valori, il contatto con la natura. E quando mi mettevano le medaglie al collo, durante le premiazioni, per me aveva un significato profondo”. Il simbolo della vittoria si intreccia così a un immaginario fatto di radici, essenzialità, rapporto con il creato.
Nei giorni dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, la vicenda di Zurbriggen mostra quanto dietro il gesto atletico ci sia un terreno più fragile e più vero, dove contano equilibri interiori e domande di senso. “Per me la forza, la base, è la famiglia. È lì che si trova il fondamento: capisci perché sei dove sei, se tieni duro o se cedi, se le cose vanno bene o male. Tutto dipende dalle persone che ti circondano”. In un’epoca in cui ogni atleta d’élite ha mental coach, psicologi, team di supporto, lui ricorda un’altra grammatica della resistenza: “Personalmente, io non avevo un mental coach o uno psicologo. Vedo sempre di più che la forza nasceva dal fatto che tutto era integrato molto profondamente nella famiglia, e non veniva da figure esterne”.
Questo radicamento non lo ha tenuto al riparo dalla pressione, ma gli ha dato strumenti per abitarla. Fin da ragazzo, quando lasciava casa per Coppe Europa e gare di alto livello, ha imparato a rileggere il proprio talento alla luce di qualcosa di più grande di una classifica. “Ho cominciato a conoscere la fede attraverso il mio percorso sportivo, cercando di unire le due cose. L’ho vissuto molto presto, già a quindici o sedici anni… Ho capito che poteva essere una grande forza, anche per alleggerire la pressione”. Nelle sue parole, la fede diventa una sorta di “preparazione psicologica” ante litteram, un modo per relativizzare il risultato senza sminuire l’impegno: “Non è il mondo che crolla se non riesci, non è che la tua vita cambia completamente”.
Nella relazione con Dio ha trivato una bussola per affrontare successi, infortuni e il dopo-carriera. Nelle grandi competizioni, ricorda, non mancavano momenti di raccoglimento condiviso: “Anche nelle grandi competizioni, come i Mondiali o le Olimpiadi, ci capitava qualche volta di avere la fortuna di partecipare a una messa, magari di un’ora. È successo a Crans-Montana, a Bormio, perfino a Calgary”. Oggi osserva con interesse i giovani che provano a integrare esplicitamente fede e sport: “Ci sono giovani austriaci, svizzeri, tedeschi che iniziano a parlare di questi temi, fanno piccoli libretti che distribuiscono agli atleti. Lo trovo molto bello, è una forza che continua a circolare”.
La pista, per Zurbriggen, è sempre stata anche un luogo di interiorità. Alle immagini degli atleti che si fanno il segno della croce in partenza, lui risponde con una propria liturgia silenziosa: “Ho visto molti italiani fare il segno della croce prima di partire: l’ho sempre trovato un gesto fortissimo. Io non riuscivo, perché in quel momento pensavo solo alla pista, alla gara”. Il suo “rito” era un altro: “Il mio momento di raccoglimento era ai cancelli di partenza: lì trovavo la forza, pensando che tutto ciò che avevo fatto mi portava a quella corsa. Il cronometro era il mio simbolo: un istante prima di partire, tutto si concentrava lì”. Il tempo, misurato al centesimo, diventa così spazio di concentrazione estrema ma anche di abbandono: hai fatto il possibile, ora “il resto non dipende solo da te”.
Dopo il ritiro a 28 anni, da vincitore dell’ultima Coppa del Mondo generale, Zurbriggen ha scelto una vita lontana dai riflettori, tra famiglia e attività di albergatore. Nel viaggio verso Milano-Cortina, l’eredità di Pirmin Zurbriggen non si esaurisce dunque nei record e nelle medaglie che hanno consacrato gli anni Ottanta della squadra svizzera come un’epoca d’oro dello sci alpino. La sua storia suggerisce che ogni tracciato, anche il più ripido, può diventare laboratorio di umanità: un luogo in cui la prestazione va in secondo piano e in primo entra la domanda su chi siamo, che cosa accade quando il cronometro si ferma, quali valori ci permettono di restare in piedi anche lontano dai riflettori. In questo senso, la neve di Zurbriggen parla anche a chi non ha mai indossato un pettorale: la vera vittoria, sembra dire, è trovare un equilibrio tra gloria e fragilità, tra la ricerca del risultato e quella di una spiritualità capace di illuminare le sfide di ogni giorno.