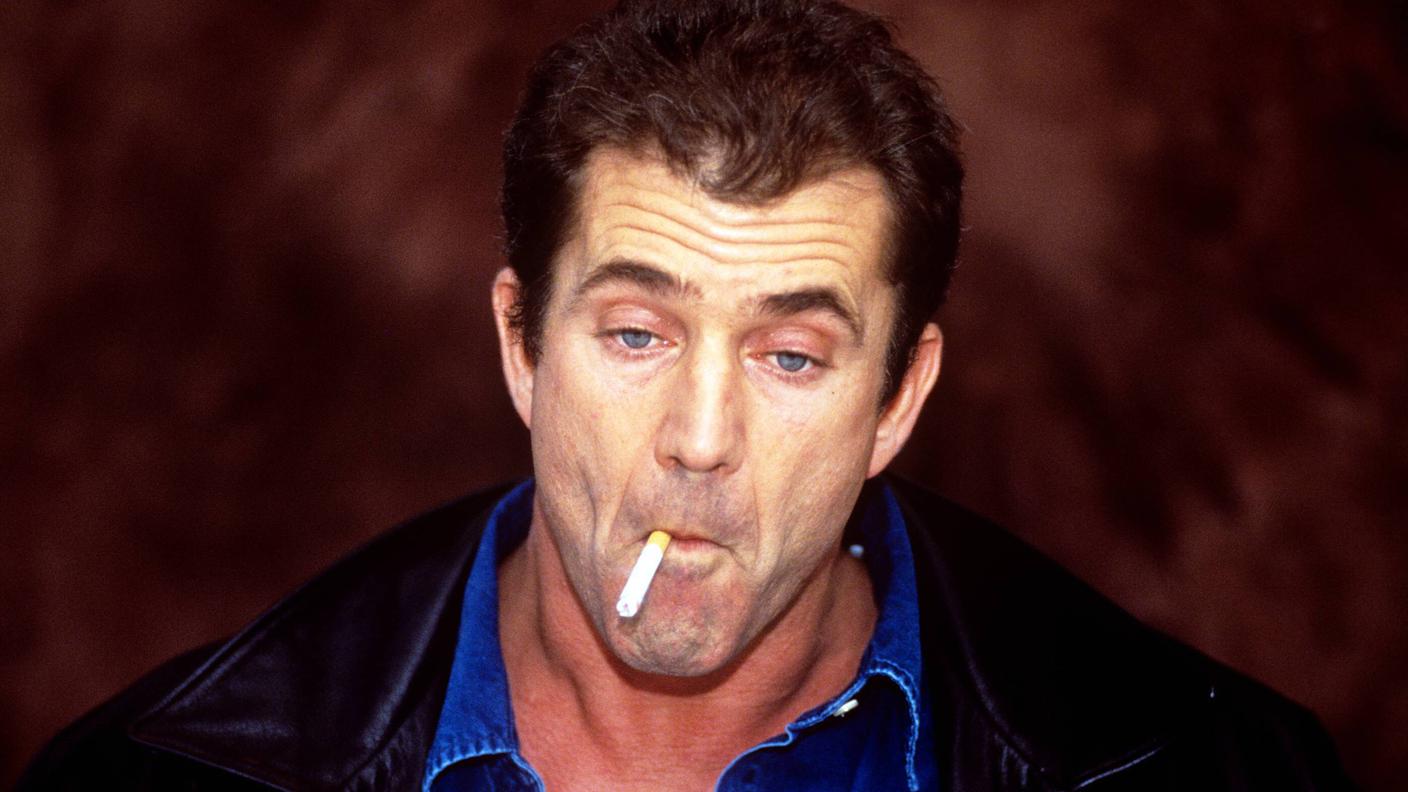Sotto il trucco da clown e dietro la risata isterica, si nasconde un uomo che sta andando in pezzi. Joker, il film di Todd Phillips vincitore del Leone d’oro di Venezia 2019, è solo un esempio di un approccio alla scrittura – o meglio riscrittura – di personaggi popolari che, senza paura di destrutturarne la mitologia, li rende più forti e complessi proprio rendendoli più fragili, umanizzandoli. Un uomo disperato, ai margini, debole, folle, alienato e pericoloso, questo è il Joker al quale l’interpretazione di Joaquin Phoenix ha dato corpo, conquistando prima il Golden Globe e poi l’Oscar 2020 per il migliore attore protagonista. Un personaggio che, nel film di Phillips, ricorda più il Travis Bickle di Taxi Driver di Scorsese (1976) che quello che molta gente si aspetta quando si parla di “cattivo da fumetto”. È nei fumetti infatti, quelli di Batman, che Joker nasce nel 1940 come uno degli antagonisti storici dell’uomo pipistrello difensore di Gotham City. Nel tempo il personaggio ha subito molte variazioni ed evoluzioni, passando dagli albi disegnati e la graphic novel ai film, alle serie tv, alle serie animate. In comune è rimasta la componente di follia, alla quale Phillips e il cosceneggiatore Scott Silver danno però una chiave di lettura totalmente realistica, spogliandola di ogni incursione nel fantastico e rendendola totalmente autonoma dall’ambito fumettistico. Niente cadute in vasche di sostanze chimiche, niente cicatrici inferte da un supereroe. Solo la violenza della società su una mente debole, un emarginato che in questo mondo non trova pietà. Siamo ben lontani dalla malvagità di un personaggio cattivo “perché mi disegnano così”, per dirla con Jessica Rabbit…
Dalla notte dei tempi, la complessità rende i personaggi più avvincenti. Quello dei fumetti portati sullo schermo, grande o piccolo che sia, è solo lo sfondo sul quale forse questo attualmente risulta più evidente. I supereroi del cinema arrivano in massima parte dai fumetti, ma sono stati i fumetti stessi a ripensarli negli anni e a umanizzarli nel male e nel bene. Quello che una volta era pensato per i ragazzini è stato consegnato a un pubblico adulto. Artefici di questa trasformazione nel mondo dei comics sono nomi come quelli – ormai stracitati – dei vari Frank Miller, Alan Moore, Neil Gaiman, più in là Garth Ennis e molti altri. I Batman del grande schermo firmati da Christopher Nolan, solo per fare un esempio, devono moltissimo a queste evoluzioni. Anche nelle franchise supereroistiche che in questi anni hanno fatto sfracelli ai botteghini, quelle per intenderci dove i loghi della Marvel o della DC Comics sono ben in evidenza a differenza del film di Phillips che mette questa discendenza in secondo piano fin quasi a cancellarla, tutte queste sfumature sono entrate, talvolta di soppiatto, talvolta prepotentemente. La cosa si fa esplicita ad esempio nel crepuscolare Logan (2017), il secondo film che James Mangold ha dedicato al popolare supereroe Wolverine degli X-Men, distante anni luce come tono dal suo precedente Wolverine – L’immortale (2013). In Logan – titolo che non per niente è il nome dell’identità umana del personaggio, come dire “l’uomo dietro la maschera” – il supereroe dagli artigli di adamantio è acciaccato, in declino, per quanto sempre capace di estrema violenza. Malato è il suo mentore, il Professor X e la salvezza passa dal sacrificio. L’umanizzazione però non ha sempre esiti drammatici. Negli Avengers campioni di incasso e dall’azione spettacolare senza compromessi, un personaggio invincibile come quello di Thor – che più che un supereroe è proprio una divinità – conquista la scena con i suoi atteggiamenti da sbruffone buono, con la sua continua competizione con il collega Hulk e strappa risate quando lo ritroviamo in piena crisi, mentre tutto intorno è l’apocalisse e lui se ne sta in pigiama, la barba incolta e con un pancione da incallito bevitore di birra, una specie Grande Lebowski piovuto giù da Asgard.
Nel mondo cinematografico, ancora prima dei super, tutto questo ha radici antiche. Questo germe di fragilità e di umanità che li rende più vulnerabili e vicini a noi, c’è già nei mostri classici, quelli in bianco e nero: l’uomo lupo, il mostro della laguna nera, la mummia, Frankenstein... Si è cercato qualche anno fa di resuscitare questo universo che fa capo alla Universal con il progetto Dark Universe. Ma qualcosa con il primo film – il remake de La mummia con Tom Cruise nel 2017, stroncato dalla critica e soprattutto non remunerativo quanto sperato – non ha funzionato. Illuminanti in questo senso le dichiarazioni del regista del film Alex Kurtzman al sito The Hollywood Reporter, dichiarazioni riportate in un articolo di Giuseppe Benincasa per Mondofox.it. “La Mummia non è quello che doveva essere – ha dichiarato Kurtzman – Non sono più coinvolto nel progetto e non ho idea di come continuerà”. Secondo l’articolo – citiamo – il problema era legato proprio alla figura della Mummia, che il regista vedeva “come un personaggio profondo e complesso, più di un semplice villain”. Una tesi avvalorata dalle parole dello stesso Kurtzman che, riferendosi ai vecchi film di mostri della Universal di cui il Dark Universe avrebbe dovuto essere la versione aggiornata, ha dichiarato all’Hollywood Reporter che “quei film [sui mostri classici] sono belli perché i mostri sono personaggi distrutti dentro, e noi ci rispecchiamo in loro”.
Non è questione esclusiva di supereroi o supercattivi, di mostri o fantascienza. Non inventiamo nulla, su questi argomenti sono stati scritti fior di saggi e studi. La complessità dell’animo, le sue debolezze e contraddizioni sono un ingrediente chiave per dare spessore ai personaggi: lo sanno bene i narratori di tutti i tempi, scrittori, oratori o sceneggiatori che siano. Solo che tutto questo risalta di più proprio laddove il personaggio è connotato da invincibilità e infallibilità, che sia dovuta a superpoteri oppure no. Vale in generale per gli eroi, che ci immaginiamo scolpiti nel marmo, e di conseguenza per i loro antagonisti. Un caso eclatante è quello dell’ultima incarnazione di James Bond, un personaggio cambiato rispetto al passato nei film che lo vedono impersonato da Daniel Craig. È uno 007 diverso da quello dei vari Sean Connery, Roger Moore o Pierce Brosnan, perfetti, impeccabili, ironici, in grado di uscire da una sparatoria o da un inseguimento in motoscafo e di andarsene senza soluzione di continuità a un cocktail party, senza un capello fuori posto, elegantissimi nello smoking d’ordinanza e con la bellezza di turno al loro fianco. Non che l’azione da supereroe senza superpoteri o le situazioni glamour manchino nei Bond con Craig, anzi ce ne sono pure di più e ancora più spettacolari grazie ai mezzi del cinema del nuovo millennio: l’adrenalinico trailer dell’imminente nuovo capitolo No Time to Die non lascia dubbi. Ma il suo è uno 007 più ombroso, terreno e vulnerabile. Vederlo legato a una sedia e brutalmente torturato in Casino Royale del 2006 – l’esordio di Craig nel ruolo – era qualcosa di praticamente impensabile fino ad allora. Un Bond che sanguina, non solo per le ferite del corpo ma anche per quelle del cuore visto che in quel film si innamorava solo per poi perdere tragicamente l’amata. Un Bond che nei film seguenti deve fare i conti con l’età che avanza e con le nuove generazioni che non capisce, con la perdita di una figura di riferimento come M., con il ritorno a casa e ai suoi fantasmi. Certo, non sarà stato solo questo a riportare 007 in cima al box office e nei cuori del pubblico. Ma di sicuro ha aiutato.