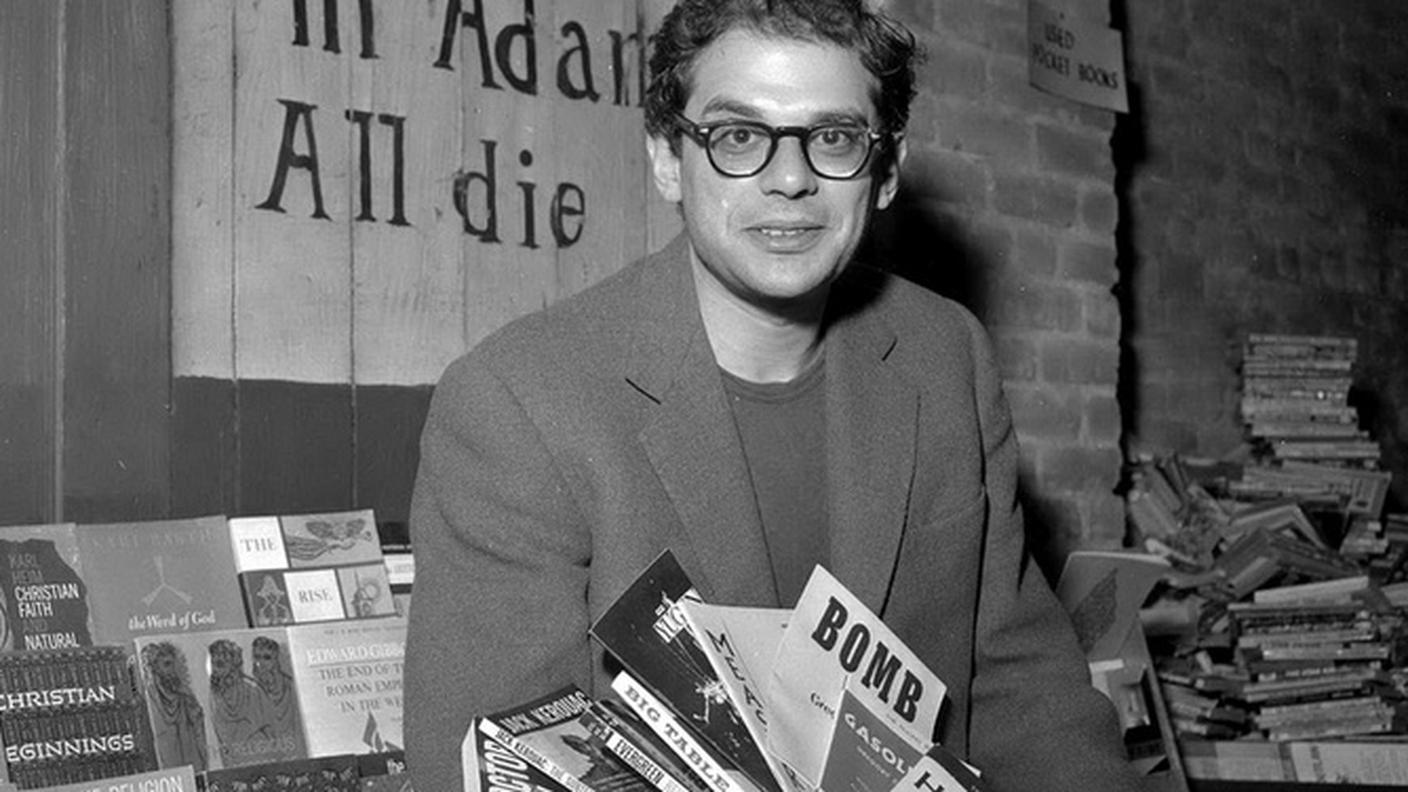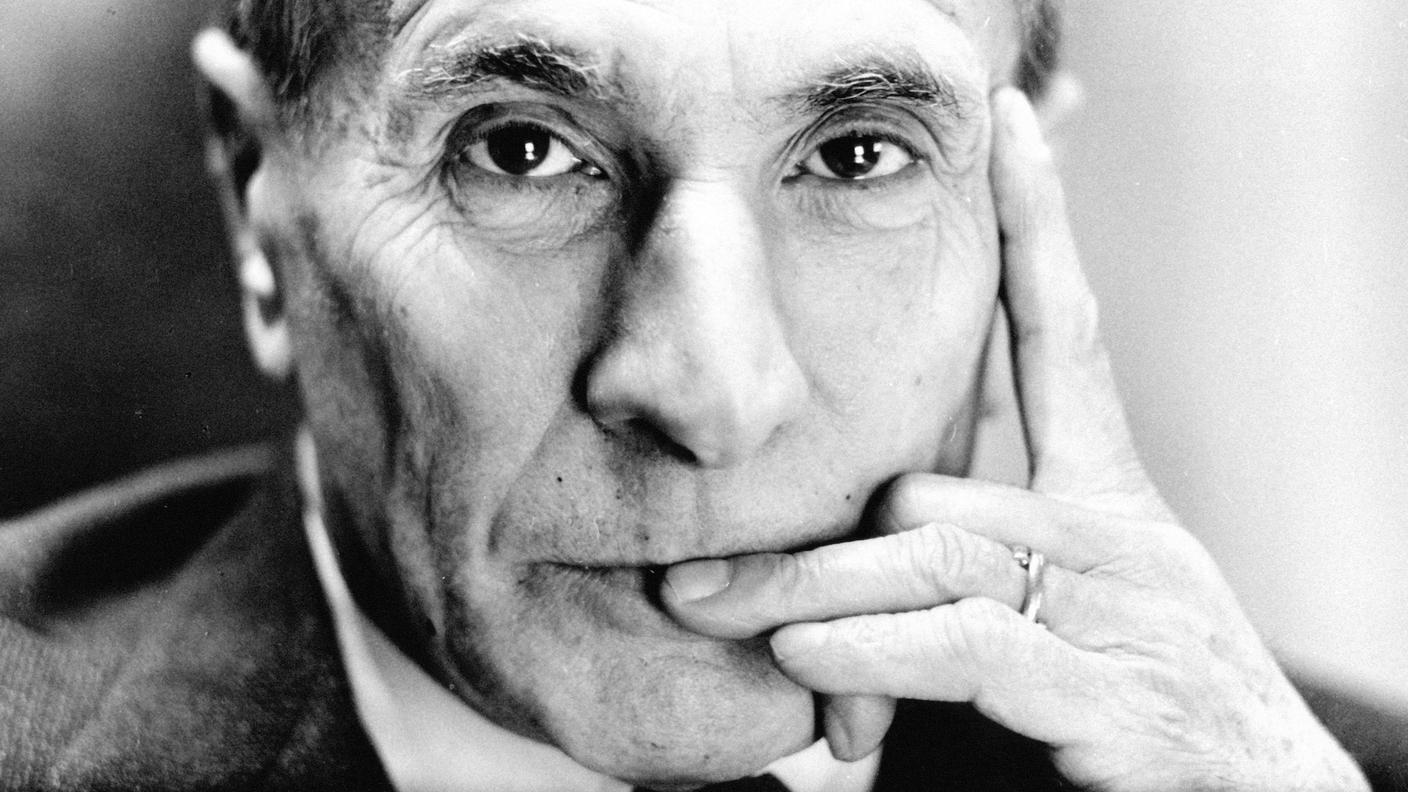Una volta Mario Vargas Llosa era venuto al Cairo, all’Istituto Spagnolo “Cervantes”, e aveva spiegato le ragioni per cui secondo lui i libri lunghi valessero di più dei libri brevi.
Fu una confessione per molti versi sorprendente. Non solo perché ci sono centinaia di capolavori che non superano le 150 o le 200 pagine – pensiamo a Morte a Venezia o alla Metamorfosi – ma perché il metro “quantitativo” rischierebbe a questo modo di premiare anche le dubbie pagine di uno Stephen King o di una Oriana Fallaci (penso all’improbabile epopea di Inshallah, in particolare).
Eppure quel parere così apodittico di Vargas Llosa ha una sua ragion d’essere. Non fosse che per la capacità dei cosiddetti libri lunghi – e ancora di più dei cosiddetti romanzi lunghi – di costituirsi come delle opere-mondo, in cui la lunghezza non è dilatazione fine a se stessa ma espressione di un universo altrimenti irraggiungibile.
O cosa sarebbe di una “sintesi” di Guerra e pace o dell’Idiota, della Montagna incantata o dell’Uomo senza qualità – per non parlare degli ancor più “canonici” Ulisse e Recherche – se non una loro radicale adulterazione? E soprattutto: come mai potremmo “entrare”, come si suol dire, in universi così complessi e articolati se la “quantità” non si alleasse – potremmo dire, sinergeticamente – con la “qualità”?
Ciò che la letteratura contemporanea ha – a partire da Joyce e da un certo Céline – di specifico rispetto al “tradizionale” romanzo lungo ottocentesco e primo-novecentesco – omettiamo per il momento opere-mondo come la Divina commedia, L’Orlando furioso o il Don Chisciotte – è però che al dato “quantitativo” molti romanzi lunghi accompagnano anche un linguaggio particolarmente complesso e sintatticamente denso. Ragione per cui ci troviamo di fronte non solo alla “fatica” di un testo sterminato, ma alla “doppia fatica” di un testo sterminato e linguisticamente di ardua decifrazione.
In questo quadro si stagliano diversi libri che si potrebbero definire, forzando la mano al lessico, delle specie di “piccole Bibbie” per amatori: dal Gioco del mondo di Cortàzar alla Vita. Istruzioni per l’uso di Perec all’Anima che fugge di Brodkey (di cui abbiamo già parlato). E su tutti, forse, per densità di linguaggio, un libro che richiama il meglio della cosiddetta “arte per l’arte” e il meglio della raffinatezza stilistica che si possa chiedere a un’opera di narrativa: Paradiso di José Lezama Lima.
Le 600 pagine del romanzo sembrano beffare in partenza, contro ogni aspettativa di intrattenimento facile, chiunque pretenda da un racconto prevalentemente una trama, un plot o una narrazione a suspence. Niente di tutto questo: il gusto, il tono del libro, il senso del libro, la sua magia, sono tutti racchiusi nella grazia della penna. E nulla è altrettanto edificante quando accorgersi, pagina dopo pagina, che l’autore non ci sta catturando in una storia propriamente intesa ma in una rete. E che in questa rete o ci si dispone a perdersi o si è – perdonate la contraddizione – perduti.
Inutile quindi riassumere le vicende che vi sono narrate: non è questo il romanzo a cui la storia offre se non un servizio ancillare. Il pregio di quest’opera per cultori decantata dallo stesso Vargas Llosa e dallo stesso Cortàzar, è semmai che ogni singolo paragrafo esalta l’immensità dell’esistente e della vita in quanto tale. Laddove una situazione narrativa “classica” sarebbe al più in grado di proporci un percorso di vicende tra loro allineate, qui si fa saltare il tavolo della linearità e si lascia esplodere la polifonia di colori, voci, sapori e dettagli che decantano il quotidiano.
Quindi ecco un libro per chi non cerca solo il finale, ma un’opera che risponde alle richieste di chi viceversa assapora le infinite circonvoluzioni e invenzioni dello spirito a contatto con la parola. Un’opera per devoti della letteratura e non per consumatori di storie. Un’opera che a buon diritto potrebbe figurare tra i libri-mastri del più giustificato e coerente manierismo contemporaneo. Di un autore di cui si sa troppo poco come troppo si sa spesso di troppi altri.