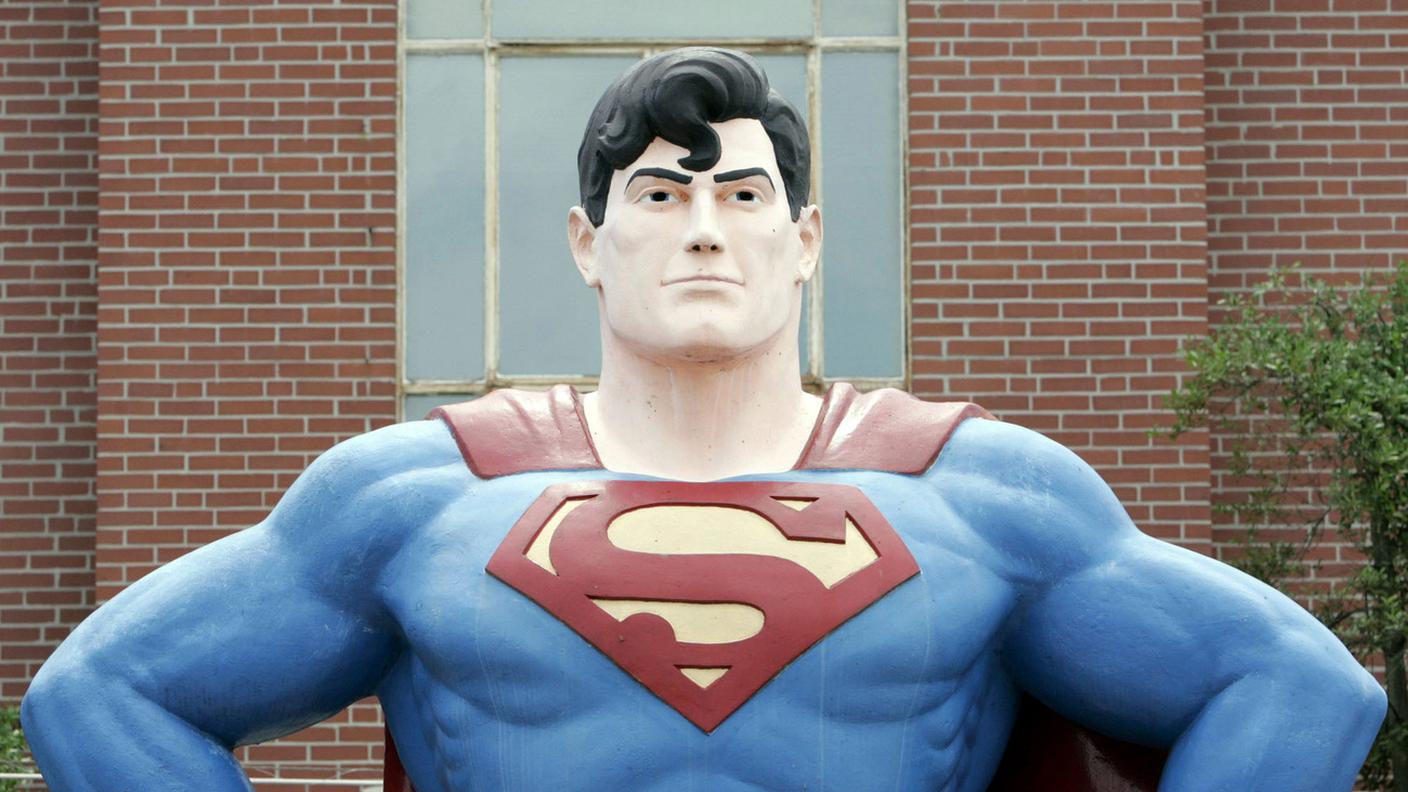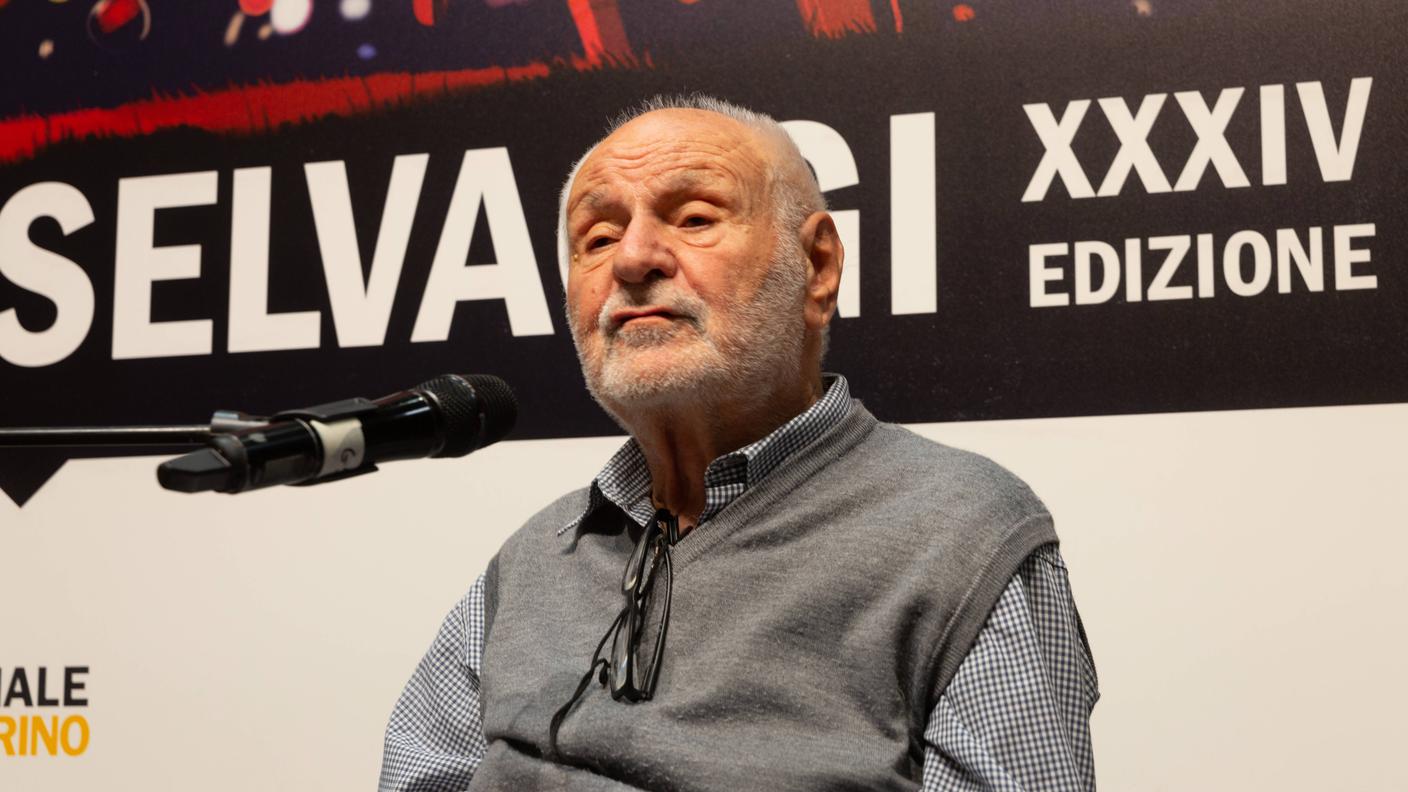Le grandi saghe familiari sono da sempre al centro della letteratura americana. E alla lunga lista di famiglie protagoniste di romanzi memorabili, si aggiungono i Van Lars, raccontati da Liz Moore nel suo Il dio dei boschi. I Van Lars - ovviamente, ricchissimi - si percepiscono dèi, dominatori della loro terra selvaggia, i monti Adirondack: un massiccio cristallino che attraversa lo stato di New York. Sugli Adirondack prende corpo un giallo, a partire dalla sparizione di una ragazzina, ospite di uno dei tanti campi estivi della zona.
Da quel mistero parte una trama complessa e stratificata, di quelle che hanno reso Liz Moore una delle scrittrici più lette negli Stati Uniti nell’ultimo decennio: ospite fissa delle classifiche dei best seller del New York Times, consigliata dall’ex presidente Barack Obama, lanciata da talk show storici, da Jimmy Fallon in giù. Ma se glielo chiedi, Liz Moore risponde che essere una scrittrice con dieci o dieci milioni di lettori, non cambia davvero il suo modo di scrivere: «Credo di essere sempre stata interessata alle cose che interessano a chi scrive: la storia, i personaggi, l’ambientazione… E questo non è cambiato affatto».
Al di là del successo di vendite, possiamo dire che Il dio dei boschi sia un successo letterario. Nel senso che è un mistery, ma è molto di più. È un romanzo che riesce a tenere insieme la facilità di lettura – quella che ti fa sfogliare una pagina dietro l’altra, quella che rende difficile posare un libro – con una grande complessità: conta decine di personaggi, e ognuno viene approfondito, ci viene raccontata la sua storia, le sue motivazioni. Ognuno ha un posto nella vicenda, che funziona (ed è questa la cosa davvero sorprendente) come un gioco a incastro tra linee temporali diverse, tra gli anni settanta e il presente. Uno si immaginerebbe un grande piano, un disegno architettonico che viene prima della stesura di un romanzo del genere, invece Liz Moore dice che no, lei non ama pianificare troppo.
Di solito riesco a capire quando arriva una nuova idea che mi piace, che mi entusiasma… ma le idee, anche quelle che mi entusiasmano, non sono necessariamente quelle che poi funzioneranno per il lettore. Tratto le idee nuove come qualcuno che conosco da poco, quindi le frequento per un po’, le sperimento, percorro quella certa strada e poi a volte scopro che in realtà anche se sono idee che mi piacciono, alla fine non sono adatte al libro che sto scrivendo. Allora torno indietro, torno all’ultimo punto del romanzo su cui mi sentivo sicura, e da lì procedo in una direzione diversa. Alla fine l’unico modo per sapere se un’idea funziona è provare a scriverla. In ogni caso, non mi piace fare troppi piani, quando scrivo. Non ho mai un programma preciso di quello che succederà. A volte magari disegno una mappa, per capire le ambientazioni, per sapere come si potrebbero muovere i miei personaggi nello spazio. Ma non pianifico mai in anticipo gli eventi di un libro, il che allunga un po’ i tempi di scrittura, credo… di solito mi ci vogliono circa quattro anni per scrivere un libro. Non sempre esattamente quattro anni, ma di solito, più o meno è così. Non sono un’autrice che può pubblicare un libro all’anno, questo è sicuro.
Liz Moore
“Il dio dei boschi” di Liz Moore, NNE (dettaglio di copertina)
Quattro anni non è poco, ma ora Il dio dei boschi fa funzionare perfettamente la macchina del suo intreccio, saltando avanti e indietro nel tempo come i film migliori di Quentin Tarantino.
Dunque, c’è stato un momento in cui ho provato a rimettere in ordine cronologico il racconto. Il libro inizia nel mezzo della vicenda: subito c’è la scomparsa di Barbara, rampolla della ricca famiglia proprietaria di questo campo estivo sui monti Adirondack. C’è stato però un momento in cui mi baloccavo con l’idea di mettere all’inizio una specie di prologo: due decenni prima, l’arrivo della madre su quei monti… ho sperimentato anche quell’idea, ma poi ho capito che il mio primo istinto era corretto. Mi piaceva l’idea di aprire proprio nel mezzo dell’azione, e poi andare avanti e indietro da lì, per mostrare al lettore lo svolgimento della storia.
In realtà nei miei libri comincio sempre dal luogo, poi passo ai personaggi e poi al problema fondamentale. Quindi la prima cosa a cui penso è: dove voglio che sia ambientato questo libro? Come voglio far sentire il luogo al lettore?
Poi, dopo penso a chi potrebbero essere i personaggi, e cerco di farmi un’idea precisa sulla loro personalità. E poi ancora, penso a quale sarà il primo problema che si presenterà nella vita dei personaggi. Nel caso del Dio dei boschi, quindi, tutto ciò che sapevo all’inizio era che il libro sarebbe stato ambientato nelle Adirondack Mountains negli anni Settanta. Che sarebbe stata la storia di questi personaggi ricchi, i Van Lars, che mandano la figlia al campo estivo da loro fondato. E che il problema sarebbe stato che lei scompare.
Ma non sapevo nient’altro. Quindi, credo che il modo in cui mantengo fresca la scrittura sia non sapere mai cosa scriverò finché non l’ho scritto. Ma devo essere sempre disposta a riconoscere che una parte della storia non funziona, che non sembra credibile, e quindi a tornare indietro, e pensare a un’idea diversa che sembri più corretta per lo sviluppo dei personaggi. Devo sempre confidare che i personaggi mi dicano cosa vorrebbero fare.
Al centro del Dio dei boschi c’è una ragazzina che scompare dal campo estivo, che per i ragazzi americani è da sempre un rito di passaggio, qualcosa di importante. E lo è stato anche per Liz Moore, ma, pare, non proprio in senso positivo. O almeno, così dice lei.
La mia esperienza personale al campo estivo non è stata una grande esperienza. Forse perché, come uno dei personaggi del libro, sono arrivato al campo estivo un po’ tardi, nel senso che avevo 12 o 13 anni quando ci andai per la prima volta, mentre la maggior parte degli altri bambini ci andava da quando ne aveva otto o nove, quindi c’era già un gruppo precostituito e io mi sono sempre sentita un po’ un’estranea. C’è, nel libro, un personaggio che vive una situazione simile… Comunque, anche se la mia esperienza personale al campo estivo non è stata un granché, rimane un rito di passaggio molto americano. Un sacco di ragazzi negli Stati Uniti hanno un ricordo davvero positivo del campo estivo.
Come spesso accade, Liz Moore riesce riesce a infilare nel giallo anche un grande discorso politico - o se non altro, socioeconomico: proprio al centro della storia c’è una potente famiglia capace di influenzare un intero territorio. E i soldi cambiano tutto. Anche la percezione che i ricchi hanno di sé.
Premesso che parlo solo delle famiglie americane, e della realtà americana, perché è quella che conosco, credo che le famiglie ricche, quelle capaci di creare una dinastia, abbiano una certa tendenza a credere in una specie di mito dell’autocreazione, cioè l’idea di aver costruito la loro ricchezza dal nulla, quando in realtà è necessario riconoscere che la maggior parte delle famiglie americane molto ricche ha costruito la propria ricchezza sfruttando il lavoro di altri, il lavoro della classe operaia.
La ricca famiglia che è al centro del Dio dei boschi ha questo difetto: i membri della famiglia non riconoscono mai che quello che li sostiene è il lavoro della classe operaia, si sono mitizzati, arrivano a chiamare la casa in cui vivono “fiducia in se stessi”, dal titolo di un saggio di Ralph Waldo Emerson. Pensano di poter contare solo su loro stessi, di non aver bisogno dell’aiuto di nessun altro. Ma è come se fosse un angolo morto nella loro visione del mondo, e non può che portare a conseguenze nefaste.
Tra personale e politico
Alice 05.07.2025, 14:35
Contenuto audio
Il dio dei boschi, grazie alla bravura di Liz Moore, funziona molto bene anche come una macchina del tempo, che ci porta indietro verso gli anni Settanta. Anni molto diversi dai nostri, sia per come funzionava la società, ma anche per come funzionavano le famiglie, e i rapporti tra genitori e figli.
Credo che se la storia si svolgesse oggi, nel nostro presente, i ricchi genitori di questi bambini che frequentano il campo tenderebbero a supervisionare in modo molto più stretto le vacanze dei figli, si intrometterebbero molto di più nella gestione del campo… Penso che molti bambini di oggi abbiano genitori iper-presenti, soprattutto i figli dei ricchi. Genitori del genere non permetterebbero ad esempio l’escursione che porta i bambini a passare tre notti in mezzo alla natura in modo molto indipendente.
Allargando lo sguardo, invece, una grande differenza, e una cosa che mi piace degli anni Settanta, è che si trattava di un periodo di grandi cambiamenti sociali, negli Stati Uniti e nel resto del mondo, e quindi esiste una tensione tra le zone rurali che racconti nel libro e il resto d’America. I personaggi percepiscono che ci sono grandi cambiamenti sociali in atto, cose che stanno avvenendo nelle città, che sono magari a quattro ore di viaggio da loro… percepiscono il cambiamento, ma non riescono a farne parte. Quindi nasce una sorta di nostalgia in alcuni personaggi, un rimpianto per i movimenti che stanno avvenendo a poche ore di distanza, più a sud, a New York.
Nella complessità della narrazione di Liz Moore, tutto si tiene: la descrizione della natura diventa descrizione dei cambiamenti sociali, e poi analisi delle personalità di personaggi che sono unici, e al tempo stesso tipi universali. Tutto per raccontare questo giallo, ma mettere insieme anche una parabola che pone dei problemi morali e sociali insieme.
Gli Adirondack sono monti situate nella parte settentrionale dello Stato di New York, e sono una catena montuosa separata rispetto alle Catskill mountain o agli Appalachi. Sono montagne molto belle, ancora molto selvagge, e hanno una storia moralmente complessa, nel senso che l’istituzione di una riserva naturale protetta alla fine del 1800 ha preservato il territorio, rendendo molto difficile ad esempio ogni nuova costruzione, il che lo ha reso molto bello oggi, perché è altamente protetto.
Ma si potrebbe anche dire che il Parco degli Adirondack sia stato creato principalmente per proteggere gli interessi dei ricchi che l’avevano eletto a loro residenza di vacanza, invece che per proteggere il territorio stesso, anche se alcuni potrebbero contestare questa mia affermazione. Però è un fatto, che solo dopo che alcune grandi famiglie americane hanno scoperto gli Adirondack, solo dopo che è diventato il loro parco giochi estivo, solo dopo il governo ha iniziato a interessarsi a quei luoghi, e a pensare di proteggere quelle terre istituendo una riserva naturale. Quando è stata creata la riserva però, paradossalmente ha distrutto il lavoro di molte persone che si guadagnavano da vivere sfruttando il territorio. Così si sono create delle sacche di povertà rurale in quella zona che esistono ancora oggi.
Famiglie come i Vanderbilt, i Roosevelt e i Rockefeller usavano gli Adirondack come residenza estiva, avevano le loro ville, eccetera. Sono stati loro a interessarsi per primi alla conservazione della natura, ma lo hanno fatto soprattutto per poter avere le loro ville in mezzo alla natura selvaggia, all’interno di zone protette.
Insomma, questa è una di quelle questioni complesse dal punto di vista morale, che come scrittrice mi piacciono molto. Mi piacciono sempre le storie che non sono completamente bianche o nere. È chiaro che è ottimo pensare a proteggere la natura, soprattutto oggi che stiamo rapidamente precipitando verso una crisi ambientale. Ma quella scelta ha anche messo a repentaglio il benessere economico di un’ampia fascia di popolazione che viveva su quel territorio all’epoca.
Credo che gli esseri umani abbiano la tendenza a incasinare la natura, in molti modi. Nel libro, cerco di mettere in evidenza come la natura abbia una doppia faccia, bella, ma anche pericolosa. E la natura deve essere rispettata dall’uomo. La natura è entrambe le cose, e spetta agli esseri umani che si muovono nella natura capire come coesistere con essa in modo che sia una relazione sana, invece che una relazione in cui l’uomo cerca solo di trarre profitto dalla natura.