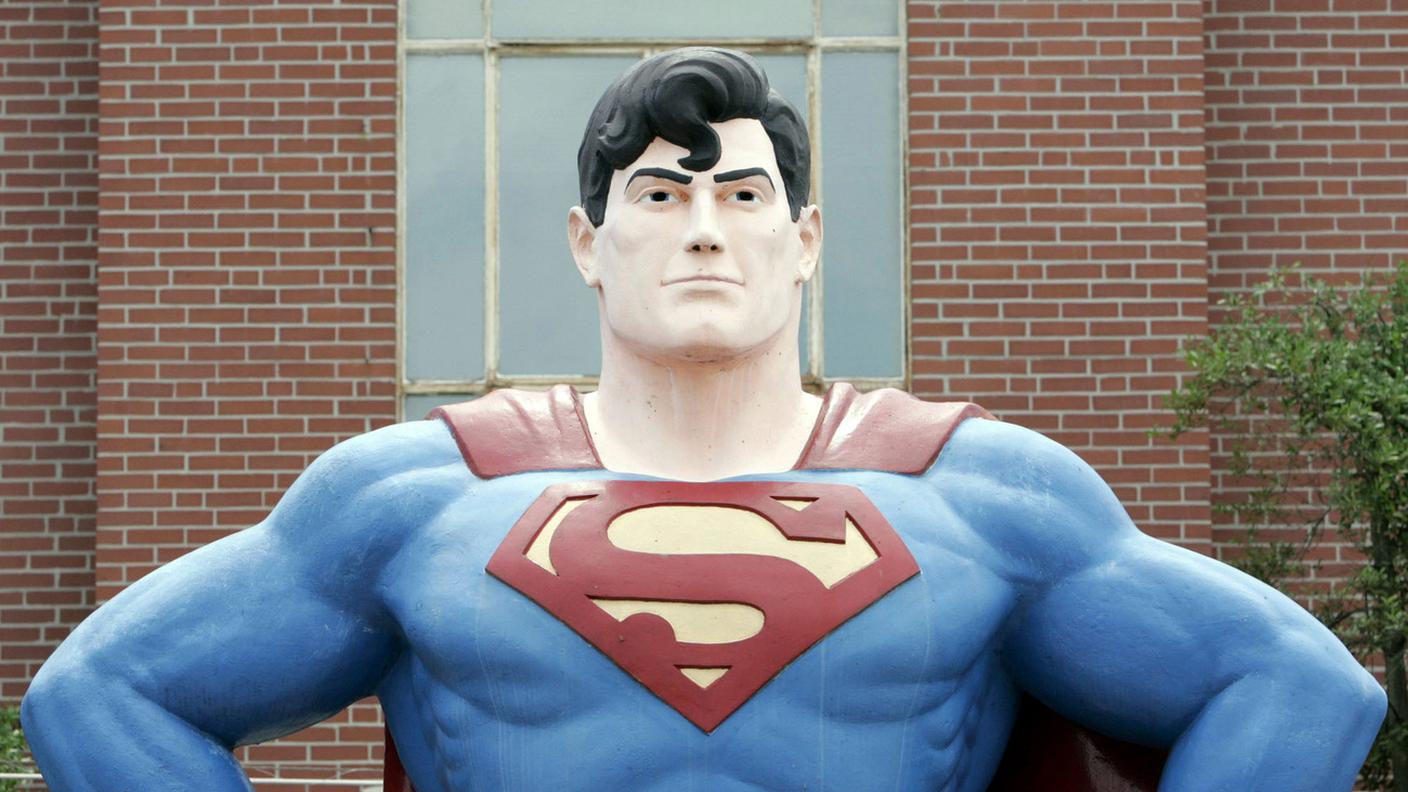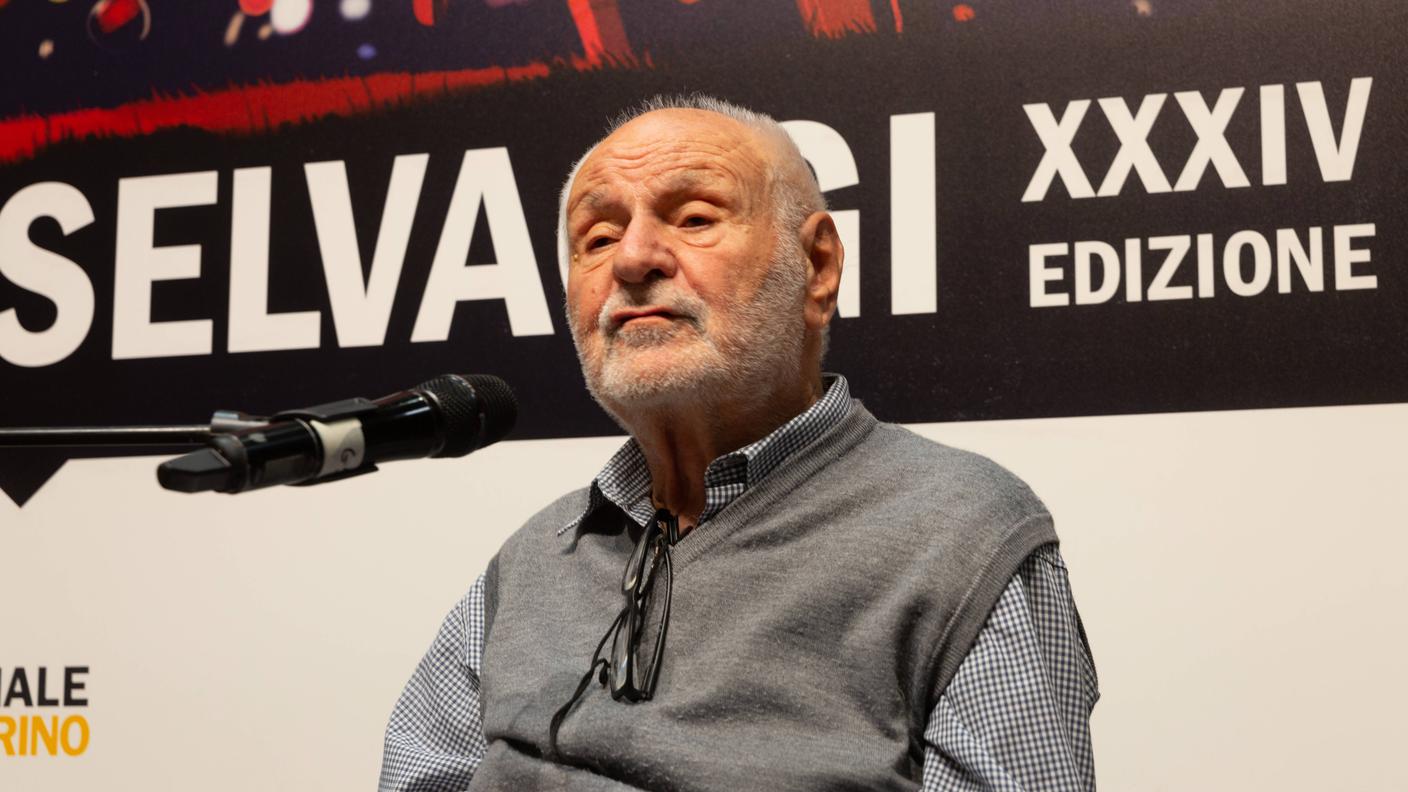Qualche settimana fa, in riva al lago, ci si chiedeva tra amici se il grande romanzo con la R maiuscola, il classicone dei secoli scorsi, quello che nella nostra crescita intellettuale era stato formatore di vita, esempio da prendere o evitare, scatola di sogni in cui evadere, fucina di prototipi di persone di cui fidarsi, invaghirsi o tenersi alla larga, esistesse ancora. Se il nostro specchio sul mondo in formato cartaceo funzionasse ancora. Se nelle narrazioni contemporanee ci fossero ancora grandi creazioni capaci di resistere nel tempo e di parlare alle generazioni successive, dire qualcosa di nuovo, riuscire a conquistare giovani donne e uomini degli anni a venire con storie universali.
Come a dire, non so se nella mia vita potrò ancora innamorarmi come quando avevo 18 anni.
Credo di no, non ci innamoreremo più come quando avevamo 18 anni, ma ci innamoreremo ancora, e in un altro modo. È l’impatto con l’amore e la lettura e con il mondo stesso a cambiare, nel tempo della nostra vita.
Per questa ragione, nonostante spesso si dica e si scriva il contrario, credo che il romanzo (inteso in senso classico, come testo in prosa che contiene la narrazione delle vicende di un individuo o di una famiglia su uno sfondo che può essere storico, fantastico o attuale e realistico) oggi sia in ottima salute. E sì, mi piace credere che alcuni suoi esempi potranno resistere negli anni e nei secoli (sempre che ci sia ancora gente che li legga, ma anche su questa ipotesi mi sento in questi giorni estivi piuttosto ottimista).
Porto qui quattro esempi – ce ne sono un’infinità di altri, ovviamente, e vi esorto a stilare delle liste sotto l’ombrellone in caso di noia - completamente diversi l’uno dall’altro, che negli ultimi anni hanno conquistato classifiche, premi e critica del mondo anglofono, e che a me hanno fatto tornare alla memoria antichi amori letterari (a volte proprio perché ne ripercorrono trama o intenzioni).
C’è un filo rosso che lega Il giorno dell’ape di Paul Murray, James di Percival Everett, Demon Copperhead di Barbara Kingsolver e Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo. Tutti rispondono alla domanda: esiste ancora, il grande romanzo?
Una volta si trattava di costruire mondi coesi, popolati da decine di personaggi, in cui le famiglie erano microcosmi della società. In cui le differenze di classe o il genere determinavano i destini di donne e uomini, e la Storia cancellava i sogni e riscriveva le realtà (Dickens, Flaubert, Mann o Tolstoj prima, Steinbeck, Faulkner, Morante, Ginzburg poi...). Oggi ritroviamo in romanzi come i quattro citati poco sopra la complessità del nostro tempo, raccontata nella maniera contemporanea. In un’epoca dominata da linguaggi brevi e narrazioni frammentate, queste opere conquistano per la loro ambizione di voler dipingere, anche attraverso storie fantastiche o epopee storiche, il nostro universo.
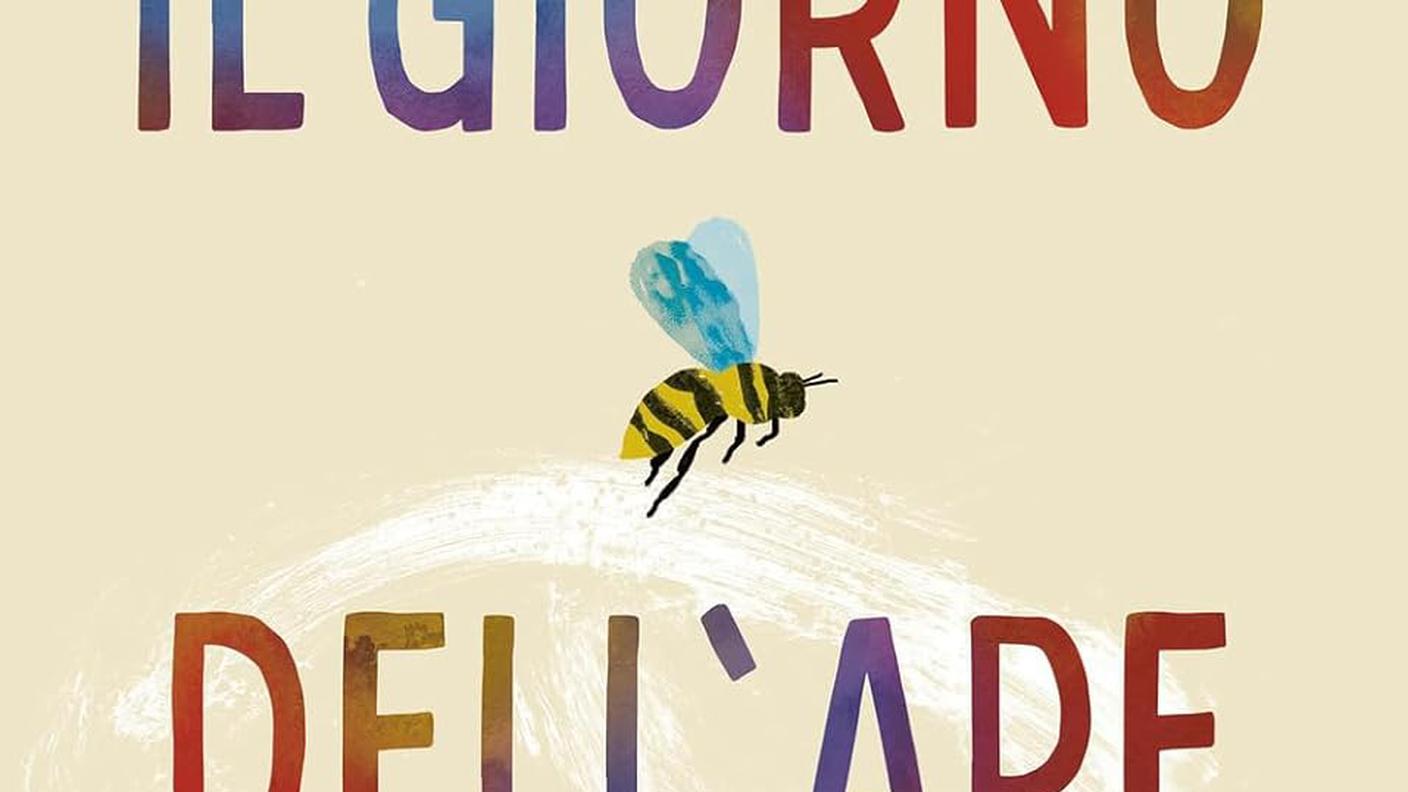
Il giorno dell'ape di Paul Murray, copertina
Paul Murray e la crisi della famiglia borghese. Con il clima che crolla.
Il giorno dell’ape , uscito per Einaudi lo scorso gennaio grazie alla traduzione di Tommaso Pincio, racconta la discesa della famiglia Barnes, alle prese con una crisi economica e personale che porterà tutti i suoi componenti sull’orlo dell’abisso. Dickie, il padre, invece di affrontare il fallimento della sua concessionaria Volkswagen e della sua identità, si rifugia nella costruzione di un bunker apocalittico. Imelda, la bella madre miss mancata, senza nessuna intenzione di tornare alla miseria del mondo da cui proviene, vende i mobili di design per far quadrare i conti di casa e costruisce legami col demonio, in buona fede. Cass, adolescente dalle grandi promesse e pessime frequentazioni, sabota il suo futuro scolastico mettendo a rischio la sua frequentazione al Trinity College. PJ, genio incompreso, figlio invisibile, progetta di scappare di casa. Come nei Buddenbrook di Thomas Mann o ne I Malavoglia di Verga, la crisi familiare diventa specchio di una società in decadenza. Ma se Mann raccontava il tramonto della borghesia mercantile ottocentesca e Verga quello di un’economia pre-industriale travolta dal progresso, Murray mostra soprattutto la frantumazione delle relazioni in un mondo dove la comunicazione è impossibile. «Perché nessuno vede quello che io vedo?», si chiede Cass. «Perché ognuno è chiuso in un silenzio più grande del bunker di papà?».
In questo romanzo emerge poi una nuova angoscia collettiva: la crisi climatica. L’ossessione di Dickie per il suo rifugio antiatomico non è solo paranoia o complottismo, ma un riflesso di paure reali e globali (nel romanzo assistiamo anche a una di quelle tremende alluvioni che sempre di più invadono i nostri tempi). L’idea di un collasso ambientale si intreccia alla disgregazione del proprio piccolo mondo e diventa il simbolo di una società che, davanti al disastro, preferisce prepararsi all’apocalisse piuttosto che cambiare rotta, o comunicare.

James, di Percival Everett
Percival Everett e la libertà negata
James, uscito nella traduzione italiana ad opera di Andrea Silvestri per La nave di Teseo la scorsa estate, riscrive radicalmente Le avventure di Huckleberry Finn del buon Mark Twain. Everett narra la storia dal punto di vista dello schiavo Jim, qui James, restituendogli la dignità identitaria, poiché Jim era il nome dato genericamente a tutti gli schiavi. E qui James è un uomo colto e lucido, che deve fingere ignoranza per sopravvivere ai padroni bianchi. La comparazione tra passato e presente è facilitata dalla riscrittura: se Twain celebrava la fuga adolescenziale come promessa di libertà, quella di Huck, James mostra il prezzo di quella libertà. «La mia intelligenza era l’unica cosa che nessuno poteva portarmi via. E così la nascondevo». La fuga non è più un sogno americano, ma la lotta disperata per la dignità in un sistema che considera gli afroamericani meno che umani.
La natura lungo il Mississippi, che in Twain era un luogo di avventura e possibilità, diventa in James un territorio di sorveglianza, pericolo, controllo. La dimensione ambientale è presente nel paesaggio della schiavitù e dello sfruttamento coloniale, eco delle monoculture di cotone che distrussero territori e vite umane, ricordandoci che la devastazione climatica di oggi nasce anche da quella storica radice di dominio.
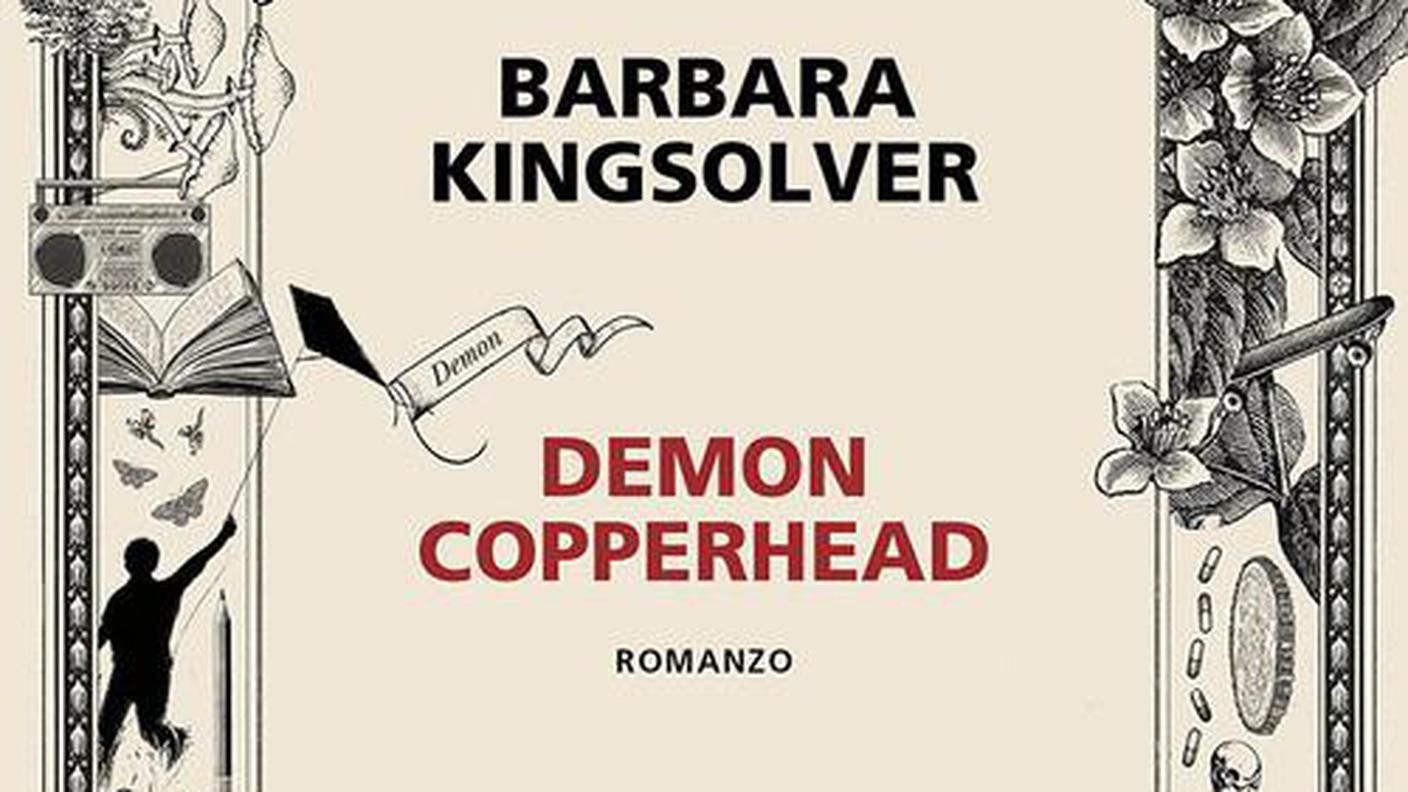
Copertina di Demon Copperhead, di Barbara Kingsolver
Barbara Kingsolver e il riscatto dickensiano
Altro esempio di ispirazione dichiarata è quello di Demon Copperhead, capolavoro del 2023 a opera di Barbara Kingsolver, per noi da Neri Pozza con la traduzione di Laura Prandino. L’autrice rilegge David Copperfield nel cuore depresso dell’America rurale contemporanea.
Demon nasce povero nella Virginia degli Appalachi colpita dalla crisi degli oppioidi, passa attraverso famiglie affidatarie violente, abusi, droga. Poi si riscatta, e dopo ancora ricade più giù, e noi non possiamo far altro che seguire con il respiro mozzato la sua epopea, in cui tra tanto male esistono per fortuna anche poche (pochissime) persone buone; dove l’amore distrugge, ma a volte può ricostruire, e l’intelligenza lo salva, fino a fargli trovare la propria voce. Come Dickens, come Steinbeck, Kingsolver crea un legame immediato tra lettore e protagonista: «La mia storia è quella di tanti altri qui, ma se nessuno la racconta, chi ci sentirà mai?». Ma mentre Dickens scriveva in un mondo di ingiustizie e progresso, Demon cresce in un’America senza via d’uscita.
Il romanzo racconta poi di una terra devastata dall’estrazione mineraria e dall’inquinamento, con paesaggi feriti che rispecchiano i corpi feriti dei personaggi. Le colline dell’Appalachia, scavate fino all’osso, diventano metafora di un mondo che non si prende cura né delle persone né della natura.
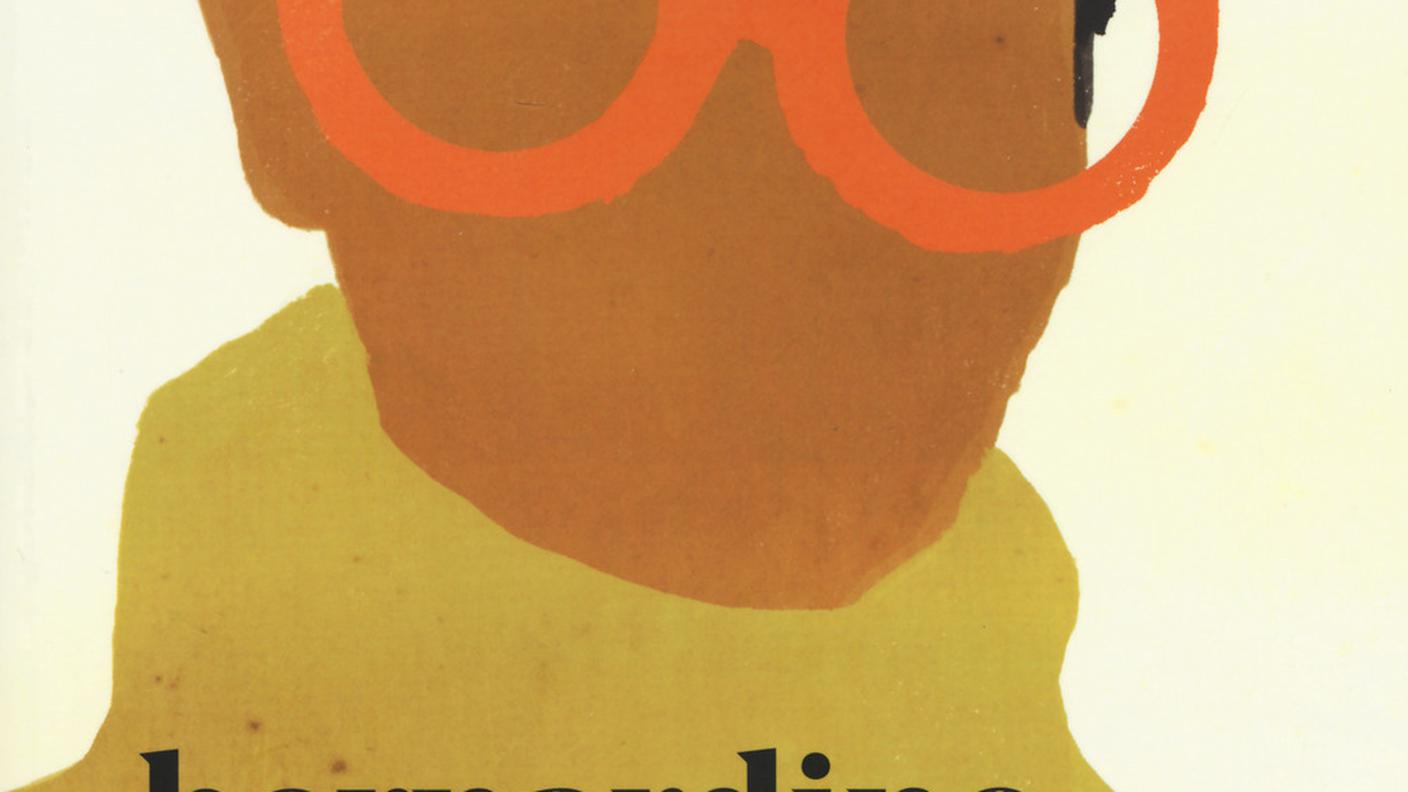
Ragazza, donna, altro di Bernardine Evaristo, copertina
Bernardine Evaristo e il coro delle voci afro-britanniche
Ragazza, donna, altro, Edizioni Sur 2020 con la traduzione di Martina Testa, è un ulteriore esempio di come un coro di voci possa raccontare una Storia collettiva. Più lontano degli altri tre nel tempo, è in realtà quello che più aderisce alla contemporaneità. Intreccia le storie (sentimentali, sessuali, familiari e professionali) di dodici donne nere e di sangue misto, giovani e anziane, in un mosaico che sfida la struttura lineare del romanzo tradizionale. Con una prosa poetica e una liberissima punteggiatura, Evaristo costruisce un coro di voci femminili: artiste, migranti, attiviste e lavoratrici che si confrontano con il razzismo, il sessismo, l’eredità coloniale e la ricerca di identità. Ieri e oggi. Le loro storie sono cucite insieme come in un arazzo, nel quale le loro vite, e quelle degli uomini che le attraversano, formano un’anticonvenzionale e appassionata rilettura di un secolo di storia inglese.
Come James, anche questo romanzo parla di libertà e dignità negate. Ma se Everett riscrive un classico americano da dentro l’esperienza della schiavitù, Evaristo crea un polifonico romanzo di formazione collettiva.
Cosa hanno in comune con le opere del passato? Sono spesso saghe con diversi personaggi che incarnano tensioni collettive, e raccontano crisi famigliari, sociali e ambientali da fin de siècle (come nei Buddenbrock, per esempio, in Anna Karenina o Furore); in tutto questo i personaggi cercano quel riscatto o libertà che andavano chiedendo anche David Copperfield e Huckleberry Finn. E seppure abbiano anche delle differenze marcate rispetto ad alcuni tratti dei classici della letteratura otto-novecentesca - non credono più in un ordine narrativo “totale” (Murray), decostruiscono la lingua (Everett), frammentano la narrazione in un flusso poetico e politico (Evaristo) - rimangono specchi potenti del nostro tempo.
Forse non saranno mai delle lenti universali come I fratelli Karamazov, ma sicuramente contribuiranno ad aiutare nella costruzione di un pensiero collettivo che possa affrontare il clima, le relazioni e le identità di oggi. E rimangono romanzi grandi, proprio perché ci ricordano a modo loro che la letteratura non è qui a darci pacchette sulle spalle, ma a rivelare quel che non conosciamo,o che non vogliamo vedere, e a dirci che, in fondo, siamo tutti uguali - in modi infinitamente diversi. Così come abbiamo tanti modi diversi di innamorarci.