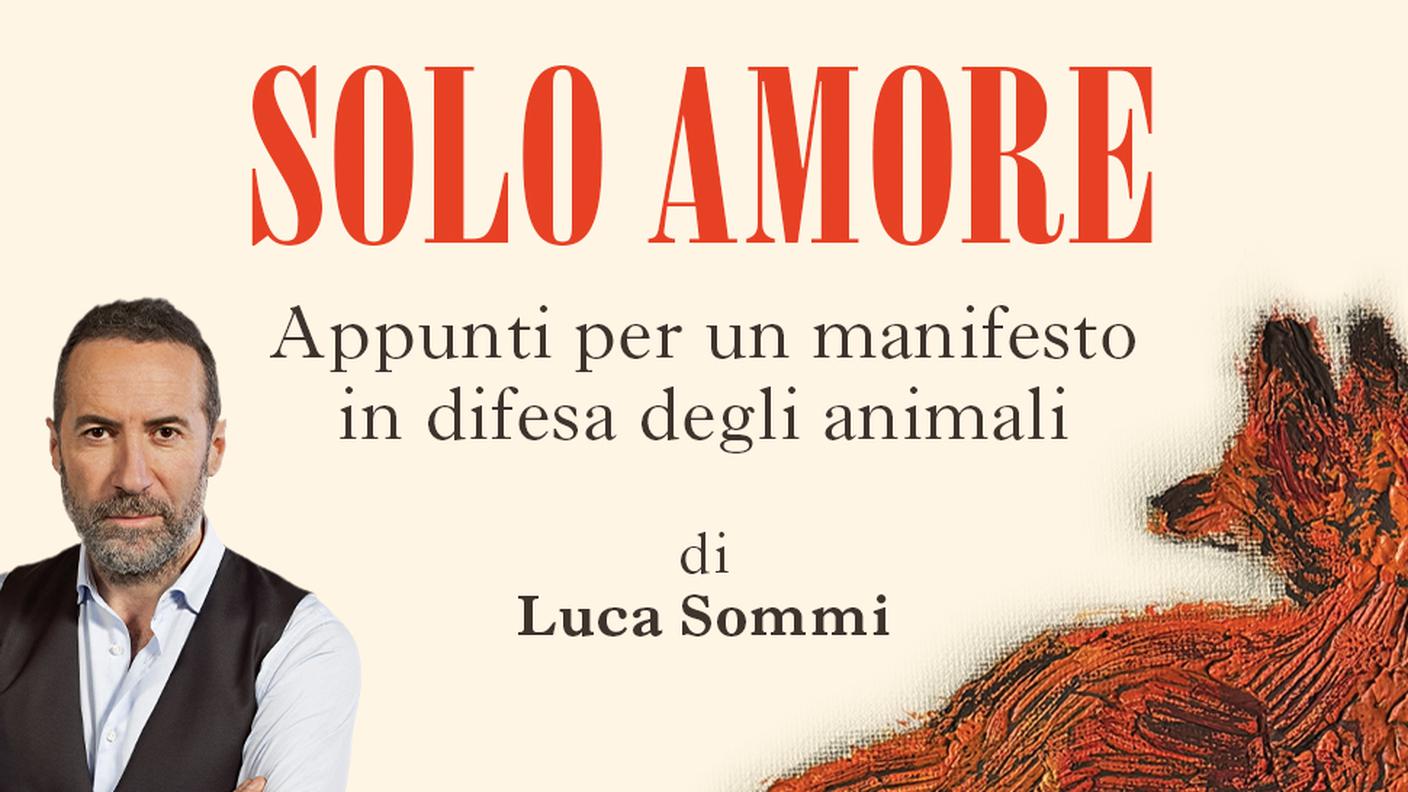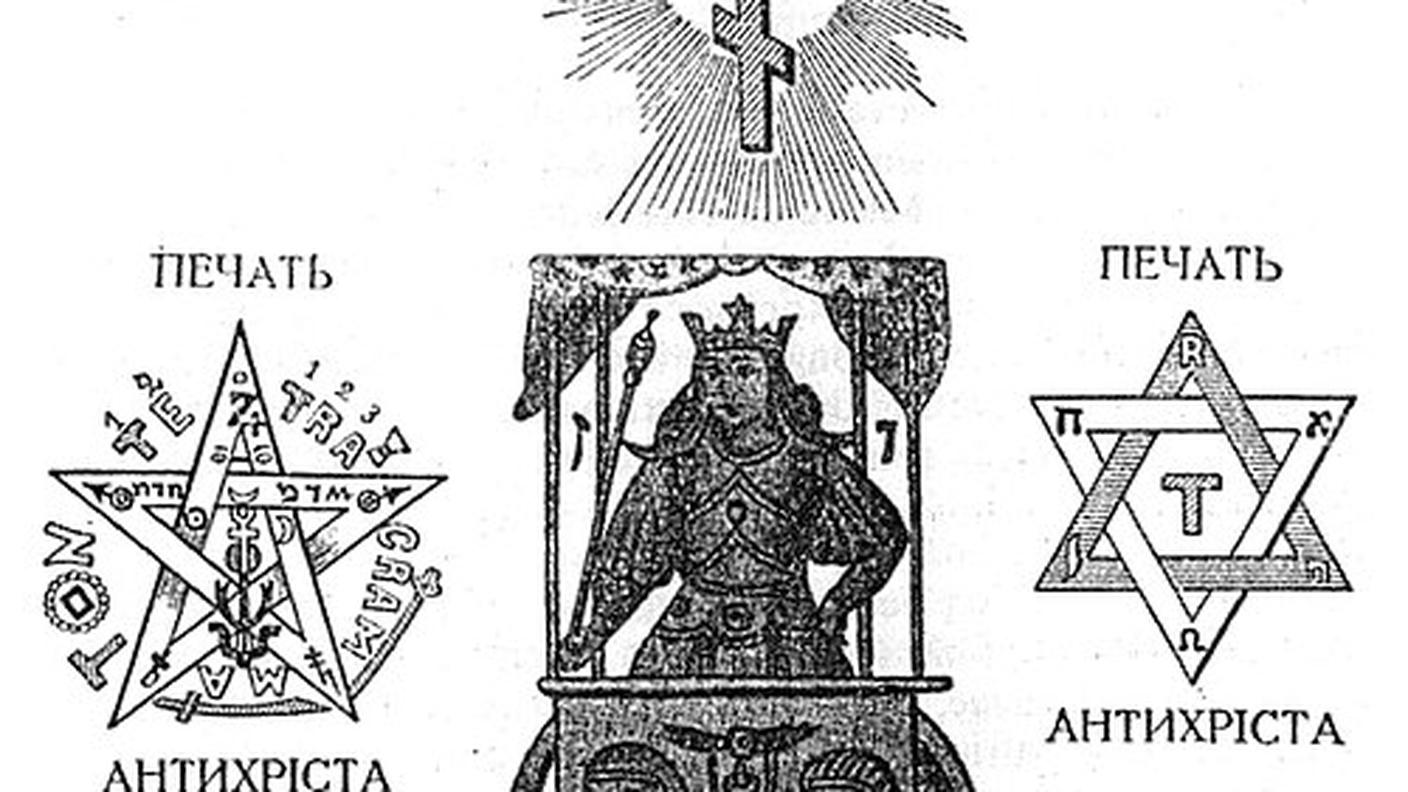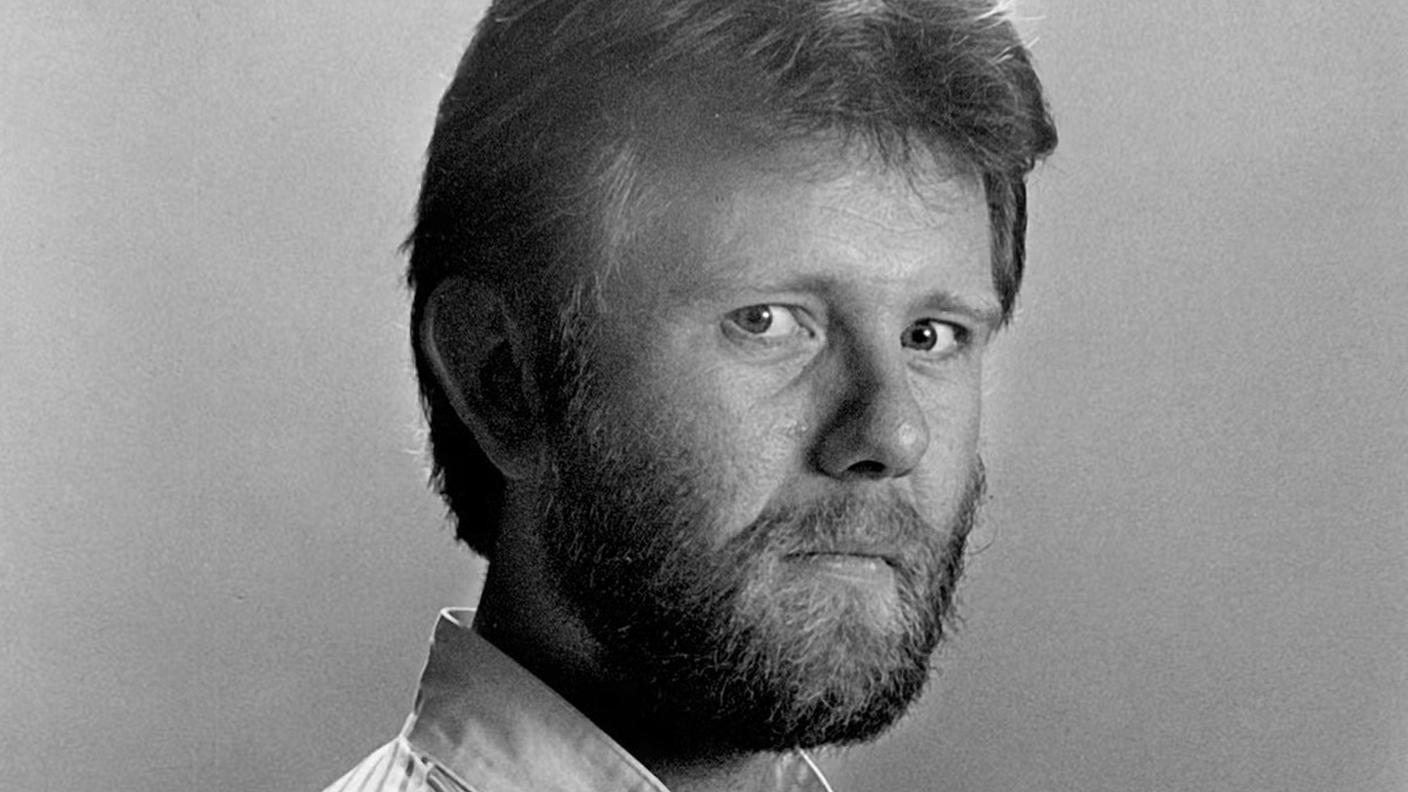Lo scrittore spagnolo Enrique Vila-Matas lo ha definito “il labirinto del no” e gli ha dedicato un bel libro pubblicato anche in versione italiana circa vent’anni fa col titolo “Bartleby e compagnia”. E’ il labirinto nel quale si sono persi e smarriti (o forse si sono ritrovati) tutti quegli scrittori che secondo lo stesso Vila-Matas sono caduti vittime della cosiddetta “sindrome di Bartleby” e quindi, come l’omonimo personaggio di Melville, hanno risposto “preferisco di no” ai presunti obblighi della creazione e alle pretese dell’industria editoriale.
Tra gli scrittori che hanno risposto “preferisco di no” e hanno smesso improvvisamente di scrivere ci sono alcuni grandi nomi della storia letteraria -Rimbaud, Walser, Salinger, e altri ancora-, tutti mossi da diverse motivazioni ma uniti dal rifiuto, dalla negazione e soprattutto dal silenzio. Poi ci sono i libri che dicono l’impossibilità di scrivere, come la “Lettera di Lord Chandos” di Hofmannsthal, e quelli mai scritti, come il fantomatico e leggendario “Garçon” di Flaubert. E’ insomma un silenzio multiforme e ricco di screziature, sul quale si è molto discusso e che è stato anche molto romanzato (per non dire banalizzato e mitizzato), ma nel suo nucleo più profondo restituisce un enorme interrogativo.
C’è comunque un personaggio che più di ogni altro sembra incarnare la “sindrome di Bartleby”, perché l’ha portata alle estreme conseguenze e in un territorio che sembra perfino situarsi oltre il silenzio comunemente inteso: il suo nome è Roberto Bazlen. Nato il 10 giugno 1902 a Trieste, che al tempo era un grande crocevia culturale nonché lo sbocco sul Mediterraneo dell’Impero Austroungarico, Roberto “Bobi” Bazlen fu anzitutto un lettore onnivoro («aveva letto tutte le opere in tutte le lingue», ha scritto di lui Vila-Matas) e collaborò in qualità di consulente prima con Einaudi e infine con Adelphi, la casa editrice alla quale contribuì a dare quell’impronta che ancora oggi, a quasi sessant’anni dalla fondazione, rimane un marchio di fabbrica.
Quando morì a Milano, nel luglio 1965, Bazlen aveva infatti lasciato dietro di sé un’infinità di pagine di consigli editoriali che contribuirono a sprovincializzare la cultura italiana e introdussero autori come Jung, Musil, l’amatissimo Kafka, il sulfureo e fino a quel momento “impresentabile” Artaud, Arnold Zweig e Heinrich Mann, solo per citare alcuni nomi, ma la lista è lunghissima. La sua cultura sterminata e la sua quasi prodigiosa facilità e leggerezza di scrittura gli avrebbero permesso di scrivere con ottimi esiti anche in prima persona, sia nel campo della narrativa che in quello della saggistica. Ma Bazlen non lo fece, rispondendo “preferisco di no”. Il perché di questo rifiuto è spiegato nelle sue “Note senza testo”, una raccolta di appunti pubblicata per la prima volta da Adelphi nel 1970: «Io credo che non si possa più scrivere libri -osserva Bazlen con una delle sue tipiche sentenze lapidarie-. Perciò non scrivo libri. Quasi tutti i libri sono note a piè di pagina gonfiate in volumi. Io scrivo solo note a piè di pagina».
L’affermazione, di vago sapore borgesiano, è molto estrema e in ultima analisi non tutto condivisibile, soprattutto se espressa in maniera così perentoria. Ma non si può negare che la sua intima fascinazione sia enorme. Non è quindi un caso che uno dei giudizi più onesti ed equilibrati sulla scelta di Bazlen lo abbia fornito un altro scrittore/non scrittore, Giorgio Voghera, che si tenne sempre molto appartato e fu estremamente restio alla pubblicazione e alle ribalte letterarie. Triestino come Bazlen, e suo amico fin dai tempi di gioventù, Voghera ha tracciato un mirabile ritratto di Bazlen in un libro di ricordi intitolato “Gli anni della psicanalisi”: «Bazlen -ha scritto Voghera- non era inquadrabile in alcuna categoria né cercava di appartenere ad alcun gruppo, non imitava nessuno e non si poneva nessuno a modello. Era se stesso con una spontaneità e un’autenticità che ben di rado si trovano nelle persone adulte. Piuttosto, nei bambini e negli animali». Voghera chiude il ritratto citando una frase di suo padre Giorgio, presunto autore de “Il segreto”, uno grandi capolavori nascosti della letteratura italiana del Novecento: «Bobi disprezza l’intelligenza perché ne ha troppa».
Il disprezzo dell’intelligenza per eccesso di intelligenza: è questa, con ogni probabilità, la chiave per penetrare nel mistero di Roberto Bazlen. E che Bazlen di intelligenza ne avesse molta, perfino in eccesso, si nota dall’insieme dei suoi scritti, che Adelphi ha raccolto e pubblicato nel 1984 e in seguito ristampato nel 2002 in occasione del centenario della nascita (la nuova edizione economica è uscita negli scorsi mesi). Oltre alle “Note senza testo”, il libro contiene i frammenti di un romanzo incompiuto (ma nel senso più nobile e “schubertiano” della parola) dal titolo “Il capitano di lungo corso”, le belle e affettuose “Lettere a Montale” (fu Bazlen a coniare il celebre soprannome di Eusebio, mutuato dall’Eusebius di Schumann) e soprattutto le “Lettere editoriali”, che rappresentano la cifra più autentica della sua smisurata intelligenza. Leggendole, infatti, si ricava l’impressione che Bazlen sapesse davvero tutto e avesse letto tutto. I suoi giudizi sui libri altrui, inoltre, sono sempre perfetti, di una precisione chirurgica, scritti in un italiano ricco e pastoso che ci rimanda a una stagione culturale che purtroppo si è definitivamente conclusa.
Uno dei più grandi “scrittori del no”, Robert Walser, diceva di non augurare a nessuno «di essere come me: di sapere tante cose, di avere visto tante cose e di non avere nulla, così nulla da dire». Sono parole che forse valgono anche per Bazlen. Che sapeva tante, troppe cose, ed è giunto alla medesima conclusione: in fondo, non c’è nulla da dire. Rimane solo da chiedersi, ed è il grande interrogativo che lo stesso Bazlen ci ha lasciato involontariamente in eredità, in quali abissali profondità affondi le proprie radici una simile consapevolezza: «Un tempo -dice una delle “Note senza testo”- si nasceva vivi e poco a poco si moriva. Ora si nasce morti, e solo alcuni, poco a poco, riescono a diventare vivi».