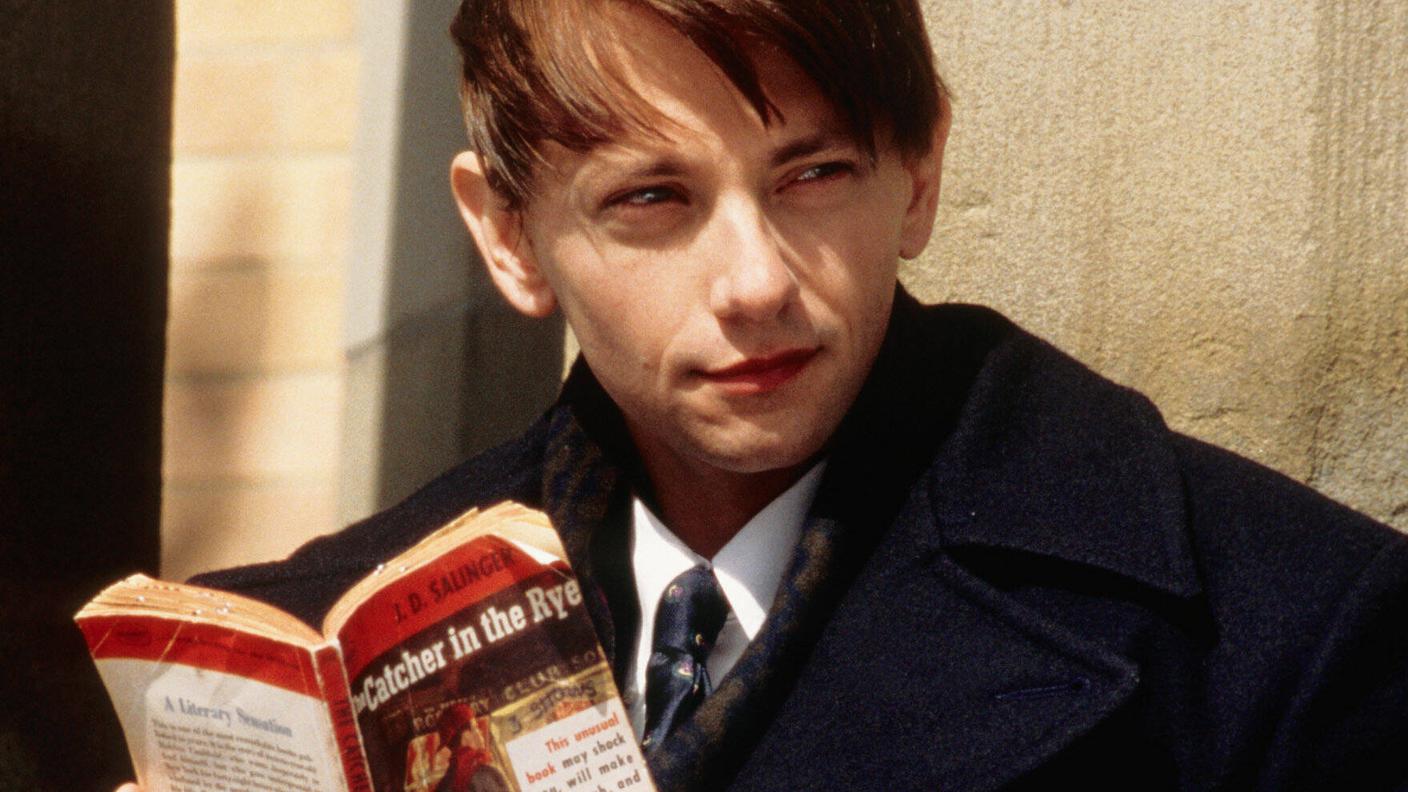Ci sono molti modi per “raccontare” e “raccontarsi”, che a ben vedere sono più o meno la stessa cosa, perché si è capito che l’utopia flaubertiana del mot juste, la “parola esatta”, è destinata a rimanere tale. Lo stesso discorso vale per il “grande stile”, il “narratore onnisciente” e più ancora l’impersonalità della cosiddetta narrazione “totale”, che avrebbe dovuto risolvere nella figurazione artistica e nella reinvenzione letteraria la magmatica e sfuggente complessità del reale. Altri tempi, altri sogni, come direbbe il Poeta.
I “personaggi”, più che di un “autore”, sono ormai in cerca di una maschera, di una finzione in cui credere. Dopo un secolo e mezzo di positivismo, “magnifiche sorti” e ingenue quanto strumentali mitologie del progresso, come ricordava giustamente Ennio Flaiano, dovrebbe esserci definitivamente chiaro che lo scetticismo e il dubbio costituiscono l’approccio più sensato e ragionevole alla tragicommedia umana. Ecco perché l’unico modo rimasto per raccontare veramente, sfuggendo alla ricerca della maschera, della messinscena e della finzione, consiste con ogni evidenza nel raccontare raccontandosi. È un genere letterario che si potrebbe definire “autobiografia obliqua” e consiste nel parlare di sé parlando degli altri e dell’altro, o in altri termini nel fornire un’immagine della propria vita descrivendo oppure evocando quella altrui.
Ennio Flaiano, tra letteratura e cinema (3./5)
Alphaville 16.04.2025, 12:05
Contenuto audio
La citazione di Ennio Flaiano non è casuale, perché proprio l’opera complessiva di Flaiano si configura come un tipico esempio di approccio scettico e dubitoso ai dati del reale e conseguentemente come autobiografia obliqua, con un racconto solo apparentemente in prima persona che diventa il racconto di un’epoca nelle sue varie forme e declinazioni, quasi la sceneggiatura di un film spesso dozzinale, una baracconata o pantomima con i suoi protagonisti e le sue comparse.
Pochi come Flaiano, che in maniera molto canaille si era autodefinito “scrittore satirico minore dell’Italia del benessere”, hanno infatti restituito in molteplici quanto sapide variazioni le poche virtù e i molti vizi dello scorcio centrale del Novecento, più nello specifico dell’eterna Italietta: la sua inestirpabile “mentalità balneare” («tutti bagnini, che aspettano soltanto l’estate»), la mancanza di sintassi interiore, la tendenza a soffocare il meglio e lasciar suppurare il peggio.
Lo si nota, in particolare, leggendo i suoi scritti dedicati al cinema: non solo perché Flaiano, come soggettista e sceneggiatore (un elenco preciso e completo dei suoi lavori sarebbe pressoché interminabile, dalla celebre, fortunata e spesso burrascosa collaborazione con Fellini alla riduzione per lo schermo del Tonio Kröger del diletto Thomas Mann, fino al grandioso tentativo, mai concretizzatosi, di sceneggiare tutta la Recherche di Proust), ha frequentato molto da vicino l’ambiente del cinema, ma anche e soprattutto perché ha raccontato e si è raccontato per mezzo del cinema, come spettatore e critico.
Gli scritti di Flaiano sul cinema, usciti originariamente su vari giornali e riviste, apparsi postumi nel 1978 e poi nel 1990 per i tipi di Rizzoli in due volumi dal titolo Lettere d’amore al cinema e Nuove lettere d’amore al cinema, e che a breve verranno raccolti da Adelphi in un volume con un titolo molto alla Flaiano, Chiuso per noia, forniscono inoltre la conferma di una regola talmente ferrea da non conoscere praticamente eccezioni: gli scritti minori degli scrittori maggiori sono molto meglio degli scritti maggiori degli scrittori minori. Sarebbe infatti fin troppo facile – e anche piuttosto comodo, in ultima analisi – derubricare gli scritti sul cinema come un episodio minore all’interno della più ampia produzione di Flaiano, soprattutto quella confluita nelle opere maggiori e più celebri, anche perché centrate sulle flagranti contraddizioni del miracolo economico italiano e sulle incongruenze della grande storia internazionale, più in generale sulle eterne miserie e gli abissi (spesso grotteschi e ridicoli) dell’animale-uomo.
Ma non è così, perché il Flaiano cosiddetto “maggiore” è già presente in questi scritti “minori”, dove il cinema diventa una specie di reagente chimico che permette a noi “venuti dopo” di capire in che modo – da spettatori nel buio delle sale, quando il cinema era uno dei pochi passatempi ed era quasi un rito – siano stati vissuti e percepiti il primo scorcio dell’Italia repubblicana e il periodo del boom economico, con quali speranze e promesse, ma soprattutto con quali delusioni e disillusioni, con quanta ipocrisia e quanto opportunismo, tra ripicche e bassezze morali che non hanno risparmiato quasi nessuno nella società dell’epoca, provocando guasti e malfunzionamenti duramente scontati nei decenni successivi, in pratica fino ad oggi.
Ennio Flaiano: tra cinema e teatro
Laser 04.11.2010, 01:00
Contenuto audio
«Per anni ho scritto delle critiche sui giornali, senza cavarne altro che inimicizie ed errori tipografici», ha osservato Flaiano nel 1946. Mentiva, ovviamente, sapendo di mentire, anche quando diceva di essersi «fatto una cultura sui propri articoli», perché a partire dal 1939, poco dopo il suo ritorno dal sordido, infame e abietto teatro di guerra dell’Abissinia (una delle tante, troppe vergogne italiane, poi raccontata nel suo primo e unico romanzo, Tempo di uccidere, scritto nel 1946 su sollecitazione di Leo Longanesi e pubblicato nel 1947 dallo stesso Longanesi), Flaiano è stato uno spettatore assiduo e attentissimo e poi un recensore cinematografico acuto e beffardo, pacato e intransigente, sempre ostile a quei film volutamente corrivi che «presuppongono, di regola, un pubblico eccessivamente tardo di comprendonio» o che «rendono confortevole l’esistenza, allo stesso titolo dei treni rapidi, delle automobili, dei termosifoni».
Uno spettatore, insomma, tutt’altro che “addormentato”, per operare una variazione sul celebre titolo di una sua critica teatrale, fortemente avverso alle falsità e insulsaggini dispensate dalla «nostra incapacità di essere sinceri e di guardare la vita invece dei suoi modelli più accettati». Parole verissime, e soprattutto invecchiate benissimo, perché si riferiscono a un certo cinema dell’epoca ma valgono anche per un certo cinema di oggi. La sua ultima critica cinematografica, una straordinaria lettura e analisi di 2001 - Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, è apparsa su L’Europeo il 2 gennaio 1969, quasi trent’anni dopo la prima recensione, apparsa il 3 giugno 1939 su Oggi: il film in questione era Sangue d’artista di Carl Lamak. Tre interi decenni nel corso dei quali Flaiano ha raccontato e si è raccontato, scrivendo una personalissima storia del cinema e del costume che non sfigura affatto rispetto alle storie canoniche e ufficiali.
Come ha notato nel 1941, commentando una serie di lettere che gli erano pervenute da aspiranti attrici e attori di provincia:
Ogni epoca ha le sue passioni, il cinema è toccato a noi. Ma il cinema potrebbe renderci migliori e invece spesso ci rende peggiori o scontenti, il che è la stessa cosa. Quasi tutti i personaggi del cinema obbediscono a una finzione ottimista, di modo che gli ammiratori innocenti di questi personaggi si credono, a lungo andare, defraudati dell’esistenza. Metà dell’universo oggi si ispira a un modello transitorio e aspira a recitare una parte brillante nella vita. Molta gente, oggi, avrebbe bisogno di un anti-romanzo che la riconducesse alla realtà.
A distanza di oltre ottant’anni, si tratta di considerazioni più che mai attuali. Il critico cinematografico Flaiano ha scritto precisamente questo anti-romanzo, fatto di tante recensioni che possono essere considerate come le tante lettere scritte al cinema da uno spettatore appassionato e spesso deluso, ma pur sempre innamorato: “lettere d’amore al cinema”, appunto.
Per capire il suo rapporto di amore/odio col cinema è tuttavia necessario ragionare su un altro aspetto, che permette di circoscrivere anche la sua complessiva proposta poetica e le sue personalissime clausole stilistiche: un certo understatement talvolta molto appuntito, l’ironia utilizzata sulla scorta di Musil come unico modo per «smussare gli spigoli del reale», la costante preferenza per la litote rispetto all’enfasi e all’iperbole, la cosiddetta “malinconia canina” come (legittima e fondata) visione del mondo. Flaiano sosteneva infatti che sono sufficienti un minimo di esperienza e spirito di osservazione per ritrovarsi faccia a faccia con una verità tanto amara quanto incontestabile. La considerazione è contenuta nel Diario notturno del 1956:
La stupidità è lo stato perfetto, originario, dell’uomo, il quale trova buono ogni pretesto per riaccostarsi a quello stato felice. L’intelligenza è una sovrapposizione, un deposito successivo, e soltanto verso quel primo strato dello spirito noi tendiamo per gravità o convenienza.
Lo stesso Flaiano aveva già svolto un simile ragionamento alcuni anni prima, nel 1948, nel divertente resoconto di un viaggio in automobile da Roma a Torino insieme al celebre produttore cinematografico Carlo Ponti e al regista Alberto Lattuada. Nel resoconto, dal titolo O stupidi, o niente, si parla – sul filo del paradosso, ovviamente, ma riletta oggi la considerazione non ci sembra affatto paradossale – della necessità di fare film stupidi per un pubblico stupido, perché la stupidità «ha un suo fascino ed è perfino riposante», e soprattutto perché in questo modo si obbedisce alla «legge di gravità» che riconduce e risospinge l’essere umano alla sua condizione originaria e privilegiata: la stupidità, lo «strato dello spirito non solo più felice, ma anche più comodo». Mai come in queste righe, forse, o comunque mai con la stessa concisione, Flaiano si rivela un flaubertiano “doc” e individua nella bêtise la cifra più autentica dell’esistenza umana, svelando nello stesso tempo la propria attenzione per le potenzialità e il proprio timore per le possibili derive dell’arte cinematografica.
Si capisce allora perché lo spettatore e critico Flaiano vada al cinema col sospetto di perdere tempo e rincretinirsi, ma anche con l’entusiasmo di chi ha intenzione di «sgranchirsi l’immaginazione e la visione morale del mondo». Talvolta rimane deluso, profondamente deluso, perché il cinema gli appare nient’altro che la continuazione con altri mezzi delle assurdità e delle insulsaggini della vita reale. È in simili frangenti che si scatena una feroce ironia, spinta fino al sarcasmo, che a sua volta si traduce in una quasi sistematica dissacrazione di una certa sottocultura o retorica nazionale, effettivamente presente in molti, troppi film italiani dell’epoca. È davvero una trista carnevalata quella che si mostra allo sguardo di Flaiano e si riflette nelle densissime righe delle sue recensioni, dove molte glorie culturali dell’immediato secondo dopoguerra appaiono piuttosto in chiaroscuro.
Il grande pregio dei due volumi editi da Rizzoli (ed è lecito pensare che lo si ritroverà nel volume in uscita per Adelphi) consiste soprattutto nel saldare le recensioni in un racconto lineare, le “lettere d’amore”, che restituisce molti tratti poco conosciuti del periodo, con la politica – o almeno una certa politica – che si avvia a diventare lo specchio di una società nominalmente egualitaria e democratica, ma in definitiva profondamente volgare e (cosa ancor più grave) del tutto paga e soddisfatta della propria volgarità. E’ quanto accade soprattutto nelle critiche scritte per il Mondo, nelle quali la recensione cinematografica assume la connotazione di un vero e proprio genere espressivo e si profila quale momento preciso del suo essere scrittore, con la presenza di temi e stilemi che erano già presenti oppure torneranno nelle sue altre opere, soprattutto i racconti e i diari, ma anche gli aforismi e gli apologhi.
È molto “cinematografica”, ad esempio, e infatti torna leggermente variata in alcune recensioni, questa “storiella morale”, se così la si può definire, apparsa nel 1947 come nota di costume su La voce repubblicana, col titolo Piatto del giorno: «La politica, l’arte, la letteratura, il pensiero contemporaneo possono dormire tranquillamente: la mondanità li protegge. In un salotto ti accorgi che in fondo a questi istruttivi giochi contemporanei si erge, maestoso come un iceberg, l’antico buffet. Qui i convenuti depongono il loro fervore davanti al volto impassibile dei camerieri. Non avranno mai la loro complicità». Sono parole di urticante e soprattutto avvilente bellezza e verità, tanto che si ha l’impressione di essere catapultati in una scena di film come I mostri, Vogliamo i colonnelli o qualche altro capolavoro della commedia all’italiana. In alcuni casi c’è anche un po’ di cattiveria (difficile dire fino a che punto gratuita), come nel giudizio dello sceneggiatore Flaiano sul difficile rapporto tra sceneggiatori e registi: «Lo sceneggiatore è colui che mette il padrone dove vuole l’asino».
Ma talvolta la magia si compie, come nel caso di Verso la vita di Renoir, tratto da Bassifondi di Gor’kij, la cui arte «è di un’intelligenza che appare semplice, elementare, e che invece è il risultato di un superamento costante delle posizioni altrui», oppure di Ombre rosse di Ford, dove «l’ombra di Maupassant si sposa a quella di un Murnau», e non da ultimo di Monsieur Verdoux di Chaplin, un capolavoro «in cui tutto porta il marchio così semplice e raro del genio». Alla schiera bisogna aggiungere anche Bergman, Billy Wilder e «i registi di casa nostra che sanno leggere e scrivere, e quindi si danno meno arie».
In un Paese come l’Italia, «dove è lecito essere anticonformisti solo nel modo giusto e approvato», il critico cinematografico Flaiano ha saputo esserlo sino in fondo, come dimostra l’irresistibile giudizio riservato a Orson Welles: «I suoi personaggi appartengono a quella categoria che mangia il pollo con le mani non per maleducazione, ma per eccesso di carattere, per prepotenza di immaginazione e di volontà!». Come ha scritto Guido Fink nello scritto che chiude il secondo volume delle Lettere d’amore al cinema: «A questa raccolta è possibile senz’altro rivolgersi come a una sorta di giornale impaziente, sempre proteso verso dimensioni rigorose e remote, e sempre invischiato nella commedia non esaltante del quotidiano».
Il che è verissimo, soprattutto se si prende in considerazione l’ultima recensione, dedicata a 2001 – Odissea nello spazio, che rappresenta il più compiuto esempio di racconto obliquo, con Flaiano che parla di sé stesso e della propria visione del mondo parlando del capolavoro di Kubrick. È forse uno degli apici dell’intera produzione di Flaiano, sicuramente è la più bella tra le “lettere d’amore al cinema”: «Le conclusioni di Kubrick sono scoraggianti, tanto vale dire: reazionarie. Non vi aspettate molto dallo Spazio, è praticamente vuoto. Le possibilità turistiche sembrano limitate». Tutto nasce col famigerato monolite e terminerà forse allo stesso modo, in un tramonto che sarà maledettamente simile all’alba. «Tutto passa, nulla cambia e tutto stanca», diceva Maupassant. Non mancando di aggiungere: «Beati coloro che non se ne accorgono».
Flaiano, da parte sua, lo dice riflettendo sulla trama del film di Kubrick e sul comportamento del calcolatore AL 9000, che «si macchia di fellonia». Nelle sue parole si possono leggere in filigrana la trama nascosta di tutta la sua opera, il sunto di un’epoca e una riflessione davvero definitiva sul cinema, i suoi limiti ma anche la sua potenza profetica e visionaria, prodotta dalla reinvenzione della realtà nell’illusione, e viceversa:
L’errore è di credere che la macchina dominerà sull’uomo con la sua indispensabile capacità di intelligenza. No, le macchine un giorno vinceranno per la semplice forza del numero, per la loro proliferazione incessante, che l’uomo non può arrestare, perché sembra ormai evidente che il suo scopo principale è fare macchine.