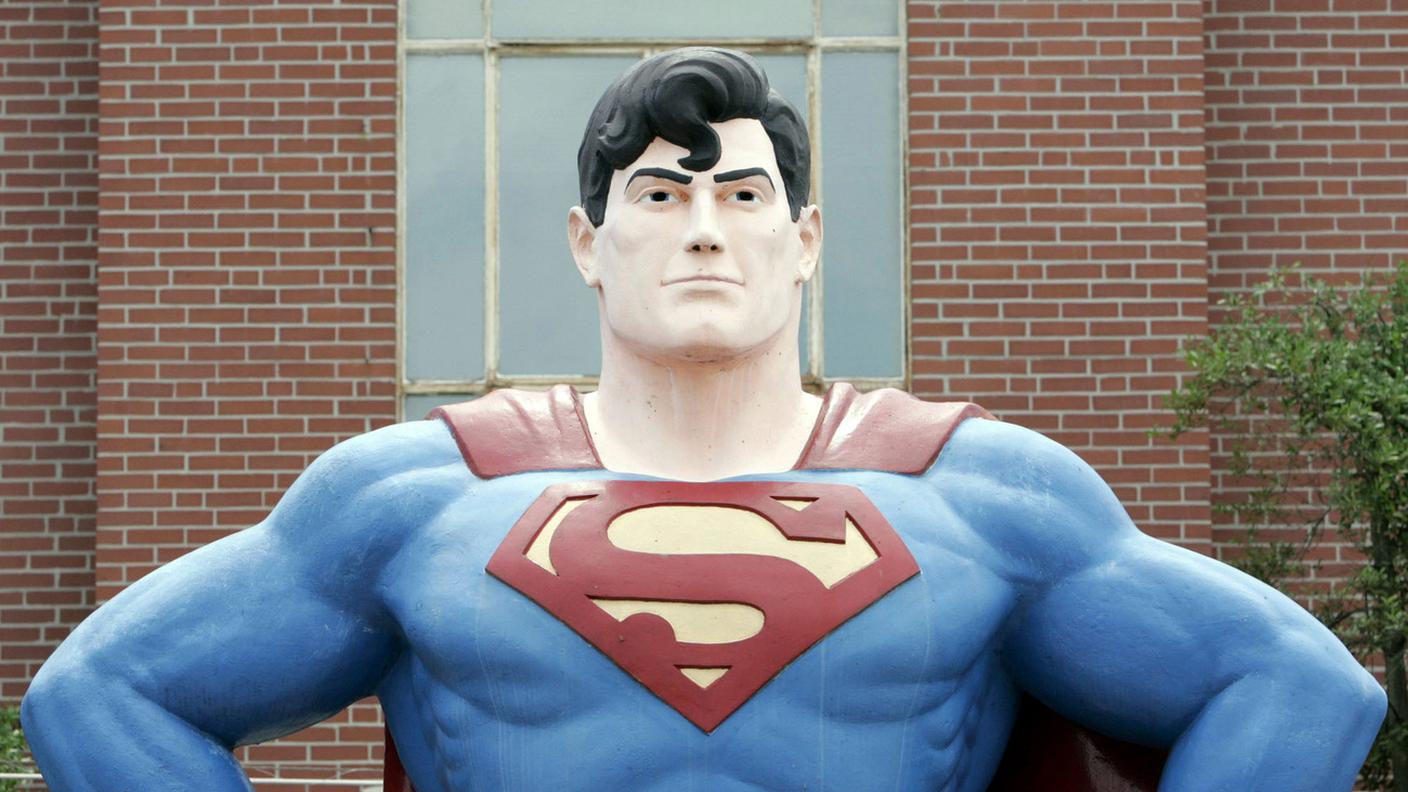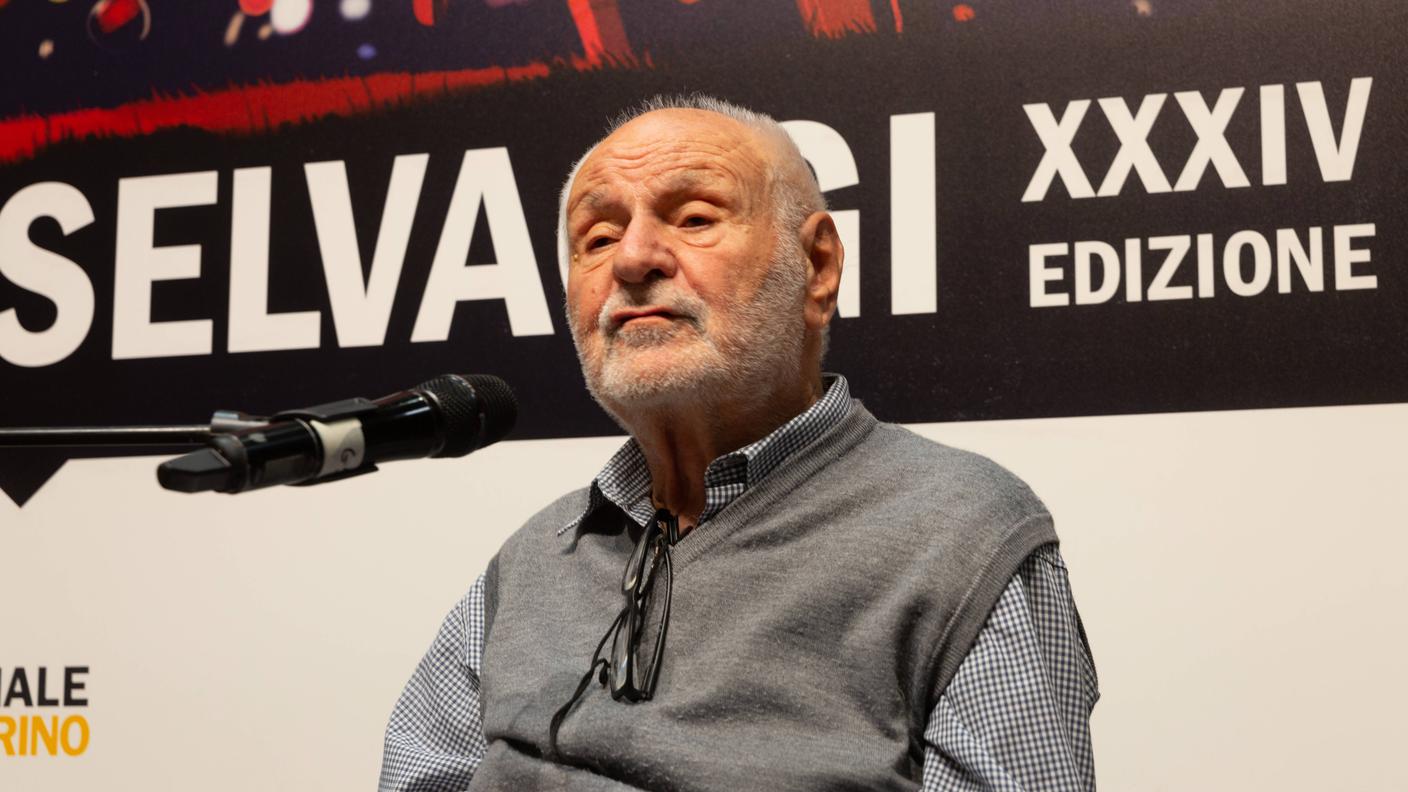A volte basta un piccolo libro per cogliere verità profonde. E a volte, di un piccolo libro, bastano poche pagine. Nel caso che si vuole trattare qui, Vagabondaggio di Hermann Hesse, bastano persino poche righe.
Sulla linea di tutta la sua produzione maggiore, da Narciso e Boccadoro a Siddharta al Gioco delle perle di vetro, Hesse propone in questo libretto, soprattutto nelle righe che ora riporteremo, quella che anni dopo il viaggiatore e scrittore Bruce Chatwin avrebbe chiamato con perfetta formula l’alternativa nomade. Non già e non solo una visione anti-sedentaristica o hippy o beat dell’esistenza, ma un vero e proprio monito a quella che l’etica del potere ha eletto a suo idolo: la preminenza del confine.
Scrive Hesse a questo riguardo, nella prima pagina del suo Vagabondaggio:
Un viandante è, sotto molti aspetti, un uomo primitivo, così come il nomade è più primitivo del contadino. Tuttavia il superamento della sedentarietà e il disprezzo per i confini fanno di gente del mio tipo degli alfieri del futuro. Se esistessero molti uomini nei quali fosse così radicato come lo è in me il disprezzo per i confini nazionali, allora non ci sarebbero più guerre né blocchi. Niente è più odioso dei confini, niente è più stupido.
E poco sotto aggiunge, quasi vaticinando le attuali stupidità, che sono in fondo le stupidità di tutti i tempi e di tutte le guerre:
I confini sono come cannoni, come generali: sino a quando ragione, senso di umanità e pace dominano, non se ne ha sentore e di loro si ride, – ma non appena guerra e follia divampano essi divengono importanti e sacri. Quanta angustia e tormento hanno procurato a noi viandanti negli anni di guerra! Che il diavolo se li porti!
Sono considerazioni che andrebbero affisse su tutti i portali di tutte le scuole affinché chi si introduce al mondo del sapere sappia che il più pernicioso dei confini è quello che pretende di separare uomo da uomo, collettività da collettività, cultura da cultura e civiltà da civiltà. Ma sono anche considerazioni che insegnano tra le righe qualcosa di più radicale: che laddove si disegnano o impongono confini, là siamo certi che prima o poi si scatenerà la voluttà di difendersi, comporti o non comporti l’uso della violenza o lo strumento della guerra.
Cosa suggerisce allora Hesse per uscire dalla coazione a ripetere del confinamento, della chiusura, della separazione tra umani e tra popoli? La risposta è nello stesso titolo del libro. Fuori da un’etica del vagabondaggio, nessun mondo sarà mai preservato dalla sua vocazione alla guerra.
Ma perché un cuore e una mente possano aprirsi a questa etica di pace, di fratellanza, perché un uomo o una donna possano conquistare uno stato di ecumene e di concreta apertura verso gli altri, è fondamentale che il nostro spirito si doti di una virtù che appartiene a pochissimi: la capacità di disappartenere. Fintanto che termini come “zolla” o “patria”, “casa” o “famiglia”, “terra” o “culla” verranno intesi come uniche possibili determinazioni della nostra sicurezza esistenziale, è certo che all’etica del vagabondaggio non sapremo mai appartenere. E pur di proteggere e difendere i nostri luoghi saremo pronti a guerreggiare all’ultimo sangue contro quelli altrui.
Scrive Hesse, alludendo a quella che potrebbe essere chiamata l’utopia di un uomo universale:
Domani amerò altri tetti, altre capanne. Non lascio qui il mio cuore, come si legge nelle lettere d’amore. Oh no, il mio cuore lo porterò con me, ho bisogno di lui anche lassù sulle montagne, in ogni ora. Poiché sono un nomade, non un contadino. Sono un adoratore dell’infedeltà, del mutamento, della fantasia. Non tengo in nessun conto l’idea di inchiodare il mio amore a una qualsiasi chiazza di terra.
Hesse, il lago, l'albero, la via
RSI Cultura 29.11.2016, 14:46
Come risuona mistica e inattuale – e pur così adamantina nella sua ragionevolezza – l’espressione “adoratore dell’infedeltà”! In effetti a cosa dobbiamo essere fedeli, in un’ottica e in un’etica della fratellanza universale, se non all’uomo in quanto tale? Hesse ci invita a guardare al di là del risaputo, delle norme, fuori dai confini mentali dell’abitudine e del servaggio a qualsiasi identitarismo provinciale. Come un buddhista o un induista, richiama il nostro dovere di uomini all’imperativo dell’umiltà e dell’universalismo. “Io sono un cercatore e non un depositario” scrive.
Quando scoppiano le guerre, scoppiano d’altronde sempre perché qualcuno si ritiene “depositario” di verità. L’etica del vagabondaggio è prima di tutto l’etica di cercare la verità senza mai trovarla, lasciando così alle spalle la tentazione del sangue e dell’odio.