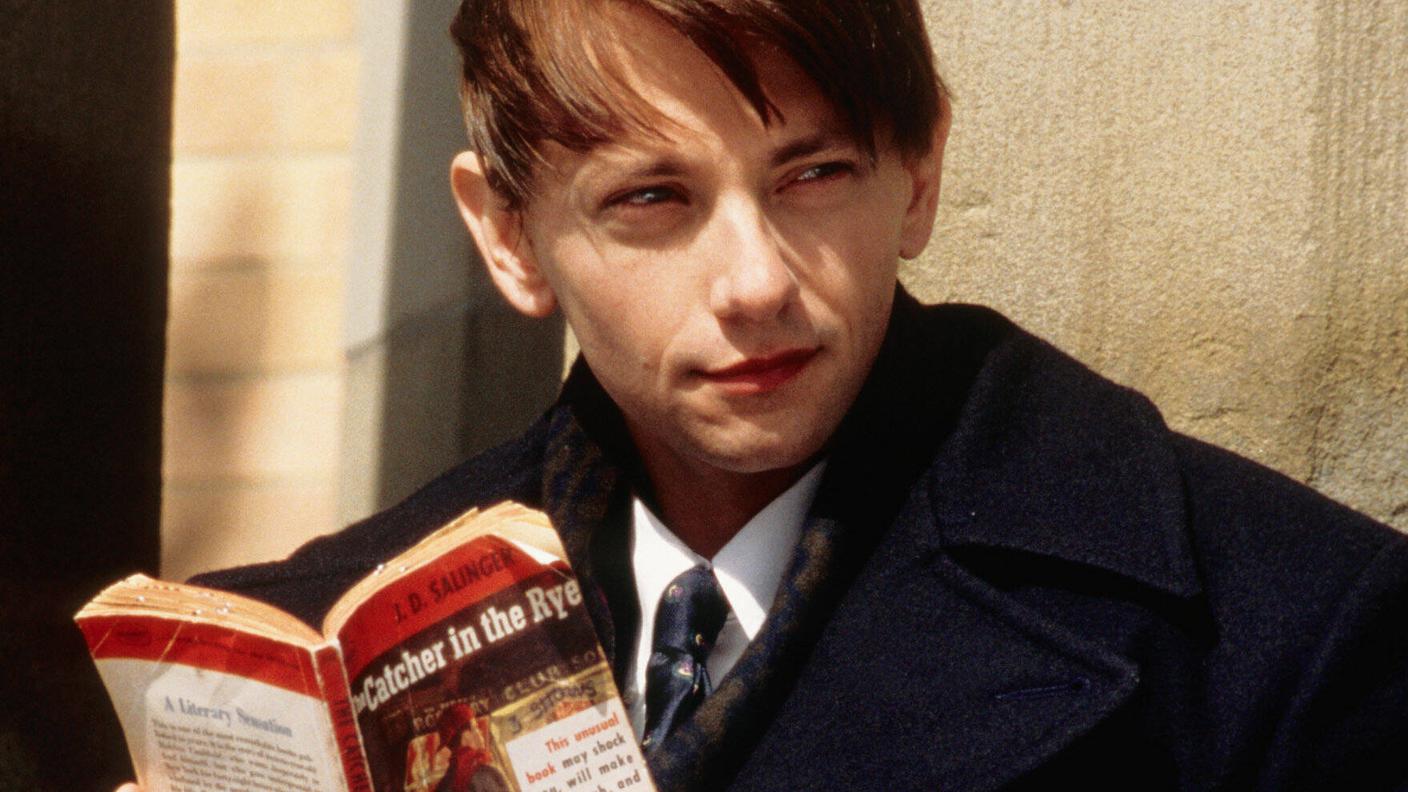La narrativa di montagna è una delle nicchie più redditizie del mercato editoriale (o forse sarebbe meglio dire, una delle poche anticicliche rispetto alla depressione generale), e negli ultimi anni è andata molto al di là dei luoghi comuni a cui ci aveva abituato.
La montagna è stata raccontata oltre lo stereotipo dell’idillio alpino, che a partire dal romanticismo ottocentesco, ha influenzato fortemente l’identità svizzera e le sue rappresentazioni nell’arte e nella letteratura. Martino Giovanettina, scrittore, animatore culturale nato e cresciuto nell’alta Vallemaggia, è uno degli autori che hanno contribuito a questa evoluzione, ad esempio con Il taccuino dei giorni freddi, pubblicato da Agenzia CAI nel 2017, che racconta le asperità e la miseria che caratterizzavano la vita delle valli ticinesi fino a pochi decenni fa.
Giovanettina è arrivato a teorizzare un genere letterario, quella della “montagna nera”, che racconta gli aspetti più oscuri del mondo alpino, in contrapposizione al mito idilliaco della “montagna bianca” che trova la sua massima rappresentazione artistica nel Trittico della Natura di Giovanni Segantini. Lo abbiamo intervistato sulla differenza fra “montagna bianca” e “montagna nera”:
«La montagna bianca è quella corrente, che si pratica. La montagna della natura, quella in cui ci si rilassa, a cui si aspira per avere un po’ di pace. Una montagna che ci fa sentire a nostro agio. La montagna nera è una montagna, invece, sepolta. Una montagna che non c’è più, che sta scomparendo anche dalla memoria, ma allo stesso tempo è una montagna che va a ricomporre l’altra, come se fossero due sfere. La montagna nera è quella dei perdenti, degli ultimi, dei sopraffatti, delle storie dimenticate. Storie nere che in qualche modo rendono comprensibile la montagna bianca.
La montagna bianca è quella facile, quella delle statistiche, quella di noi che ci andiamo il venerdì. La montagna nera invece è una serie di ricordi che provengono da quel mondo. che io a suo tempo registrato, ho provato a trascrivere, e che mi impediscono di pensare che ci sia una sola montagna».
Possiamo dire che la montagna bianca è un po’ la montagna inventata dalla città, in qualche modo…
«Questa è un’affermazione sostanzialmente corretta. Diciamo che la posizione della montagna, oggi, evidentemente proviene dalla città. La montagna non è più in grado di elaborare un proprio linguaggio, perché non ha più le persone, non ha più le forze fisiche, non ha più un controllo dei media, non ha una serie di cose che possono far sì che questa comunità diventi qualcosa di auto costruttivo… per cui la montagna bianca è spesso la montagna della città, o comunque del mondo urbano».

La montagna nera
Alphaville 02.07.2025, 11:05
Contenuto audio
Però la montagna è molto altro, come lei racconta nel suo Taccuino dei giorni freddi, pubblicato nel 2017, in cui recupera storie di miseria, emarginazione, violenza: la storia di una bambina picchiata a scuola, di una donna emarginata; le vicende drammatiche degli incesti, i parti di bambini morti; la donna rimasta incinta fuori dal matrimonio, allontanata dalla comunità, rinchiusa in un istituto femminile… Possiamo dire che siano soprattutto personaggi femminili, le vittime che lei racconta? Le donne hanno avuto una vita particolarmente dura, nella montagna del passato.
«Sì, certo, il conto salato l’han pagato le donne, perché erano in una posizione di subalternità. Le donne erano particolarmente esposte. Io ho avuto anche esperienze dirette di persone che non hanno sofferto per casi così gravi, ma che semplicemente in quanto donne che provenivano da fuori hanno avuto più difficoltà di integrazione, perché quel tipo di mondo femminile era parecchio esposto. Queste storie riguardano più le donne, perché le donne erano più deboli, più soggette a discriminazione».
Come mai ha deciso di recuperare queste storie? Ha svolto anche delle indagini storiche per recuperarle?
«Io ci ho vissuto, in questo mondo. Da bambino, da ragazzo… fino diciamo ai vent’anni, a tempo pieno. Per cui ho sperimentato il passaggio tra una civiltà contadina che stava finendo e quel questa specie di misto indeterminato che c’è adesso in queste storie. Le storie, le ho sentite… e poi ho fatto centinaia di incontri. Poi, elaborando la mia identità alpina – che è una sola delle mie identità, poi ce ne sono altre - mi sono detto: se in questa identità non ci metto la verità, non ci metto anche quello che io posso associare a un paesaggio, un nome una casa… per poter completare questo paesaggio alpino con cui mi sono confrontato, devo poterlo rendere completo. E queste storie lo rendono completo».
E come descriverebbe - mi incuriosisce questa cosa che ci ha detto - la sua “identità alpina”?
«Facciamo una premessa che non c’entra: l’annuario statistico dice che il numero di abitanti della montagna, di quelle terre alte - se vogliamo parlare del Sopraceneri - sopra i 500 metri, sta precipitando, gradualmente, ma in modo inesorabile. Quindi c’è questo dato oggettivo. Poi, sulla mia identità alpina… io sono cresciuto da madre olandese, poi ho svolto gli studi di letteratura e storia a Venezia, che è il posto per eccellenza dove non riesci a dare un’identità precisa al paesaggio, che contiene tutta una serie di altre storie di viaggi. Venezia contiene l’Oriente, contiene lo spaesamento, contiene molte cose… E poi c’è questa identità alpina primigenia. Quindi io non sono un abitante alpino vero e puro, sono una persona che vive qui, che però certamente sente questa forza primigenia. Per me San Carlo in Valle di Peccia, che è il posto in cui sono cresciuto, è il mio paese dell’anima, un paese di cui ho bisogno. Ma non è l’unico posto di cui ho bisogno».
Il suo ultimo libro si intitola La notte delle pietre folli, ed è dedicato al disastro alluvionale che colpì la Vallemaggia a inizio estate 2024, provocando otto morti e devastando i versanti e il fondovalle. Si tratta di un lavoro a più mani: suo il testo, con fotografie invece di Sara Giovanettina.
«Aggiungerei che c’è anche un bel prologo scritto da Matteo Melchiorre, l’autore del Duca pubblicato da Einaudi, che dà una lettura esterna, come può fare uno scrittore che proviene da un ambiente alpino, sì, ma completamente diverso. La notte delle pietre folli è stato scritto subito, sostanzialmente. Ma poi l’ho lasciato a decantare. È un libro nato per andare oltre la cronaca, nato per andare oltre il lamento, nato per andare oltre questa dialettica di soldi, di abbandono… che però a volte copre quello che è il senso del problema. C’è un senso pratico del problema, che è quello appunto della ricostruzione. E poi ce n’è un altro, che è quello che dice: abitando la montagna, queste cose succedono.
Il titolo La notte delle pietre folli non è casuale. Queste pietre, che appartengono al mondo minerale, evidentemente hanno stabilito un patto cosmico con l’uomo. La pietra, che viene dal mondo minerale, che sembra immota… in realtà, la pietra, si muove. La pietra è un dialogo antico di milioni d’anni, con noi. Quella notte si è mosso qualcosa anche riguardo a questo aspetto. Cioè, noi crediamo che sulle strade si passa, che nelle case si abita, che in montagna, quando piove, non ci si sta… Ma in realtà quella notte è successo qualcosa oltre il pratico, oltre il tragico - con otto morti, danni, eccetera. È successo che abbiamo dovuto ripensare a un patto obbligato che noi abbiamo con questo mondo minerale, con il mondo dell’acqua, eccetera. Questi sassi non servono solo a fare dei tetti per le piogge, panchine, tavolini, davanzali. Questi sassi hanno anche una vita propria, ogni tanto, che viene scatenata da eventi naturali. Queste cose, come generazione, non le abbiamo mai viste, e neanche i nostri padri. Ha mai visto una frana simile? Improvvisamente, siamo ritornati al centro di questo dialogo con la montagna, che è fatta di sassi e La notte delle pietre folli lo racconta».
Taccuino dei giorni freddi e La notte delle pietre folli sono due dei libri pubblicati da Agenzia Kay, l’editore fondato proprio da lei, una delle iniziative attraverso cui cerca di promuovere, di animare la cultura in valle, segnata ovviamente da un inesorabile spopolamento. Cosa vuol dire fare animazione e resistenza culturale in un contesto come quello della Vallemaggia? Quali sono le difficoltà e quali invece i successi?
«Dei successi propri è sempre difficile parlare. Io devo dire che faccio animazione per bisogno. È un fatto non dico di egoismo, ma un bisogno che ho, nel profondo. Agenzia Kay ha fatto otto libri, ha fatto una serie di incontri, Paolo Cognetti, Giorgio Orelli, Mario Rigoni Stern, sono passati cento e passa ospiti, in questi anni… quindi è chiaro che in un luogo periferico come Foroglio, dove agiamo noi, è qualcosa di interessante. Il problema nasce a monte: la Val Bavona ad esempio è una valle molto protetta, quindi abbastanza museificata. Che va benissimo, il risultato è ottimo, perché si vede, passandoci sembra di entrare in un’altra dimensione… il problema per me è quello del dialogo col contemporaneo: certo, non si va a toccare la natura, non si vanno a toccare i nuclei, giustamente non si vanno a fare queste cose, però il problema del dialogo col contemporaneo si pone. Allora mi dico… la cultura, le iniziative come questa nuova Arena Settembrini, uno spazio espositivo d’arte che abbiamo inaugurato qualche settimana fa… in qualche modo mettono in relazione questa realtà bloccata con l’uomo d’oggi, con la contemporaneità. Questo per me è fondamentale, altrimenti diventa una gabbia…».