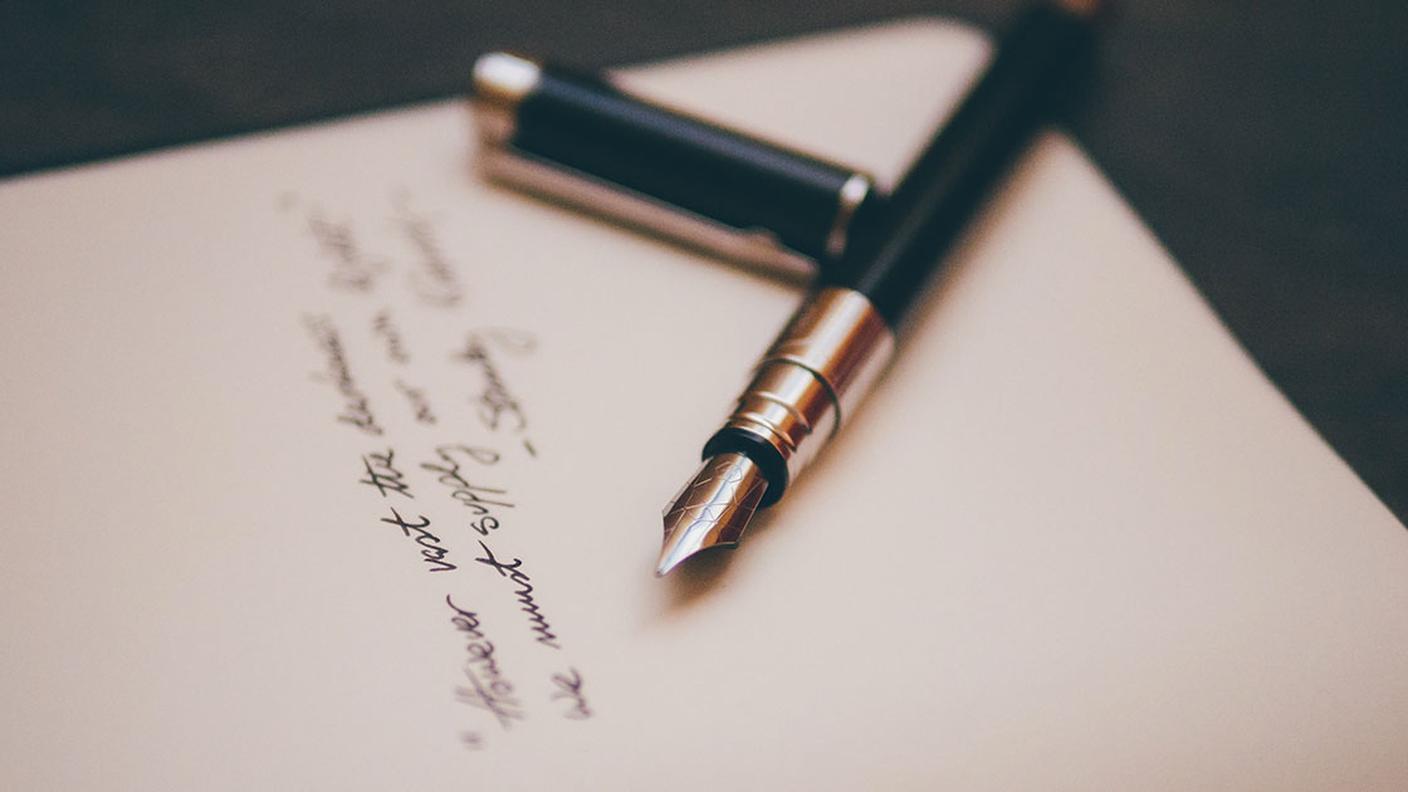Sabato 13 settembre è stato assegnato a Venezia il Premio Campiello, tra i più importanti riconoscimenti della letteratura italiana. Il settimanale radiofonico letterario di Rete Due Alice ha ospitato i cinque scrittori finalisti in altrettante interviste. Riproponiamo qui quella alla vincitrice del premio: Wanda Marasco, autrice di Di spalle a questo mondo (Neri Pozza).
«Come avete passato la notte, caro Palasciano?»
Nell’impeto, contando i colpi e lanciando domande e pensieri al muro. Ma questo non si poteva dire.
«Bene. Mi sono svegliato più sereno».
Il medico non gli credeva. Stava aguzzando gli occhi e passava all’attacco.
«Veniamo al dunque. Oggi vorrei parlare di fallimento e persecuzione. Credo che sia necessario. Il vostro amico Arena mi ha ricordato quella questione del Gesù e Maria. È convinto che qualcosa in voi sia mutato a partire da lì. E lo penso anch’io».
Ah, Ciccillo. Era stato l’amico suo a parlare di fallimento e di persecuzione. Aveva spifferato al medico lo scandalo della sua vita. Consalvo s’era accomodato sulla sedia con tutta l’aria di volerci restare a lungo. Che cosa pretendeva, che altro voleva sapere da lui?
«C’ero anch’io, Palasciano. Il 1865 fu un anno di battaglia per molti di noi. Non so se ricordate, vi espressi la mia solidarietà, firmai la protesta da indirizzare al Ministro della Pubblica Istruzione. I fatti li conosco, ma vorrei sentire dalla vostra voce come li avete vissuti. Fidatevi di me, parlate, parlate».
Parlare era una manovra dolorosa, ma l’anima non vedeva l’ora di sversarsi.
«Una muta di cani. Mi diedero i chiodi della croce».
Adesso comandava il cuore più antico. Gli stava dicendo di abbassare la testa, come un asino, essendo questa l’immagine giusta dell’uomo che torna sui propri passi.
«Il Gesù e Maria… Volevano impiantarci un ospedale. Mi opposi. Stavano creando una macchina di morte».
Il peso del testone d’asino crollava dentro la visione emersa dalla graniglia: la mole di un convento secolare, diluviata di grigio e di consumo.
«La struttura non permetteva di separare il reparto delle malattie infettive da quello delle puerpere. Voi capite? In breve avrebbero causato…»
Non era il momento dei singhiozzi. Nemmeno quello di una specie di raglio. Ma non fece in tempo a fermare la voce roca che diceva, Avrebbero causato centinaia di morti.
Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo
La storia di Di spalle a questo mondo arriva dalla Napoli dell’800, in tempi in cui il grande palazzo, ex-convento, del Gesù e Maria, diventò un ospedale. Intendiamoci, non è la storia di un ospedale, ma di Ferdinando Palasciano, luminare della chirurgia, innovatore della medicina italiana alla fine del diciannovesimo, e precursore della Croce Rossa: a trent’anni, da ufficiale medico dell’esercito borbonico, sul campo di battaglia in Sicilia volle curare anche i feriti nemici. Non fu l’unica delle battaglie professionali e civili della sua vita.
Il romanzo ruota però intorno, anche e soprattutto, alla storia d’amore con la moglie Olga, nobildonna russa curata e poi sposata; e ancora, alla discesa del protagonista verso la follia: Palasciano finisce internato in manicomio, e muore pazzo.
“Di spalle a questo mondo” di Wanda Marasco, Neri Pozza (dettaglio di copertina)
Wanda Marasco, per raccontare il suo ultimo romanzo, comincia proprio da Napoli, e dalla Torre Palasciano, la villa che il medico si fece costruire nel rione Capodimonte. «Napoli l’ho sempre usata come theatrum mundi - spiega la scrittrice - e così anche questa torre, che svetta sul ciglione orientale del borgo di Capodimonte, è un’altra forma di teatro, o meglio mente di teatro, Psiche che squaderna la voce dei due protagonisti: Ferdinando Palasciano e sua moglie Olga de Vavilov.
Ho sempre avuto la possibilità di vivere Napoli in due modi. Il primo, attraversando le sue strade, a contatto con la gente, camminando per andare a scuola o all’università… è stato, a volte, un contatto assai crudo. Il secondo, vedere questa Napoli in lontananza. Perché io sono nata a Capodimonte, proprio di fronte alla Torre del Palasciano, e ho percepito una Napoli che a volte ha dei toni, delle aberrazioni di tipo metafisico. Una città che guardi, e ti rivedi daccapo, ti reinventa.
Ho vissuto lì per oltre quarant’anni della mia vita. E la Torre in qualche maniera possiamo chiamarla una quinta dell’anima. È la dimensione dell’«Io nel pensiero mi fingo»… Poi è diventata, crescendo, una curiosità enorme. Ho cominciato a studiarne la storia, e la storia di chi l’ha fatta erigere. Mi ci sono appassionata, moltissimo.»
Michele R. Serra: Un uomo che vive il suo tempo da protagonista, e che finisce per cambiare il futuro. Il desiderio di restare umani anche di fronte ai momenti peggiori della storia. L’amore. La malattia mentale, il perdere il contatto con sé stessi. Tra tutte queste cose, come ha trovato un punto di partenza?
Wanda Marasco: Sono partita dalla suggestione del luogo, dalla mia esperienza del luogo. I luoghi diventano sempre dei contenitori psichici e anche di esperienza reale. Diventano punti, situazioni immaginifiche.
E sono partita dagli anni della follia di Ferdinando Palasciano. Qui c’è una coerenza: ho sempre usato la dimensione della follia, ad esempio nel mio romanzo Il genio dell’abbandono lo scultore Vincenzo Gemito era portatore di una follia che diventa sguardo lucido, chirurgico, spietato, ma anche umanissimo, sulla realtà e su sé stessi. C’è un passaggio d’asta, nel romanzo: Gemito lascia questa la propria follia a Ferdinando Palasciano. I due sicuramente si sono conosciuti nella realtà storica, ed è verosimile anche che si siano incontrati perché ricoverati nella stessa casa di cura.
Comunque, è difficile dire da dove si parte davvero… Sicuramente dalla ferita, dalla malattia usata nel romanzo come una forma di sguardo, di conoscenza, di nuova gnosi. Poi il testo è molto stratificato, perché c’è lo sfondo della storia, i teatrini della storia che si aprono e mescolano sempre il dramma al grottesco.
C’è una volontà di andare alla ricerca del guasto della storia. Dramma dell’imperfezione, è stato definito questo romanzo. Ma quale tipo di imperfezione? Le cadute, diciamo così, dei pochi saggi di fronte all’iniquità delle società e dei governi. Cosa terribile per Palasciano, che oltre a essere un grandissimo medico, un grande chirurgo, era un filantropo. Era uno di quei medici che – quando entrava negli ospedali – la prima cosa che vedeva non era la malattia, ma la povertà. Quindi ritorniamo al tema dell’ingiustizia, dell’assenza di equità nella storia.
Infine, c’è questa grande storia d’amore nata dalla congiunzione di due ferite Olga de Vavilov è una russa trapiantata a Napoli. Si reca da Palasciano per essere guarita dalla sua zoppia, i due si innamorano… Era molto suggestivo per me, immediato, pensare metaforicamente che questo claudicare diventasse un’infezione tragica da trasferire a tutti i personaggi, i quali prendono su di sé lo stesso ritmo zoppo dell’esistenza. Non ce n’è uno che non compia lo stesso percorso di Ferdinando e di Olga, e cioè metta in discussione la propria vita e vada alla ricerca dell’errore: dove ho sbagliato? Dove ha sbagliato la storia? Dove ha sbagliato la propria azione, una volta gettata nel mondo?
“Di spalle a questo mondo”
Alice 06.09.2025, 14:35
Contenuto audio
I due architravi fondamentali che reggono il romanzo sono in effetti la storia d’amore e la storia della malattia. Cos’è definitiva la malattia mentale, in questa storia? Siamo sempre dalle parti del fool letterario, strumento per svelare la verità?
Siamo sempre nel fool. Nella capacità del fool di dire la verità. Nella necessità di un annudamento che soltanto la conflagrazione mentale può consentire, almeno all’interno di un romanzo. Il personaggio scopre questa terribile verità interiore, che può urlare, può suggerire, può bisbigliare. La follia è una grande capacità di annudamento. E naturalmente, da che cosa viene? Dai grandi archetipi del teatro, sia maschili che femminili: Antigone, Medea, lo stesso Edipo conflagra mentalmente mentre compie la sua indagine… Amleto… Noi siamo sempre di fronte ad un’inchiesta, cioè all’uomo che si chiede daccapo: qual è la realtà? Qual è la finzione? Chi sono veramente? E gli altri, chi sono? Cosa vogliono da me? Che cosa sogno? Che cosa pretendo?
Ci troviamo sempre di fronte a queste grandi domande, che poi per un verso somigliano al Quem quaeritis? delle sacre rappresentazioni. In questo romanzo ci sono tante stazioni: stazioni della storia con la S maiuscola e dell’interiorità, dove ogni personaggio in fondo si ferma a chiedere questo, a se stesso e al tempo storico.