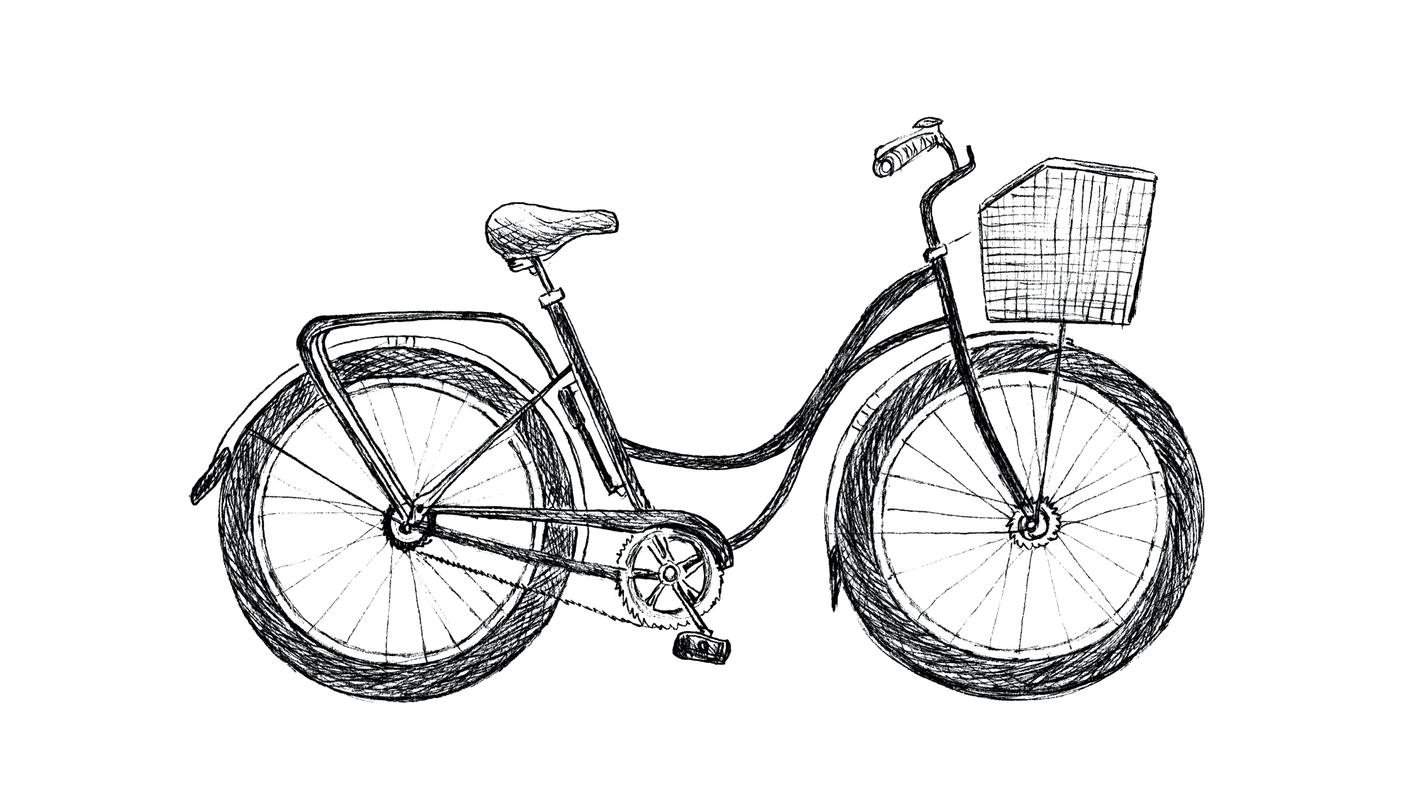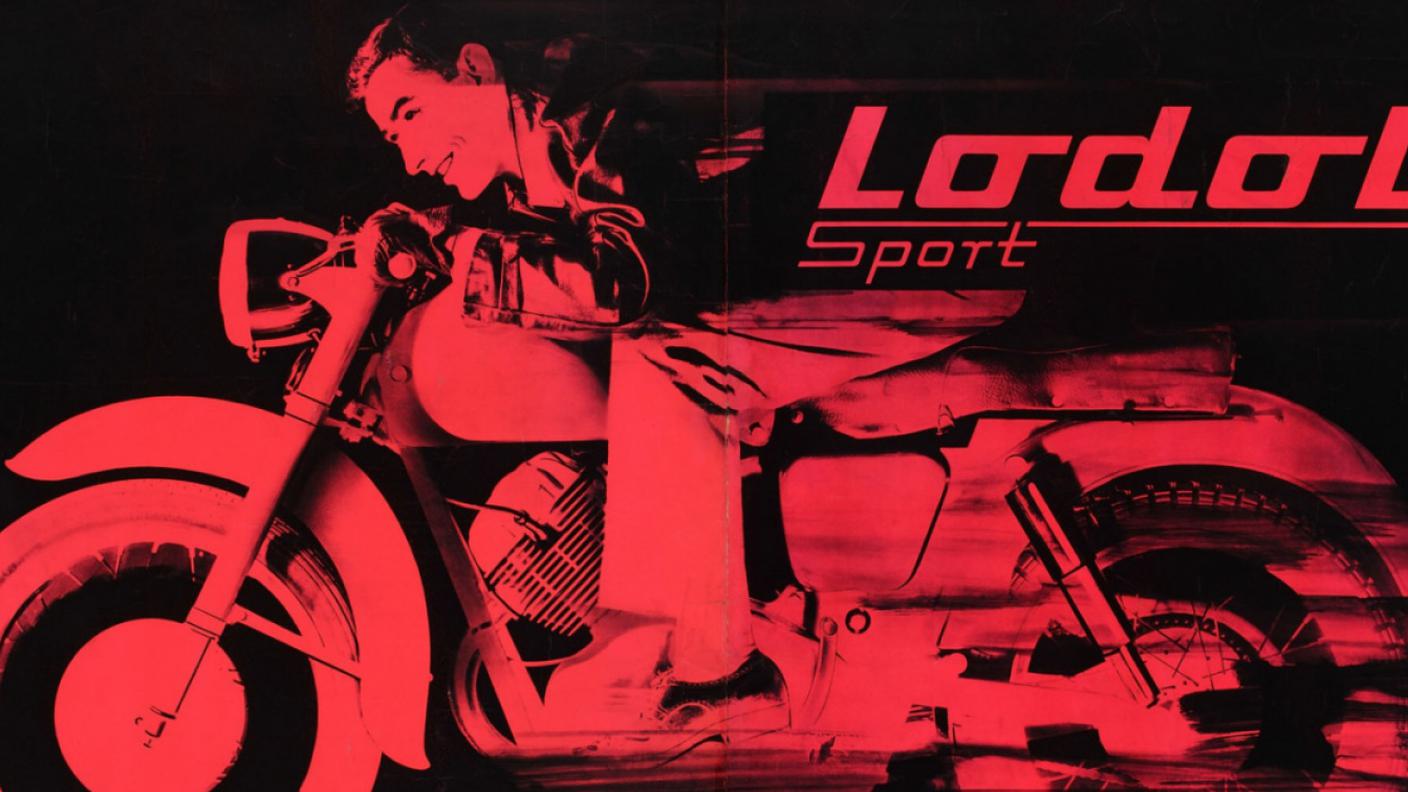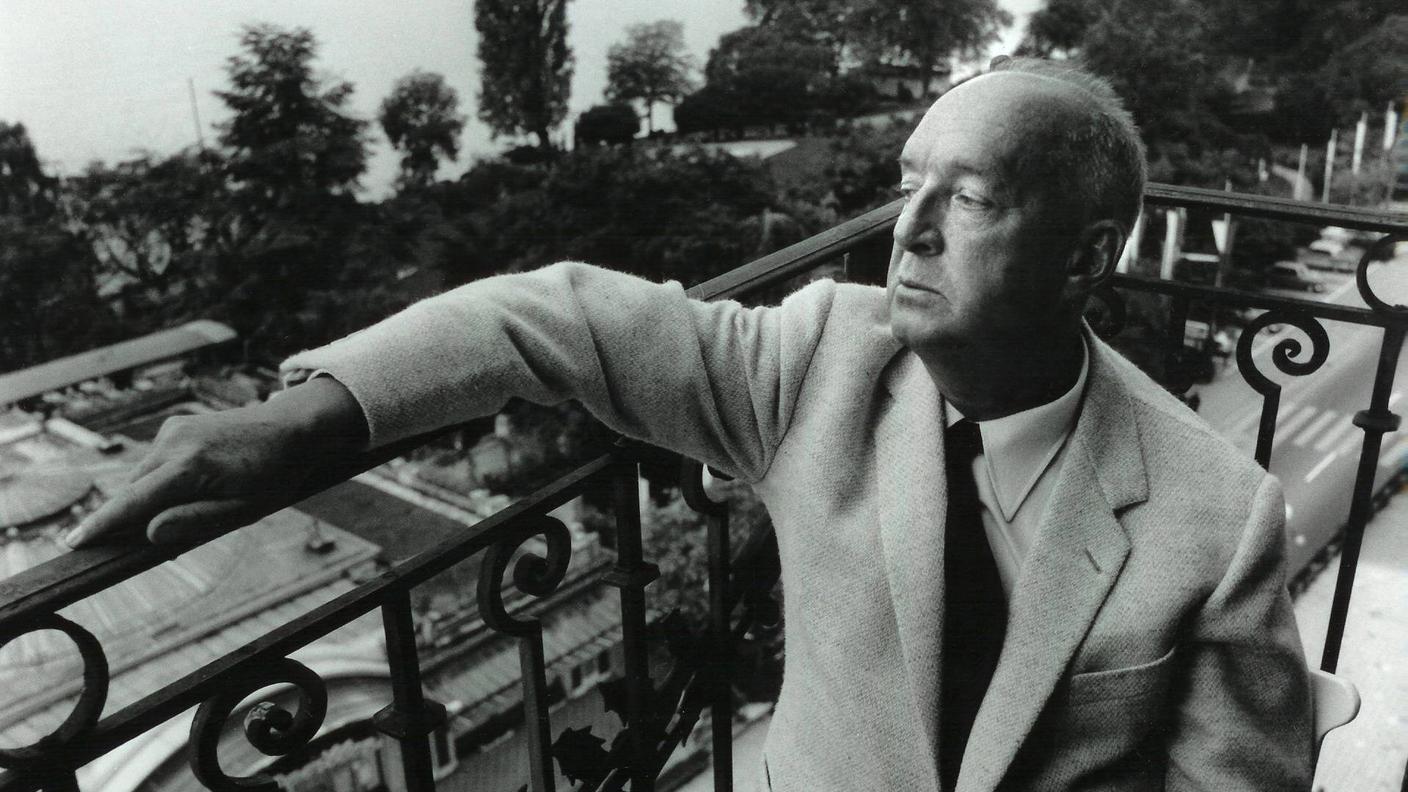Oggi sono largamente e colpevolmente negletti, oppure relegati in qualche nota a margine del canone letterario, ma all’epoca avevano goduto di una discreta fama, al punto che erano stati ribattezzati la triade dei “letterati ciclisti romagnoli”.
Il capostipite, se non altro per motivi cronologici, è stato Olindo Guerrini alias Lorenzo Stecchetti, forlivese di nascita ma ravennate di origine e bolognese d’adozione. Narratore, poeta e polemista, capo console a partire dal 1897 del neonato Touring Club Ciclistico Italiano, Guerrini/Stecchetti è l’autore del libro In bicicletta (1901), una raccolta di saggi, ricordi e divagazioni sulle due ruote intese quale coordinata esistenziale.
La parola del giorno: bicicletta
Tra le righe 02.05.2025, 14:30
Contenuto audio
«Nel roseo lume della prima aurora, / Nella vermiglia pace dei tramonti, / O nel meriggio che avvampando indora / La messe al piano e la vendemmia ai monti, / Sovra il ferreo corsier passo contento, / Come a novella gioventù rinato, / E sano e buono e libero mi sento!»: così dicono alcuni suoi versi in onore del “velocipede”, come lo si definiva ai tempi.
Versi un po’ ingenui e retorici, forse, ma non privi di sincera passione e di un fondo di verità, esattamente come le sue simpatiche e tutt’altro che banali riflessioni sul rapporto che intercorre tra la pedalata (en touriste, ovviamente, non a livello agonistico) e la “cerebrazione”, dove per “cerebrazione” bisogna intendere il cinema naturale, fatto di pensieri idee e immagini, che si svolge nella mente del ciclista.
Nel primo decennio del Novecento, infatti, dopo un breve periodo durante il quale era stata un simbolo di eccentricità per le classi più abbienti, la bicicletta entrò nell’uso comune e venne più realisticamente considerata un modo efficace per muoversi a ritmi più rapidi rispetto al viaggio a piedi, ma pur sempre umani e per così dire più indipendenti rispetto a quelli fissati, stabiliti e imposti dai mezzi meccanici come la ferrovia, coi suoi rigidi orari di partenza e arrivo. Quanto all’automobile, oltre che troppo costosa, sarebbe stata troppo veloce, rumorosa e invadente per i “letterati ciclisti”, che vedevano nel silenzio e nella lentezza uno stile di vita e una forma di approccio alla realtà.

Ciclismo e letteratura
Laser 22.09.2009, 02:00
Contenuto audio
Il secondo “letterato ciclista” è stato Alfredo Oriani, storiografo e narratore, originario di Faenza ma vissuto prevalentemente nel borgo di Casola Valsenio nei pressi di Imola, al quale si deve la raccolta di novelle La bicicletta (1902), il cui spunto venne fornito da un’autentica impresa da randonneur compiuta cinque anni prima, in un caldissimo agosto, con temperature che sfioravano i 40 gradi: un ardimentoso viaggio in solitaria dalla Romagna alla zona di Siena – poco meno di seicento chilometri, con oltre seimila metri di dislivello – in sella alla leggendaria “Bremiambourg” da corsa a scatto fisso.
Lo stesso Oriani ha fornito un’ottima risposta alle celebri parole di Pascal sull’incapacità dell’essere umano di starsene a casa propria: «Il piacere della bicicletta è quello stesso della libertà, forse meglio di una liberazione. Andarsene ad ogni momento, arrestandosi alla prima velleità di un capriccio, senza preoccupazioni come per un cavallo, senza servitù come in treno. La bicicletta siamo ancora noi, che vinciamo lo spazio e il tempo».
Perché è soprattutto in bicicletta, anche in virtù della “cerebrazione” teorizzata da Guerrini/Stecchetti, che percepiamo noi stessi come meri corpi nello spazio e ci liberiamo (dovremmo liberarci) di tutte le zavorre dell’io: «Ognuno di noi è un nomade che ha perduto la patria, le stagioni c’invecchiano senza mutarci, la morte ci coglie misteriosa come la vita. E le generazioni passano simili agli individui, interrogandosi senza che la corsa possa interrompersi un istante e senza altra gioia che nel suo impeto stesso, nell’oblio momentaneo dell’arcana inutilità».

Ciclismo e neorealismo
Laser 24.09.2009, 02:00
Contenuto audio
Il terzo, ma non ultimo per importanza, è stato lo scrittore, lessicografo e umanista Alfredo Panzini. Nato nel 1893 a Senigallia nelle Marche ma originario dell’odiamata Rimini (che allora si fregiava del titolo di “Ostenda d’Italia”: «Un grande ritrovo mondano, e in esso un casinò che porta un titolo molto onorevole e signorile»), morto a Roma nel 1939 e autore tra l’altro del monumentale Dizionario moderno nonché di una pregevole e sempre utilissima Grammatica italiana, nel luglio 1903 Panzini percorse in cinque giorni su due ruote il tragitto da Milano, dove all’epoca insegnava latino e greco in un ginnasio, a Bellaria, il borgo marinaro della sua infanzia («le natie glebe», secondo la sua stessa definizione).
Quattro anni dopo, nel 1907, raccontò il viaggio in un libro, La lanterna di Diogene, che è stato più volte ristampato, è tuttora in commercio e costituisce una specie di classico del genere. Più di un secolo dopo, e non solo per l’oggettivo valore letterario e la qualità di scrittura (Panzini scriveva benissimo, in un italiano arioso e sorvegliatissimo, ricco di preziosità sintattiche e felicissime invenzioni lessicali), La lanterna di Diogene non ha perso nulla quanto a impatto e suggestione, anche perché il suo assunto di fondo – la «fuga dalla civiltà idiota», l’idea del silenzio e della lentezza come stile di vita – è più che mai valido proprio nelle sue credenziali romantiche, utopiche e demodé.
La fuga su due ruote dal «chiacchiericcio» della «civiltà idiota», scrive Panzini ragionando sullo scopo del viaggio in bicicletta da Milano alle «natie glebe», si identifica principalmente col recupero di tutto quanto è stato messo a repentaglio dalle magnifiche sorti e progressive e dalla vita nelle metropoli, dove «è necessario possedere un sistema nervoso fabbricato appositamente»: la natura silenziosa e incontaminata, la distesa del mare che evoca il tutto e il nulla e dovrebbe indurre a profondi pensieri (ma il condizionale è d’obbligo, come ricordava velenosamente Flaubert e come testimoniano molti arenili nella stagione balneare), più in generale una dimensione priva di scissioni, fratture e lacerazioni. Meno astratta, si vorrebbe quasi dire: meno disumana.
Ma è perfino più importante e dirimente tutto quanto ci si lascia alle spalle e si perde e sfuma e infine scompare nella lontananza, nei sudari delle caligini di Milano e delle altre metropoli del (presunto) progresso: la «tirannide sociale» e il «ridicolo del mondo» (una sapida quanto geniale variazione sul positif du monde di un certo scientismo fin de siècle), dove «quattro individui vi conoscono di persona e due di nome», la carnevalata dei ruoli e delle funzioni nel cosiddetto consorzio civile, dove si è «dottore, professore, elettore, libero schiavo», mentre «il tram batte la sua furibonda campana, l’officina urla, l’uomo politico arringa davanti al suo baraccone». La bicicletta diventa quindi una visione del mondo (anche nel senso letterale: un’educazione dello sguardo) e lo strumento adatto per tutti «gli scioperanti della vita sociale, i disertori di questa miserevole milizia, i ribelli che non vogliono più recitare la farsa, gli stanchi dello spettacolo dei bussolotti, i facchini tediati del peso». Parole bellissime, non c’è che dire. E soprattutto invecchiate benissimo.
«L’undici di luglio, alle ore due del pomeriggio, io varcavo finalmente, dall’alto della mia vecchia bicicletta, il vecchio dazio milanese di Porta Romana. La meta del mio viaggio era lontana: una borgata di pescatori su l’Adriatico, dove io ero atteso in una casetta sul mare; questa borgata supponiamo che sia non lungi dall’antico pineto di Cervia e che, per l’aere puro, abbia il nome di Bellaria»: l’incipit del viaggio di Panzini, che fin da subito sembra volgersi verso l’idillio, non deve trarre in inganno. Dopo le soste a Lodi, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Rubiera e Modena, il “letterato ciclista” prende dapprima una deviazione per l’Abetone (dal quale fugge immediatamente, inorridito dall’ambiente dei nouveaux riches), torna sulla via Emilia, sale lievemente verso Savignano e infine – attraversando “villaggi trogloditici” – arriva al mare seguendo il corso del Rubicone.
Qui subentra lo storico e latinista, che si produce in una definizione che sarà sicuramente avallata da chiunque abbia visto coi propri occhi, nella stagione estiva, lo stento rigagnolo che lambisce la cittadina romagnola e passa sotto un ponticello sovrastato dalla statua di Giulio Cesare: «Un fiumicello che va tanto superbo di un suo illustre nome antico». E’ qui che si sarebbero decise illo tempore le sorti del mondo?, si domanda Panzini. Non siamo molto lontani dalle pagine de La Certosa di Parma di Stendhal, quando il protagonista Fabrizio Del Dongo partecipa alla battaglia di Waterloo e nella generale confusione non capisce – non può capire – che in quel momento si sta facendo la Storia.
Non mancano, soprattutto nella prima parte, pagine ariose e ricche di squisite citazioni letterarie (i classici greci e latini, e poi Ariosto, Tasso e il diletto Teofilo Folengo, ma in filigrana si avverte anche il già ricordato Stendhal de La Certosa di Parma), così come non manca il doveroso omaggio a Giovanni Pascoli in quel di San Mauro, dove il carducciano Panzini visita il camposanto che ha fornito lo spunto per le Myricae: «L’afa era grande come grande era il silenzio. E le scritte mortuarie, stampate e affisse su le pareti di una cappelletta, si staccavano, si accartocciavano e si confondevano lente, così come la memoria degli uomini del pari si accartoccia e, un po’ per volta, si stacca».
Pedalata dopo pedalata, mentre il mare si avvicina e si profila all’orizzonte coi colori accentuati dal vento di levante («verde e livido più che azzurro, con lunghe file di schiume bianche»), Panzini ha un’impressione sempre più vivida e venata di sconforto: la fuga dall’idiozia della civiltà e dalla flaubertiana bêtise è ormai impossibile, perché la prosa del mondo (la speculazione, la cementificazione, la bieca e infame avidità di guadagno, più in generale il cuore di tenebra dell’animale-uomo) è arrivata dappertutto e ha intaccato anche l’idillio dei borghi marinari. La cifra di questa trasformazione è costituita dall’abbattimento di un bosco di pini lungo la «via ferrata tra Cervia e Bellaria», al quale è dedicato uno degli ultimi capitoli: «Vidi i più belli di questi pini segnati con una croce di vernice rossa. La selva dei nobili pini era stata comperata da un ingordo speculatore; questi aveva, alla sua volta, ceduto per trenta lire ogni pino. Un mattino, dal largo del mare, gli occhi si volsero sul litorale, al luogo ove cento colonne elevavano il loro padiglione meraviglioso. E non c’era più nulla!». Quasi inutile aggiungere che oggi la zona è interamente cementificata.
Diceva Carlo Levi, viaggiatore curioso e attentissimo in terre vicine e lontane, che nel viaggio è presente «una frattura che è sempre una fuga, un’inconsapevole ricerca, uno scampo, un abbandono». La conseguenza è un voluto sfalsamento prospettico, perfino un paradosso: forse non viaggia veramente chi viaggia, ma piuttosto coloro che restano e «viaggiano all’indietro nel tempo immobile». Il che è sostanzialmente vero, anche se forse c’è una verità ancora più vera, sicuramente più amara e dolorosa. Una verità che si esprime in una domanda: «Andarsene, fuggire dalla “civiltà idiota”, ma dove?».

Il litorale romagnolo al tramonto, 2022
Lo scettico e malinconico Alfredo Panzini, osservando la realtà dalla sella della sua bicicletta, è stato tra i primi a porre la domanda. Qualche decennio dopo, la triste quanto fatale risposta verrà fornita da un altro scettico malinconico, Ennio Flaiano, che detestava il moto in tutte le sue forme e aveva eletto la “pigrizia” (nel senso più nobile) e il “tempo perso” a programma esistenziale e forma perfetta della “cerebrazione”: è inutile fuggire in cerca di chissà quale endroit écarté o della celebre “isola deserta”. Perché ormai non è deserta, non è nemmeno più un’isola. E’ piuttosto un luogo qualsiasi, a due passi da tutto e da niente, e assomiglia maledettamente alla sordida, “civile” e “idiota” periferia che a sua volta si è divorata il centro. Lontano da dove? Lontano da cosa? Al termine del viaggio (di ogni viaggio), suggerisce Panzini, rimane soltanto la voce del mare.
Ray Bradbury, l’autore del celeberrimo Fahrenheit 451, l’aveva definita “era del mollusco”, prefigurando una mutazione antropologica ormai pienamente in atto: «La mente si nutre sempre meno. Impazienza. Ammazzare il tempo. Niente lavoro, solo tempo libero. Superstrade piene di gente che va da qualche parte, ovunque, in nessun posto». Il suo conterraneo e predecessore Oriani aveva parlato invece di «una migrazione di tutti verso tutti». Da qualche parte, ovunque, in nessun posto: Alfredo Panzini, in sella alla sua bicicletta, nel viaggio dalle caligini di Milano alle “glebe natie”, è stato tra i primi ad averlo capito e lo ha espresso nel passo maggiormente rivelatore di tutto il resoconto: quello che si potrebbe definire il sogno del casellante.
«Sventolare la bandiera a questi piccoli treni, salutando reverentemente la vita che passa, e godere intanto questa solitudine, questa santissima quiete, dalla quale passerei senza avvedermene, senza contrasto, a più sicura pace, sepolto qui, presso questo mare, con una scritta che io vorrei dettata così: “Exaudiam vocem maris”. Altro non chiedo». La preghiera (rigorosamente laica) è stata esaudita: il “letterato ciclista” Alfredo Panzini riposa nel piccolo cimitero di Canonica, nei pressi di Santarcangelo di Romagna, non lontano dall’amatissimo mare, dai suoi orizzonti, umori e colori, dal suo tutto e dal suo nulla. Sulla lapide, accanto agli estremi biografici, campeggia la scritta: «Ascolterò la voce del mare».