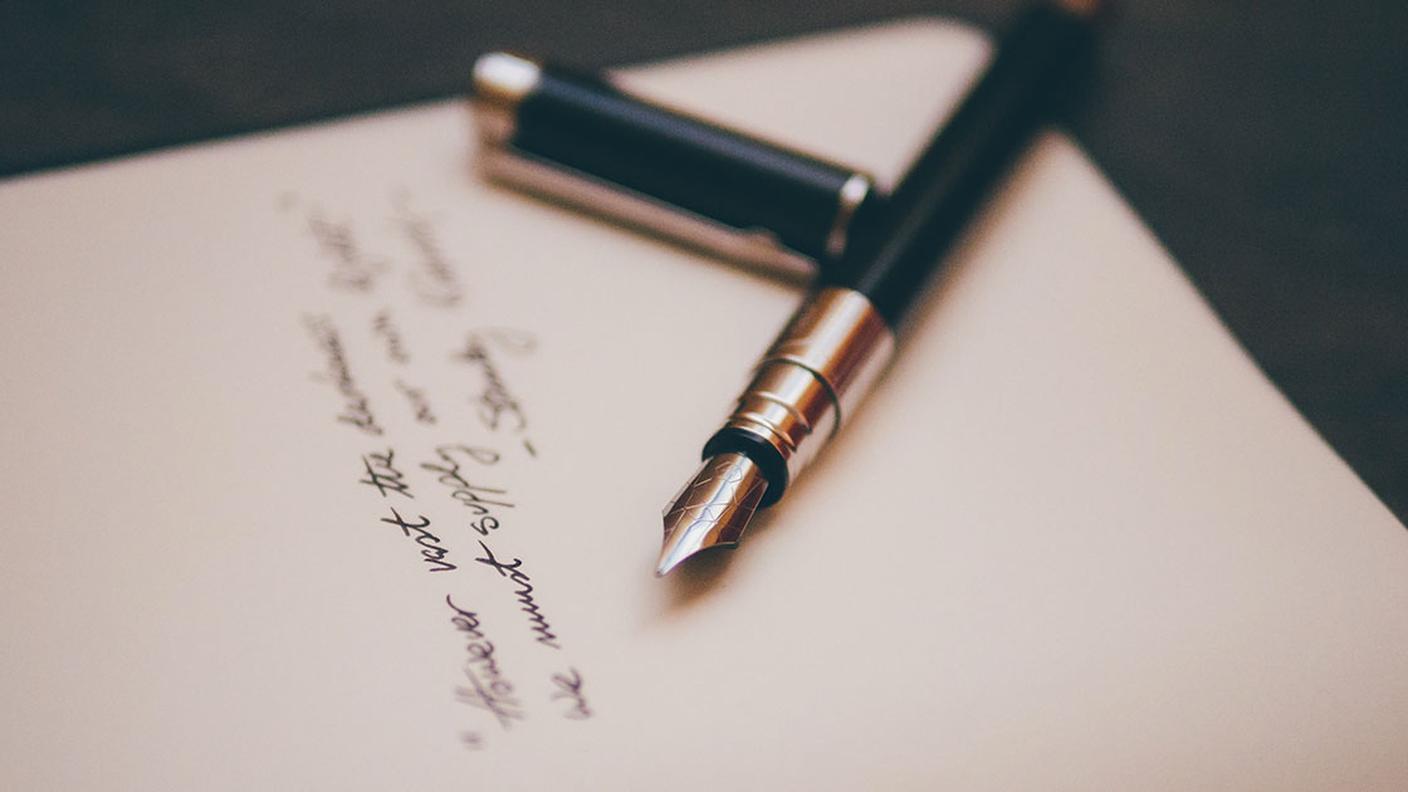Sabato 13 settembre verrà assegnato a Venezia il Premio Campiello, tra i più importanti riconoscimenti della letteratura italiana. Il settimanale radiofonico letterario di Rete Due Alice ha ospitato i cinque scrittori finalisti in altrettante interviste, che qui riproponiamo nella versione integrale. Dopo quelle con Fabio Stassi, Alberto Prunetti, Wanda Marasco, e Marco Belpoliti, chiudiamo con Monica Pareschi, autrice di Inverness (Polidoro).
Monica Pareschi è una scrittrice poco prolifica, perché è una traduttrice molto prolifica: il suo lavoro principale impegna già gran parte delle sue giornate, tra le sorelle Brontë, Shirley Jackson, Thomas Hardy e molti altri. La sua produzione letteraria propria, però, scarsa per quantità, è di altissima qualità.
Inverness è la sua ultima raccolta di racconti, otto storie inevitabilmente diverse ma accomunate da protagoniste femminili, e dal fatto di essere – perdonate la banalità – storie umane, di amore, sesso, relazioni. A volte, anche, relazioni con gli animali: gabbiani, conigli e pesci. Ma la prima caratteristica che rende raro questo Inverness all’interno del panorama editoriale italiano è – incredibile a dirsi – il fatto che si tratti di un libro di racconti. Perché le short stories pare che nell’editoria italiana non le voglia pubblicare nessuno, e nessuno le compri. Possibile?
“Inverness”
Alice 06.09.2025, 14:35
Contenuto audio
«Devo confermare che esiste uno stigma nei confronti del racconto – dice Monica Pareschi – Esiste da quando lavoro in editoria: sono traduttrice da più di trent’anni e ne ho sempre sentito parlare. E ho sempre sperato di tradurre racconti, perché è una forma che mi piace molto, ma sono riuscita a tradurne pochissimi. Di Shirley Jackson, ad esempio, ho tradotto romanzi, non racconti. Ultimamente ho lavorato su Katherine Mansfield, che sogno di tradurre integralmente prima di appendere i dizionari al chiodo.
Credo che questo pregiudizio sia molto italiano, forse europeo, meno americano. Negli Stati Uniti c’è una tradizione editoriale più solida legata ai racconti. Sì, autori come Flannery O’Connor sono riusciti a imporsi anche in Italia con i racconti, ma servono nomi già molto letti e famosi. Per un’autrice come me, pubblicare una raccolta di racconti è decisamente meno scontato».
Michele R. Serra: Chissà perché, poi. La forma breve è incredibilmente affascinante, anche per gli scrittori stessi.
Io sono una lettrice di racconti, e penso che la forma breve offra vantaggi anche molto pragmatici. Alice Munro, ad esempio, diceva che scriveva racconti perché la sua vita familiare e lavorativa non le permetteva la costanza di scrittura necessaria per un romanzo, e io mi riconosco molto in questo: lavoro tutto il giorno come traduttrice, quindi scrivo “per interposta persona”, e trovare il tempo per lavorare regolarmente su un progetto lungo è difficile.
Inoltre, quando traduco voci molto potenti, queste tendono a fagocitare la mia. Ho bisogno di vuoto intorno, di silenzio, per sviluppare una scrittura mia, una qualche originalità.
E in fondo, avere meno spazio per le spiegazioni a volte può essere anche un vantaggio.
Assolutamente. Il racconto è, per me, un luogo di sperimentalismo più ardito rispetto al romanzo proprio perché si fonda su salti, vuoti, lacune. È una forma più “matematica”, dove tutto deve tornare, altrimenti non regge. Mi piace paragonarlo al sonetto, rispetto al verso libero del romanzo.
Confesso anche di essere molto pigra: il racconto si conclude presto, si ha subito qualcosa in mano. Il romanzo richiede una tenacia che forse non ho. E poi, per come funziona la mia mente – per analogie, illuminazioni improvvise, salti – il racconto mi corrisponde molto. Non penso in modo lineare, e il racconto accoglie questa mia propensione.
“Inverness” di Monica Pareschi, Alessandro Polidoro Editore (dettaglio di copertina)
Il racconto che dà il titolo alla raccolta è l’unico che si volge in un tempo riconoscibile. Gli altri sembrano privi di riferimenti precisi. È una scelta consapevole?
In realtà no, è successo abbastanza naturalmente. Non ho una grande preoccupazione per il “qui e ora”. Anche se un argomento mi interessa a livello personale o politico, non diventa mai fonte diretta di ispirazione. Spero di non sembrare magniloquente nel dirlo, ma penso di non scrivere per questo momento, ma per un tempo più vasto.
In queste pagine insiste spesso sulla vita materiale più sgradevole: la sporcizia, la puzza, la bruttezza… A cosa serve questa insistenza? A demolire stereotipi? Ad affermare qualcosa sull’uomo?
Credo sia parte del mio sguardo, e lo dico perché non credo che nessuno scrittore si metta a tavolino e dica: ok, adesso voglio scrivere in questo modo… Rileggendomi, mi rendo conto che cerco di mettere in luce trame sotterranee della vita quotidiana, elementi con cui spesso preferiamo non fare i conti. Il non detto, il non presentabile, l’osceno in senso etimologico. Tutto questo ha un correlativo oggettivo nella fisicità.
I paesaggi che attraversano i miei personaggi sono paesaggi interiori, ma hanno bisogno di un corrispettivo materiale. Non amo un’introspezione troppo “spiegata”, e mi piace che tutto emerga a livello concreto, palpabile. Forse è anche il mio essere traduttrice di autori anglofoni: nella scrittura anglosassone c’è spesso più concretezza rispetto a quella italiana. Mi sento una scrittrice italiana per caso: all’anagrafe sì, ma nella sostanza molto poco.
Il titolo Inverness è anche il filo conduttore dei racconti? E cos’è, secondo lei, questa “invernità”?
Ho scritto il racconto “Inverness” abbastanza tardi, è uno degli ultimi della raccolta. Ero ancora alla ricerca di un titolo, e quando l’ho scritto ho notato che conteneva una parola che sembrava racchiudere l’atmosfera degli altri racconti: un senso di gelo, di freddo, di ragionamento. I personaggi sono molto desideranti, ma anche molto paurosi e bloccati. Inverness, per un lettore italiano, è un toponimo che evoca l’inverno, e in questo caso rappresenta un inverno interiore, un inverno dell’anima. Mi piace molto questa parola… devo dire che il titolo è una delle cose di cui sono più soddisfatta.
Nei racconti tornano spesso gli animali: gabbiani, conigli, pesci. C’è un significato simbolico dietro? O semplicemente, nella sua vita ci sono stati conigli domestici?
Conigli no, ma gatti sì! Mi piacciono molto gli animali, ho molta dimestichezza con loro, mi piace toccarli, non ne ho paura. Mi affascina la comunicazione non verbale tra esseri umani e animali, molto immediata.
Nei miei racconti gli animali sembrano dei messaggeri, degli araldi. Preannunciano personaggi o situazioni, proprio per la loro immediatezza, a volte ferinità, aggressività. Spesso l’inizio di un racconto nasce da un’immagine animale che mi ossessiona mentalmente: un coniglio che si muove in un certo modo, un gabbiano che fa qualcosa... Da lì si sviluppa la storia.
Questa comunicazione ferina degli animali fa da contraltare a personaggi umani molto “trattenuti”. Credo fosse Giorgio Agamben che diceva che lo stile è «impazienza trattenuta».
Se guardo alla mia raccolta precedente, di circa dieci anni fa, i racconti erano ancora più sorvegliati, molto corti, quasi esercizi di stile. La lingua era molto controllata, con una forte preoccupazione stilistica.
Negli ultimi tempi, invece, sento una maggiore distensione, una scrittura più libera, meno legata. È come se mi fossi liberata un po’ della “gabbia stilistica” del racconto. C’è una preoccupazione narrativa più distesa, meno rigida.
È come se si fosse liberata del problema di scrivere e fosse più tranquilla nel narrare...
Sì, è come se mi fossi liberata dell’editor interiore. Dopo trent’anni di traduzioni, sviluppi una capacità critica molto forte: smonti e rimonti testi, osservi gli scrittori in azione. Ma quando ti metti a scrivere, questa voce interiore può diventare limitante. Ti lasci poco andare.
A proposito di lasciarsi andare: in questi racconti si parla d’amore. E quindi, perdoni la formulazione stucchevole, ma… di che amore si tratta?
L’amore in questi racconti contiene molte cose, e alcune sono anche sgradevoli, ma inevitabili. L’amore è un vedersi, un lasciarsi vedere, un rinunciare agli schermi. E questo comporta un pericolo, sicuramente.