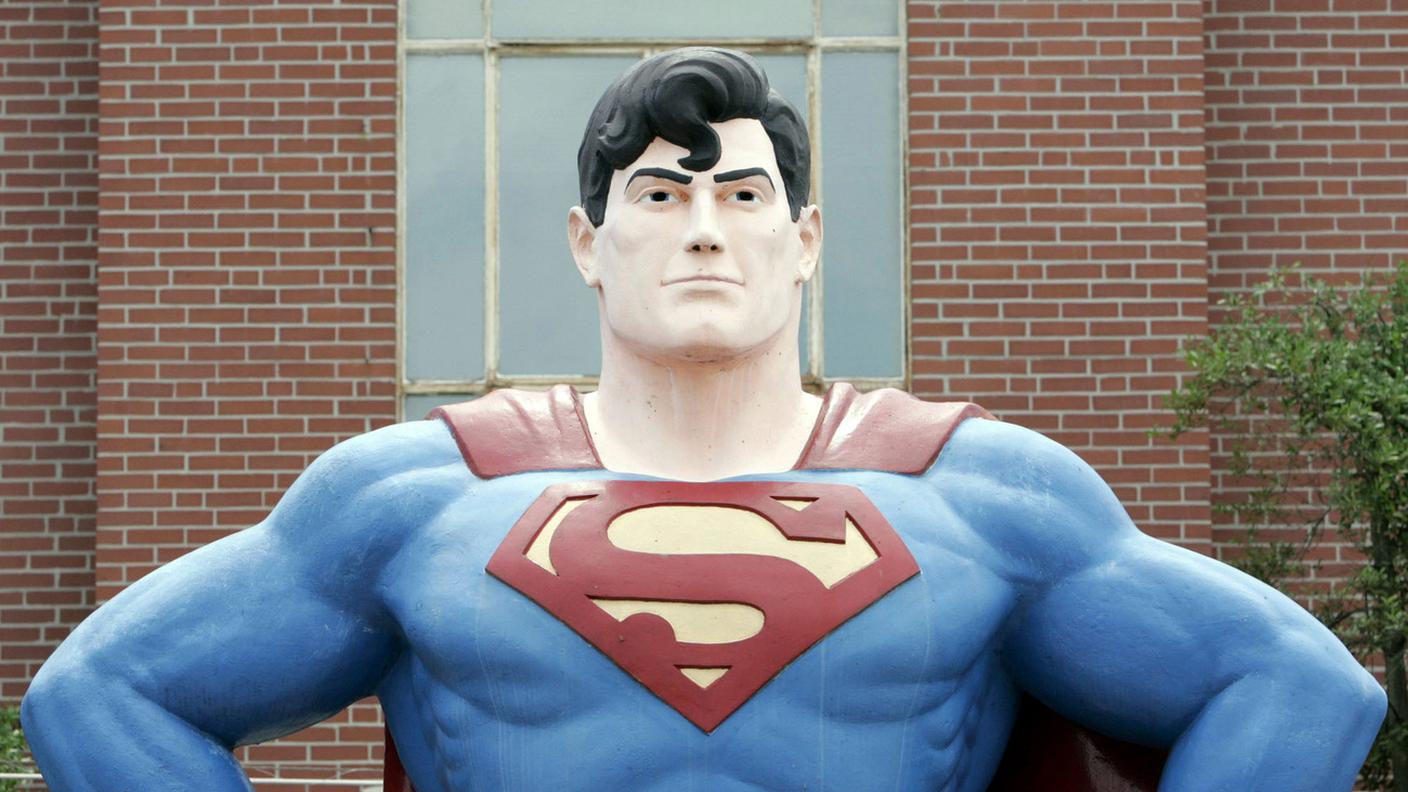«Prendo questa luce domestica, la piego / ne faccio sedie e scale / per scendere a gradini la tua assenza»: la poesia Indicibile di Antonella Anedda, possibile esergo di I dieci passi dell’addio (Einaudi 2024) di Luigi Nacci, ben si adatta anche al romanzo in versi Cemento e vento (Gabriele Capelli Editore 2025) di Noè Albergati. Nacci e Albergati, nelle pagine delle loro opere, hanno spezzato il silenzio: quello che regnava nelle loro case, quando si allontanarono dalle loro compagne, pur condividendo lo stesso tetto, quello che infine le due donne lasceranno. L’una, per ritrovare il sorriso da tempo spento; l’altra, per scomparire per sempre nel vento. Da lì, «il vuoto ad ogni gradino»: i due solitari ospiti affrontano una lenta discesa e risalita per quelle scale di montaliana memoria; due sentieri differenti e affini per la via dell’addio e in direzione di una nuova vita.
“I dieci passi dell’addio”
Alice 23.12.2024, 09:04
Contenuto audio
Luigi Nacci, poeta della “viandanza”, si sente come un «profugo che ha perso tutto», dopo essersi innamorato di un’altra donna e dover convivere con la sofferenza della e per la compagna amata e tradita, quell’invisibile presenza che «risucchia gli zigomi, le sopracciglia, le palpebre, le pupille», spegne la fame, trasforma un abbraccio in un penoso carezzare di scapole, e il mattino nel momento del «dolore puro», con le lacrime di lei che scorrendo sul suo viso al risveglio manifestano la sua disperazione, e i sensi di colpa di lui, conscio di essere «l’artefice dell’orrore». Vaga «cieco» in quella casa che non è più una casa, ma un «bivacco», evitando prima gli scatoloni dei ricordi impacchettati, e poi, procedendo in questo cammino dell’addio, trovando la forza di rileggere messaggi, post it, frammenti di vita quotidiana. Non gli unici testimoni di quell’amore, se non perduto, rimandato a un’altra dimensione: «le stanze di una casa in cui c’è stato un grande amore ricordano tutto». Mutano i nomi (la camera matrimoniale diventa la «stanza della resistenza», mentre la cucina è ribattezzata «masseria delle tristezze»), scompaiono gli oggetti di lei, ma i “reduci” del «bivacco» non smettono di parlare: «è colpa tua, ti sussurrano i chicchi di riso incastrati nelle fessure tra le mattonelle. Sei stato tu a distruggere l’amore, tu il barbaro, ti dice il tritacarne. Austero, scintillante, mai utilizzato».
In I dieci passi dell’addio, troviamo pure dei passaggi, come questo, che fra il serio e il faceto, riformulano l’esperienza vissuta da Nacci, ed anche delle amare e ironiche proposte: bisognerebbe formare «i giornalisti dell’addio», di modo che siano più sensibili su certi argomenti; istituire una «banca degli amori perduti» con relativi agenti che setaccino soffitte e scantinati, lettere e fotografie; e sancire il diritto di «congedo per lutto alla fine di una storia». Perché quando finisce una storia, non solo si perde la propria metà, ma tutte le persone a lei/lui legate: amici e parenti. Affetti ma anche «gabbie», «ragnatele», «trappole», a detta di Nacci, che a parer di chi scrive scivola talvolta in delle banalità ineleganti, quelle che lui stesso definisce dei «pensieri piccoli» e «poco originali». Vale a dire quando cerca di idealizzare la sua “deviazione dalla rotta”, screditando le relazioni altrui (quasi tutte infelici, parrebbe, unicamente legate ai «figli del disamore» che «fungono da collante») e biasimando i cosiddetti «rituali di coppia» che non sono altro che le piccole tradizioni che, presto o tardi, è naturale che si instaurino: «Volevo andare fuori sentiero con un’altra persona. […] Per non finire imbottigliato in un traffico qualunque, per non morire in una pizzeria la domenica sera, tra gli squilli dei telefonini, i cornicioni ripieni di ricotta, i bambini che urlano, i genitori che urlano, i tatuaggi fatti tanto per fare, il limoncello, il conto, domani è lunedì».
“Cemento e vento”
Alice 21.06.2025, 14:40
Contenuto audio
Ad essere brutalmente onesto è Noè Albergati: un «Orfeo allucinato», «ubriaco di dolore», che si illude di potersi voltare e ritrovare lo sguardo della donna amata e persa per sempre: «io so / in sette anni di aver dato tutto per lei / ma so anche in sette mesi di aver fallito / da qualche parte / non essere stato capace di connettermi / di raggiungerti in quella distanza». Agosto-Marzo. Poco più di duecento giorni possono trasformare una donna felice in una perduta Euridice e un uomo in un «Orfeo allucinato» (e viceversa). Tra i tanti meriti di Cemento e vento c’è quello di essere un duro monito a non sottovalutare la depressione, rivolto sia a chi la vive in prima persona sia a chi ne soffre di riflesso. «Ho una vita perfetta»: sono queste le prime parole della donna che leggiamo; giorno dopo giorno, riga dopo riga, la vediamo combattere ma anche “nascondersi”, ripetere «Adesso sto bene», presto passerà: «sigaretta / gomma da masticare / e nervosa vuoi riagganciare la vita / […] / Scegli ancora la fuga, la negazione del problema / ottundi il disagio con l’azione». Il «filo verde di speranza» che provano a tessere per lei amici e parenti è «troppo fragile» per ricucire un mondo crollato in pezzi; nella disperazione son più tenaci i «fili vischiosi di una scura ragnetela» da cui non riuscirà a liberarsi. La diga, «calamita di vuoto», infine fatalmente la attrarrà: «cemento e vento / vuoto / poi roccia e acqua ghiacciata / il tuo ultimo sorriso / con i denti e le gengive rotti».
La «casa vuota» è paradossalmente «meno triste / meno ostile nei suoi silenzi», perché l’assenza di lei, un tempo così solare e loquace, implica l’impossibilità di vederla spenta e ammutolita dalla depressione. La distanza che li separa irrimediabilmente, li fa riavvicinare: solo facendo riemergere dal gorgo del dolore il vero volto di lei, lui riesce a ritrovarla e capirla. «Macerie da cui ripartire»; i relitti, gli ostacoli da affrontare, sono i sensi di colpa e quelli che Luigi Nacci chiamava i «cataloghi dei se», che consigliava di stilare per poi bruciarli, e a cui pure Albergati non cede: «Non mi interessa contare gli errori / […] o incastrarmi in adescanti sliding doors […] da cui si genera solo tempo involuto». Senza per questo edulcorare il suo racconto o censurare le parole dette al culmine dell’angoscia: «Vai dove cazzo ti pare / le ultime parole che hai sentito / che ti ho detto / dopo sette anni di ti amo / di affetto / prima dei tornanti fino alla Verzasca […] sette anni percorsi assieme troncati / sul ciglio / e la colpa non colpa perché io so / perché tu sai che ci siamo stati vicini / fino a che si poteva / fino all’ultimo precipizio».
Far riemergere la memoria di lei. Della vera lei. Dei momenti felici. Salutare ogni reliquia del passato («ogni nuovo vuoto nella casa / un altro piccolo addio»), e guardare al futuro: «averti solo nella memoria / a evolverti con me / non legata / a oggetti inerti». Accettare che «un ti amo non mette le ali», arrendersi alla realtà: «Amor non omnia vincit / - anche se ammaliante da commedia - / ma avvicina di certo alla serenità». “Orfeo” riesce infine a voltarsi, a ritrovare lo sguardo della donna amata, non più adombrato da una «luce scura d’ossidiana», per guardare oltre, insieme a un’altra compagna («tu come sostituzione rimpiazzo / forse tutto è nato così / […] se sono felice in questo noi / importa l’innesco?»). Interiorizzare, in un certo senso, «la frase di tutti» di cui parla Anedda: «è morto, siamo vivi». «Siamo liberi, siamo vivi», come recita l’ultimo messaggio della donna tradita da Nacci, quando ritrova il suo sorriso, e andrà per la sua strada.