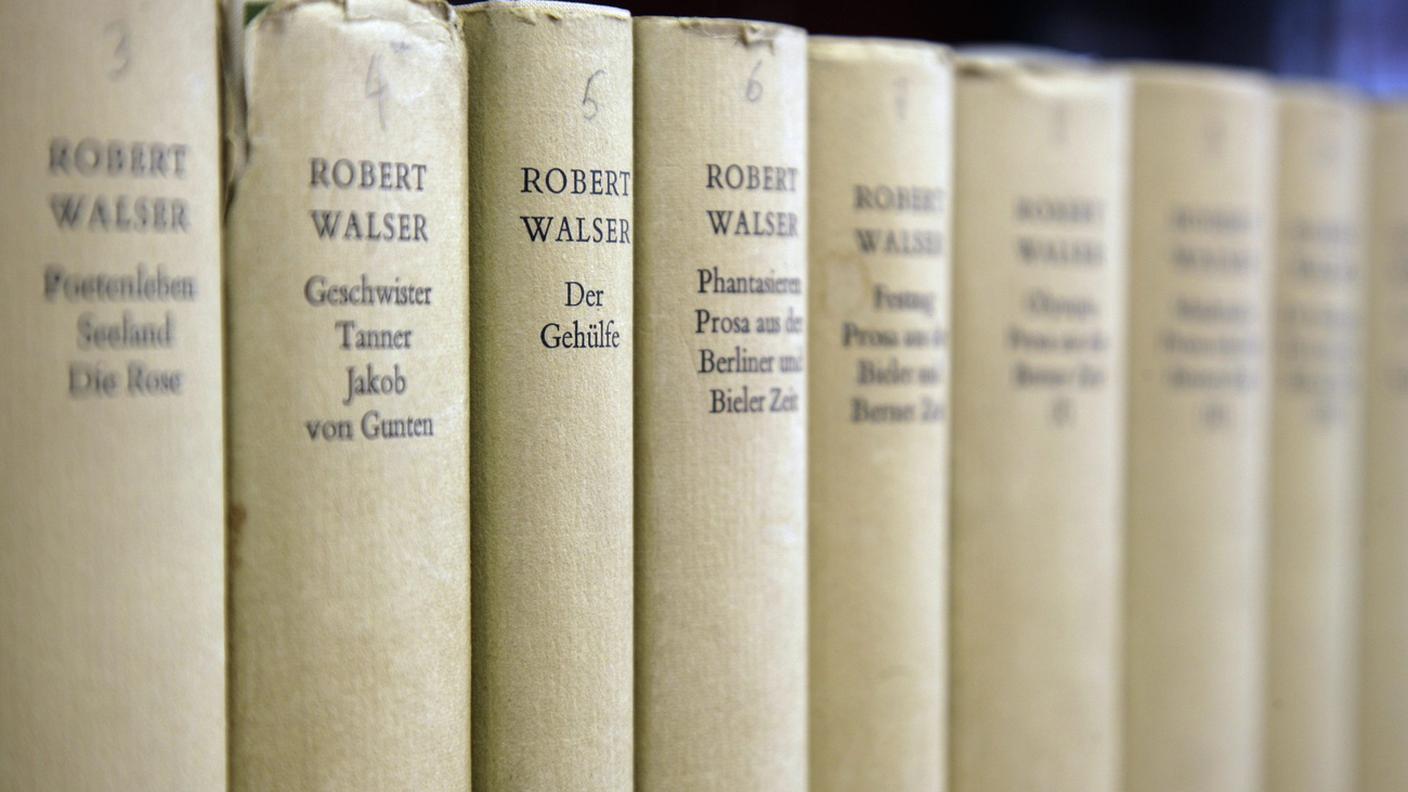Quando un grande filosofo incontra un grande poeta i sensi sono di solito avvertiti alla diffidenza. Espletandosi di norma l’agire del pensiero filosofico nel quadro della comprensione – che volentieri travalica e rapprende il sentimento – siamo infatti quasi sempre naturaliter in una sorta di manque: alla lettura filosofica “mancando”, inesorabilmente, quella resa all’imponderabile che è dello spirito poetico, esaurito il quale la poesia non avrebbe più ragion d’essere se non nella sua decifrazione.
Ragione sufficiente e ampiamente rivendicata dagli stessi poeti per reclamare la maliziosa “incomprensibilità” della poesia, sulla cui inesauribilità nemmeno i filosofi (e i poeti medesimi) hanno una sola parola da spendere. Tanto che Montale diceva a chi lo sottoponeva all’ennesima e ulteriore interpretazione dei suoi Ossi di seppia: “Non pensavo, francamente, di aver scritto tutto questo”. E al più compassato Luzi di fargli eco con un pacato: “Io stesso scopro oggi nelle mie poesie echi e luci che non avevo mai individuato”.
A riprova – se servisse rimarcarlo – che laddove esiste una pretesa di comprendere la poesia (o laddove il filosofo accampi una verve interpretativa che aspiri alla “compiutezza”) possiamo stare certi che la poesia si ritrae sdegnosa un passo più là. E soprattutto a riprova che la lezione di Nietzsche non ha mai cessato di imperversare: se ogni filosofia è “sperimentale” è perché scaturisce dall’incontro inesauribile tra un oggetto di verità e un soggetto veritativo che potrebbe essere in ogni momento superato o denegato dall’esegeta successivo.
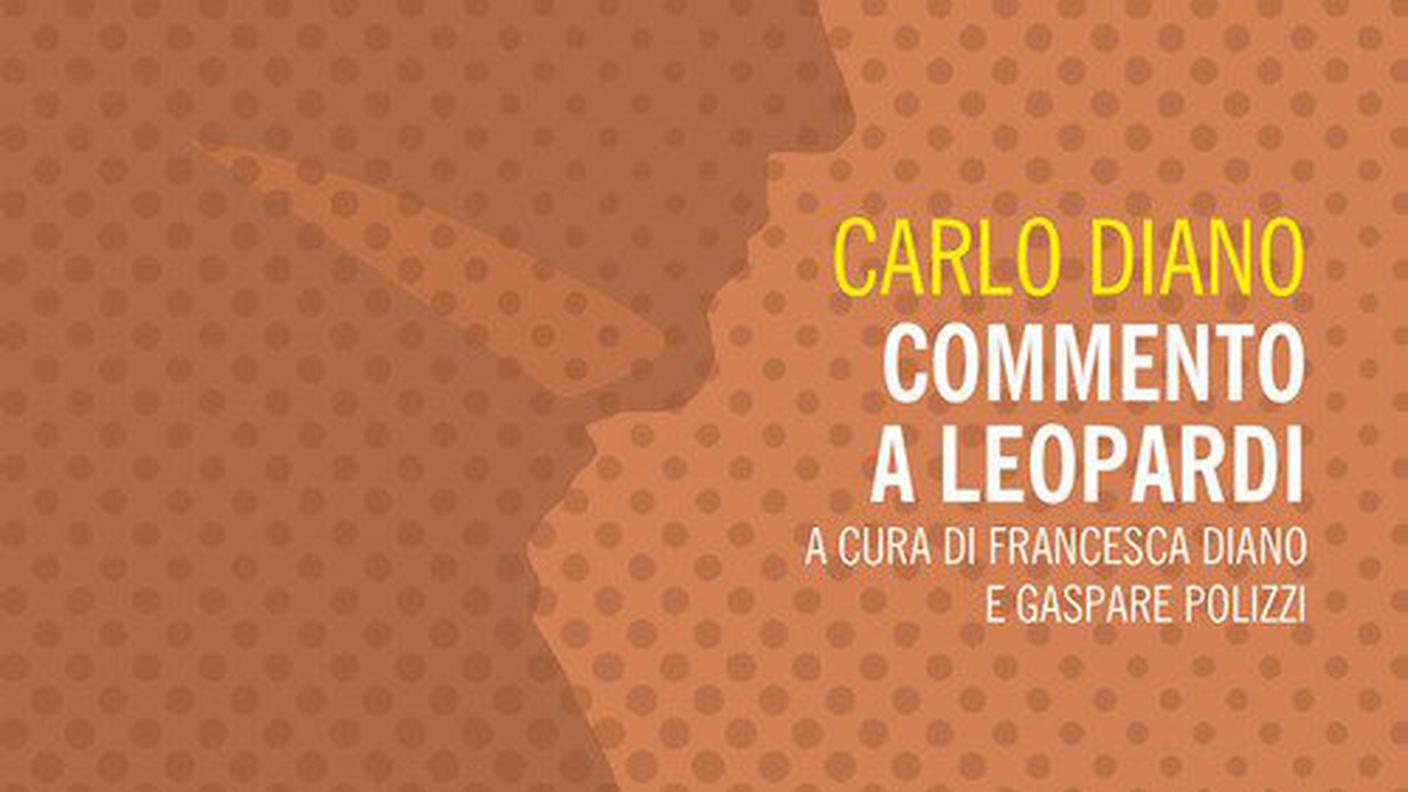
Bene dunque ha fatto, nel suo prezioso Commento a Leopardi riproposto ora da Mimesis, con gli interventi della figlia Francesca Diano e di Gaspare Polizzi, il “grande filosofo” Carlo Diano (1902-1974) a non sfidare il “grande poeta” Giacomo Leopardi sul piano della sua incommensurabilità, concentrando viceversa il proprio ragionamento di “soggetto veritativo” non tanto sul significato delle opere del Recanatese bensì sul rapporto che alcuni suoi componimenti intrattengono con la vita: da intendersi come oscillazione di stati d’animo, sentimenti, incontri, occasioni e condizioni sociali e psichiche che precedono e accompagnano la gestazione dei versi e riverberano su di essi i propri moti.
E questa edizione ha un particolare interesse proprio perché rivela aspetti del tutto inattesi della personalità del giovane Diano, testimoniando quali profondità del proprio animo egli abbia sondato grazie allo studio di Leopardi. La figlia Francesca si è avvalsa dei preziosi quaderni preparatori della tesi, rinvenuti di recente nell’Archivio del padre, così come dell’epistolario, in questo modo gettando una nuova luce sulla reale portata di questo lavoro giovanile, che pur rappresentando un approccio “anomalo” rispetto alla produzione successiva ne è in qualche modo la straordinaria anticipazione.
La scelta di Diano, eclettico frequentatore dello scibile in quanto tale, di misurarsi senza sfidarlo con il “grande poeta” ci consente pertanto di riconoscere un dato che l’ermeneutica leopardiana non sempre ha posto nella giusta luce: non tanto il peso determinativo e determinante che la vita infelice di Leopardi ha avuto sulla sua produzione, ma l’importanza cruciale che l’apertura alla vita e al mondo hanno assunto per la qualità stessa delle sue poesie. Un dato apparentemente scontato, ma che lungi dall’essere tale è viceversa decisivo per comprendere – nel senso meno limitativo del termine – uno dei fondamentali perché della tardiva e irreversibile passione per la sua opera: perché nessuna poesia degna di immortalità è potuta nascere fuori dal connubio tra vissuto e pensato.
Leopardi lo intuì nella disperazione, ma prima ancora nella disperazione lo assunse a proprio principio creativo sacrificale: laddove, insieme al fratello, il padre lo volle obbligato alle sconfinate strettoie dell’erudizione, egli seppe impastare l’immenso sapere (e amore) che andava coltivando per i Classici con l’immensa crudeltà che il mondo aveva in serbo per lui, al punto da offrirsi alla vita quasi con il pathos martiriologico di chi attinge al dolore per ricavarne poesia.
Di più: egli intuì, ed eroicamente accettò, che il sapere (che per lui fu eminentemente sapere nullistico, sapere della vanitas di ogni cosa) fosse nella compenetrazione tra vita intellettuale e vita esperienzale, in quella feconda intercapedine in cui la parola ascende dal sangue e discende dal pensiero per distillare quel che nessun lessico può fermare altrimenti che nell’irrefragabile termine Poesia.
Una lezione, quella di Leopardi, che Diano traduce a sua volta in lezione per chi voglia misurarsi oggi con la Letteratura. Si può leggere, studiare molto, si può, come Harold Bloom, pretendersi adepti di una finzione veritativa come quella del “canone”. Si può insomma essere, da professionisti della cultura, più dotti di Pico della Mirandola e più perspicaci di Benedetto Croce. Ma per essere Leopardi – dopo aver divorato mille biblioteche nel sollievo della propria claustrofobia – bisogna anche saperle bruciare dentro il fuoco vivo dell’esistenza.
O avete voi memoria di un genio che non sia stato innanzitutto un uomo?
Leopardi fu uomo nel patimento e del patimento. Ma fu poeta – potremmo quasi dire, fu il poeta – perché la sua grandiosa metafisica dell’assurdo non gli venne solo dai Greci o dai Latini, bensì da quelle stesse atroci quisquilie che sono le vicende della vita, senza le quali si può fare accademia ma non arte. E vorremmo aggiungere: senza soffrire le quali si può fare gli scrittori borghesi, gli scrittori integrati, gli scrittori felici, gli scrittori risolti, gli scrittori appagati, gli scrittori à la page, diciamo pure gli scrittori in voga... ma non i geni.
Carlo Diano forse ci ha lanciato un ammonimento con cento anni di anticipo sull’avvento istituzionale della Decadenza: cari seguaci di Leopardi, portate la vostra gobba per il mondo, altrimenti i vostri dotti versi rimarranno fatalmente poca cosa.
A macchia di Leopardi
Laser 27.03.2019, 09:00
Contenuto audio