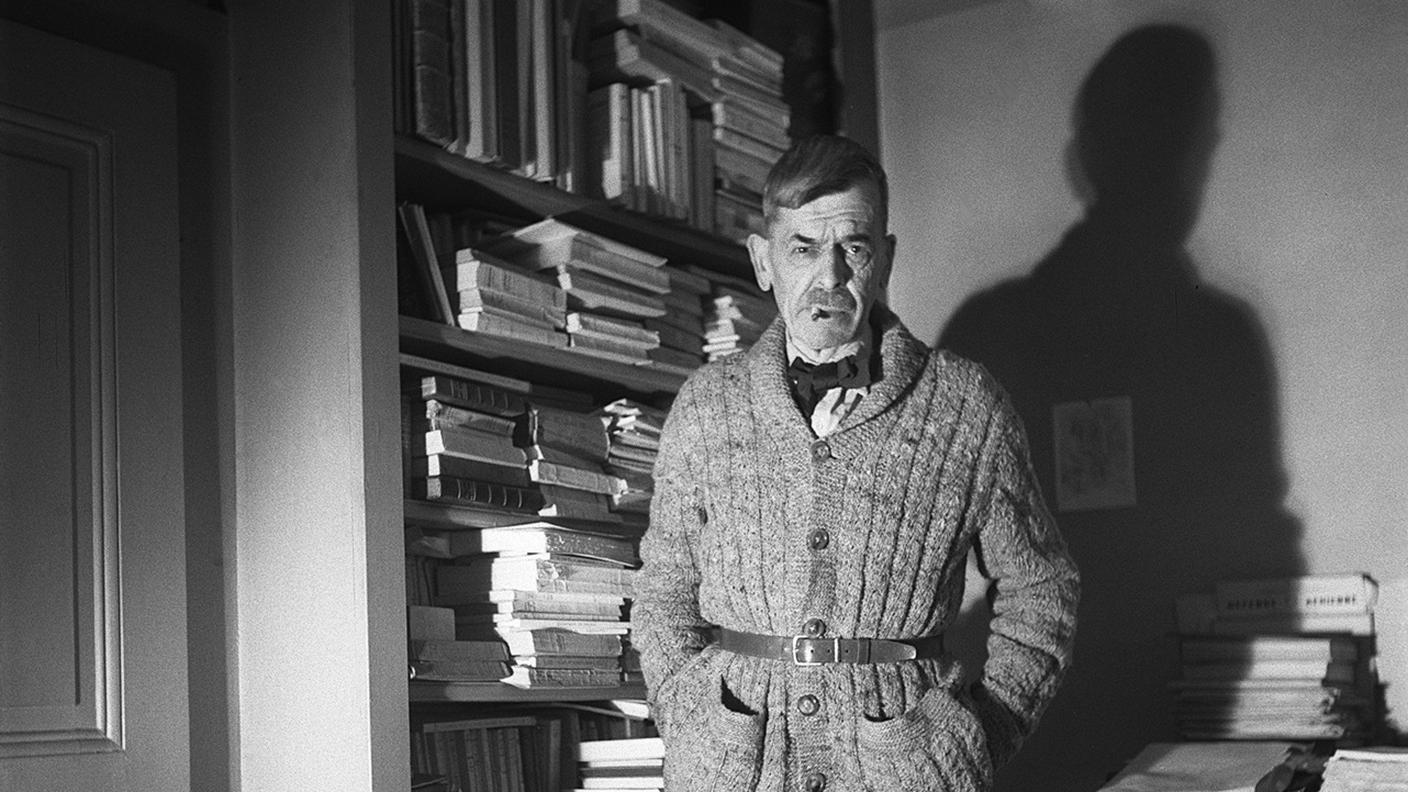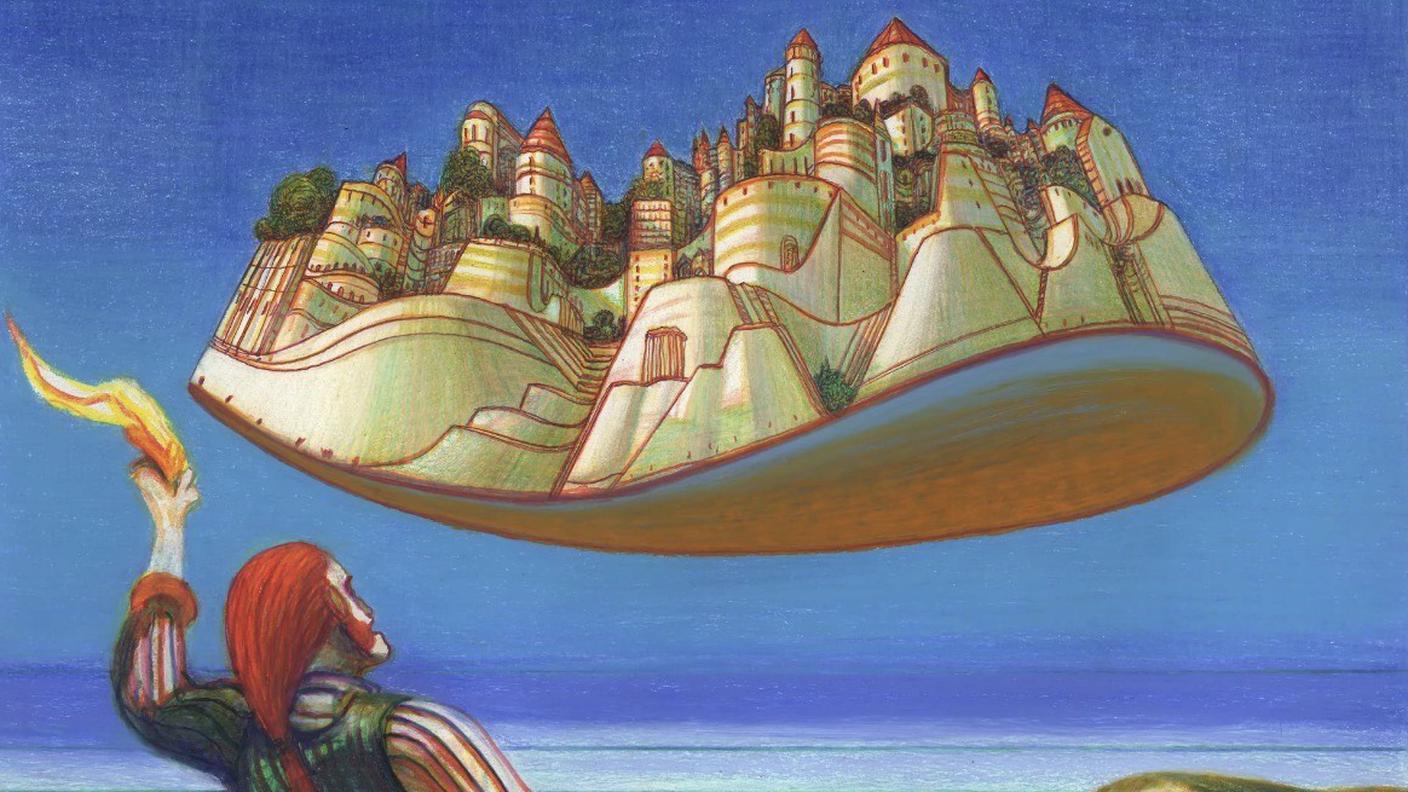Il romanzo Sedici mesi di Fabio Andina, proposto di recente dall’editore Rubbettino, sollecita alcune riflessioni di tipo letterario, ma anche alcune considerazioni estranee agli immediati contenuti del libro.
Scritto con garbo e sobrietà, ricalcando una certa tradizione popolare tipica dei memoriali di provincia, Sedici mesi è la ricostruzione delle vicende che attraversarono la vita di molti cittadini del Nord Italia nel corso della Seconda guerra mondiale, quando la persecuzione nei confronti degli ebrei diede corpo a nobili (ma anche meno nobili) imprese di salvataggio verso il Canton Ticino.
In particolare quando alcuni volenterosi, organizzati spesso in piccole consorterie rivali, aiutarono – per generosità o per vantaggio pecuniario – alcune famiglie di ebrei a trovare rifugio in Svizzera. Passeurs della pianura, verrebbe da dire, riprendendo il termine evocato da Biamonti nel suo Vento largo (a proposito dei contrabbandieri delle montagne), grandi e piccoli eroi, solerti traghettatori di uomini e vite, che contribuirono di fatto a mettere in salvo decine e centinaia di ebrei rivelando così che a ogni latitudine, anche nelle condizioni più esposte al pericolo, alberga sempre lo «spirito di Bonhoeffer».
Per la costruzione della storia, Andina si è avvalso di un gran numero di documenti, materiali, carte d’archivio e testi d’epoca in grado di fornire al racconto, insieme agli inevitabili innesti di fantasia, un precipuo significato testimoniale e storico. Ma oltre ad attingere alla Storia attraverso gli storici, egli ha affondato anche nelle memorie della propria famiglia, scoprendo che suo nonno era uno di questi eroi clandestini che sostennero e promossero la fuga degli ebrei.
Prende allora corpo una ricerca puntigliosa nelle stanze della memoria e viene dipanandosi, quasi naturaliter, il romanzo di tale scandaglio. Con l’effetto di offrirci un quadro dell’epoca non solo coerente rispetto ai fatti ma emotivamente partecipato: Andina essendo, come erede «ideale» di quel lontano parente, tributario e responsabile di restituirne fedelmente la memoria.
A questi aspetti del romanzo – uno dei cui pregi è di essere privo di inutili compiacimenti stilistici – si accompagna un vivo senso della suspence, un serrato alternarsi di prospettive e ambientazioni e una caratterizzazione netta dei personaggi. Elementi che hanno consentito al libro di raccogliere significativi riconoscimenti e un vivo interesse di pubblico.
Ma ve ne sono anche altri, che possono essere ricordati come parte di un discorso di sociologia della letteratura. E su questi è forse opportuno spendere qualche riflessione.
In particolare il tema: la persecuzione degli ebrei., ovvero la Shoah, l’Olocausto. Da Primo Levi al premio Nobel ungherese Imre Kertész, da Sebald a centinaia e centinaia di altri, gli scrittori che hanno trattato il cosiddetto «tema ebraico» non si contano. E se le ragioni sono molteplici, una di queste può essere sicuramente stigmatizzata nell’ovvietà: perché si tratta della più grande tragedia della Modernità.
A parte questo è anche vero che il tema dell’Olocausto – con buona pace di Adorno, che sosteneva che dopo Auschwitz non si sarebbero più potuti scrivere romanzi – presenta paradossalmente una serie di «vantaggi» non del tutto irrilevanti: riacutizza il nostro senso di colpa, offre uno scenario tragico già perfettamente predisposto e delineato dalla Storia (quasi un canovaccio su cui inserire nuove varianti), ripropone l’antica dicotomia tra buoni e cattivi, tra bene e male e tra persecutori e perseguitati, offre il destro al moralismo e colloca a priori l’autore nel quadro del politically correct. È inoltre un tema ampiamente noto al pubblico che, per così dire, vi si ritrova fin dalle prime righe.
Laddove questioni come l’eccidio armeno, le guerre intestine africane, la tragedia palestinese, il dramma curdo, le guerra nei Balcani e via elencando paiono stagliarsi in mondi invisibili, l’Olocausto è viceversa vissuto come famigliare. O, seguendo l’esempio di Andina, quasi come espressione di un lessico famigliare.
Il che ci riporta a un tema di primaria importanza. Se è vero, ed è indiscutibile, che bisogna sempre tenere desta la memoria sulla Shoah, è anche vero che è l’approccio culturale e letterario al consesso universale delle tragedie, ovvero delle altre tragedie, è del tutto asimettrico. Tanto che – secondo il medesimo limite che si osserva in ambito politico – laddove si spengono i riflettori, tali mondi cessano semplicemente di esistere.
Sedici mesi
Alphaville 25.09.2024, 11:30
Contenuto audio
Insieme ad Andina, ben venga quindi – ben ritorni, ben continui a ripresentarsi – la luce sulla tragedia degli ebrei nella Seconda guerra mondiale: si tratta di memorie dell’umano e del disumano, della crudeltà e dell’eroismo, che nessuna indifferenza dovrà per nessuna ragione – tanto meno per ragioni di razzismo o antisemitismo – porre al di là della nostra indignazione.
Ma valga anche l’esortazione – per quanto serve – a fare luce dove sono meno naturalmente assicurati il sentimento e il dolore di chi vi partecipa. Il mondo avendo bisogno di letteratura anche in questi ambiti: dove quattro quinti del pianeta languono da decenni, a volte da secoli, nel silenzio e nell’indifferenza della parola.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Sedici-mesi-dopo-il-5-marzo-1944--2609727.html
Premi svizzeri di letteratura
Alphaville 13.02.2025, 11:05
Contenuto audio