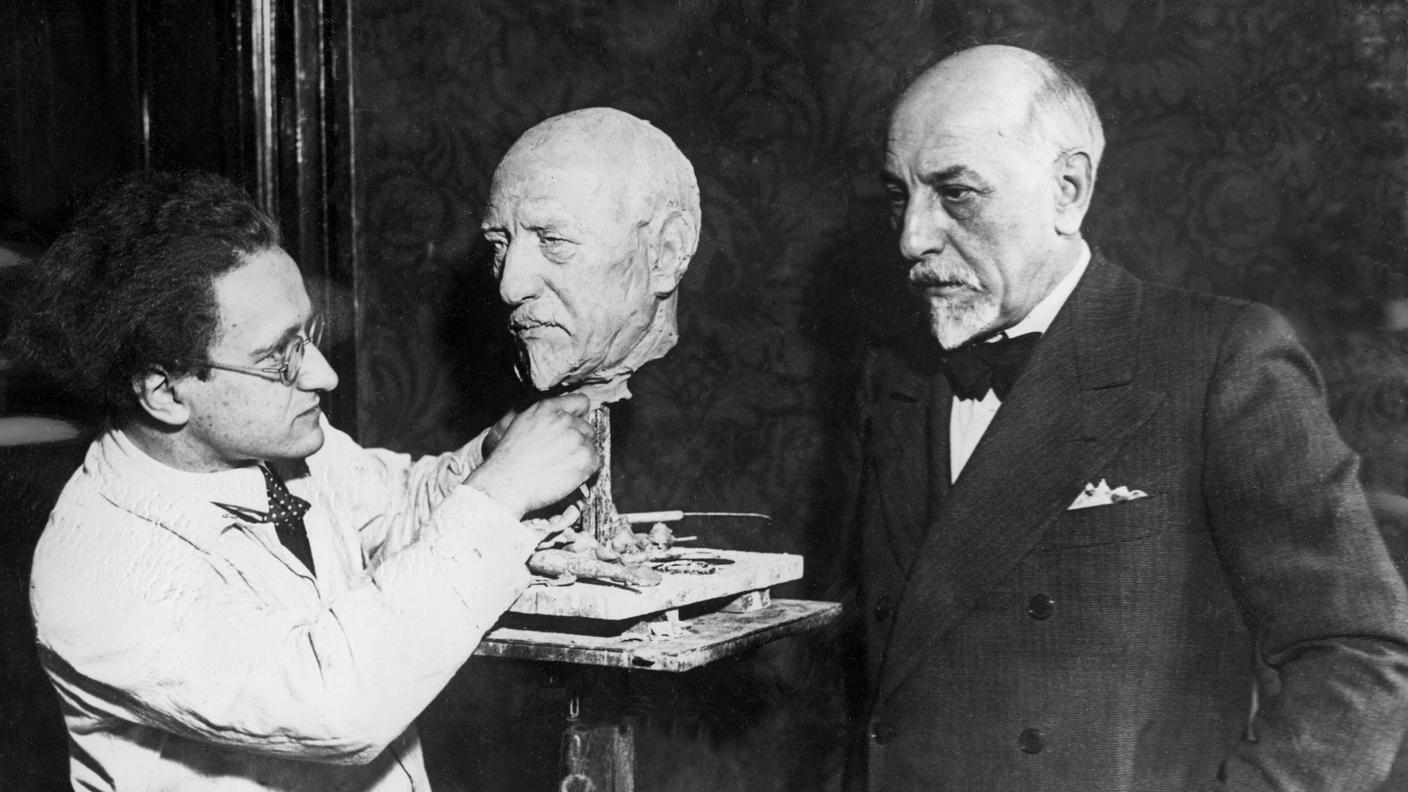Diario di un dolore di C.S. Lewis, pubblicato da Adelphi, è in realtà più propriamente il diario di un decesso. Il titolo originario recita infatti in inglese A Grief Observed, che dà una misura molto più partecipata ed esterna del dolore, una misura luttuosa.
In ogni caso raccontare il dolore, raccontare la morte, sono entrambe imprese di una difficoltà estrema. Lewis riesce a raggiungere la distanza e la freddezza dolente sufficienti per essere contemporaneamente empatico rispetto al dolore per la scomparsa della propria compagna e razionale al punto da poterla recuperare e vivificare nell’intelligenza.
D’altronde che spiegazione dare al dolore se non che è comprensibile, cioè pienamente riconoscibile, solo nel momento in cui non è raccontabile? E che è raccontabile solo nel momento in cui si è cessato interamente (o quasi) di patirlo? Scrive Lewis, rivelando come alla morte e al cinismo non vi sia scampo, come non abbia nessun senso cercare espedienti, rassicurazioni o speranze fittizie per esorcizzare l’inesorabilità di un tempo ormai passato, tracollato, definitivamente risolto nella sua morte, nella morte, nella morte di una vita e di tutto ciò che essa portava con sé: «’Il suo viaggio continua’ mi dite. Ma il mio cuore e il mio corpo gridano: ritorna, ritorna. Sii un cerchio, e tocca il mio cerchio sul piano della Natura. Ma so che è impossibile. So che quello che voglio è proprio quello che non potrò mai ottenere. La vita di un tempo, gli scherzi, bere insieme, discutere, fare l’amore, le piccole e struggenti banalità. Da qualsiasi punto di vista, dire: ‘H. è morta’ è lo stesso che dire: ‘Tutte queste cose sono finite’. Sono parte del passato. E il passato è il passato e questo è ciò che si intende per tempo, e il tempo è uno dei tanti nomi della morte, e quanto al Cielo, è uno stato dove ‘le cose di prima sono passate’».
Di fronte a uno sguardo totalmente disincantato sulla morte, l’immagine di un Dio buono cessa quindi di essere praticabile o assumibile. Anzi, persino di Cristo si potrebbe arrivare a dire, come sostiene Lewis, che è stato gabbato sulla croce: «Abbiamo Cristo. Ma se si fosse sbagliato? Tra le Sue ultime parole ce ne sono alcune il cui significato potrebbe essere chiarissimo: aveva scoperto che l’Essere da Lui chiamato Padre era orribilmente e infinitamente diverso da quel che Lui aveva creduto. La trappola, preparata da tempo con tanta cura e tanta sottile astuzia, scattò infine, sulla croce. L’infame beffa era riuscita».
Ma Lewis si spinge persino oltre. Di fronte al dolore arriva addirittura a pensare, a immaginare o credere che Dio debba essere necessariamente cattivo: «La parola buono applicata a Lui perde ogni senso, diventa un mero abracadabra. Non abbiamo alcun motivo per obbedirgli. Nemmeno la paura. È vero che abbiamo le Sue minacce e le Sue promesse. Ma perché dovremmo crederci? Se dal punto di vista della crudeltà è ‘bene’, forse anche le menzogne sono ‘bene’. E se anche dicesse la verità, che differenza farebbe? Se le Sue idee di bene sono tanto diverse dalle nostre, quello che Lui chiama ‘Cielo’ potrebbe a rigore essere quello che noi chiameremmo Inferno e viceversa».
Quindi non c’è scampo, non c’è via d’uscita, né nella religione né nella speranza. E nemmeno nell’anatema, nel grido, nella bestemmia, nel rifiuto della consolazione. Poiché la verità, conclude Lewis, è che «nella sofferenza non si può fare altro che soffrire».
Indicata la causa dell’impossibilità di una consolazione rispetto al dolore e al lutto, Lewis passa quindi a indagare le possibili conseguenze della morte nel dolore che produce presso i sopravvissuti. Ma anche qui la sua analisi è impietosa. Si chiede: «Arriverà il momento in cui non mi chiederò più che cosa ha trasformato il mondo in un vicolo grigio, perché troverò normale il suo squallore. Il dolore si acquieta in una noia soffusa di una vaga nausea».
Ecco, ci rendiamo conto che l’accecamento e la sofferenza prodotti dal dolore non terminano con la fine dell’accecamento e della sofferenza, ma hanno strascichi che si riproducono al di là del presente come una sorta di perpetuazione infinita dell’insensatezza procurata dal lutto. Tutta la vita perde di senso, tutta la vita perde di contorni, di significati, di piacevolezza. Tutto diventa noia, una vaga nausea o una noia nauseante.
In questo tracollo della speranza, dell’immaginazione, tutto appare vago. È possibile che si cerchino degli stratagemmi, che si invochino delle uscite dal dolore e dal male. Ma è anche imprescindibile rassegnarsi, a un certo punto, al fatto che ciò che è perduto non è altro che ciò che è perduto per sempre. E che non esistono risarcimenti di sorta in grado di rendere tale perdita diversa da ciò che drammaticamente è.
Questo pensiero di inesorabilità va al di là del sentimento personale di perdita e di tracollo: riguarda la stessa sofferenza patita dal defunto. Giacché, scrive Lewis: «Che importa l’evoluzione di questo mio dolore, o quel che io ne faccio? Che importa come la ricordo o se la ricordo? Nessuna di queste alternative allevierà o accrescerà i suoi tormenti passati».
Come a dire: per quanti stratagemmi noi si possa adottare per alleviare il lutto, la morte e le sofferenze che l’hanno preceduta sulla pelle della defunta, queste non saranno mai scongiurabili.