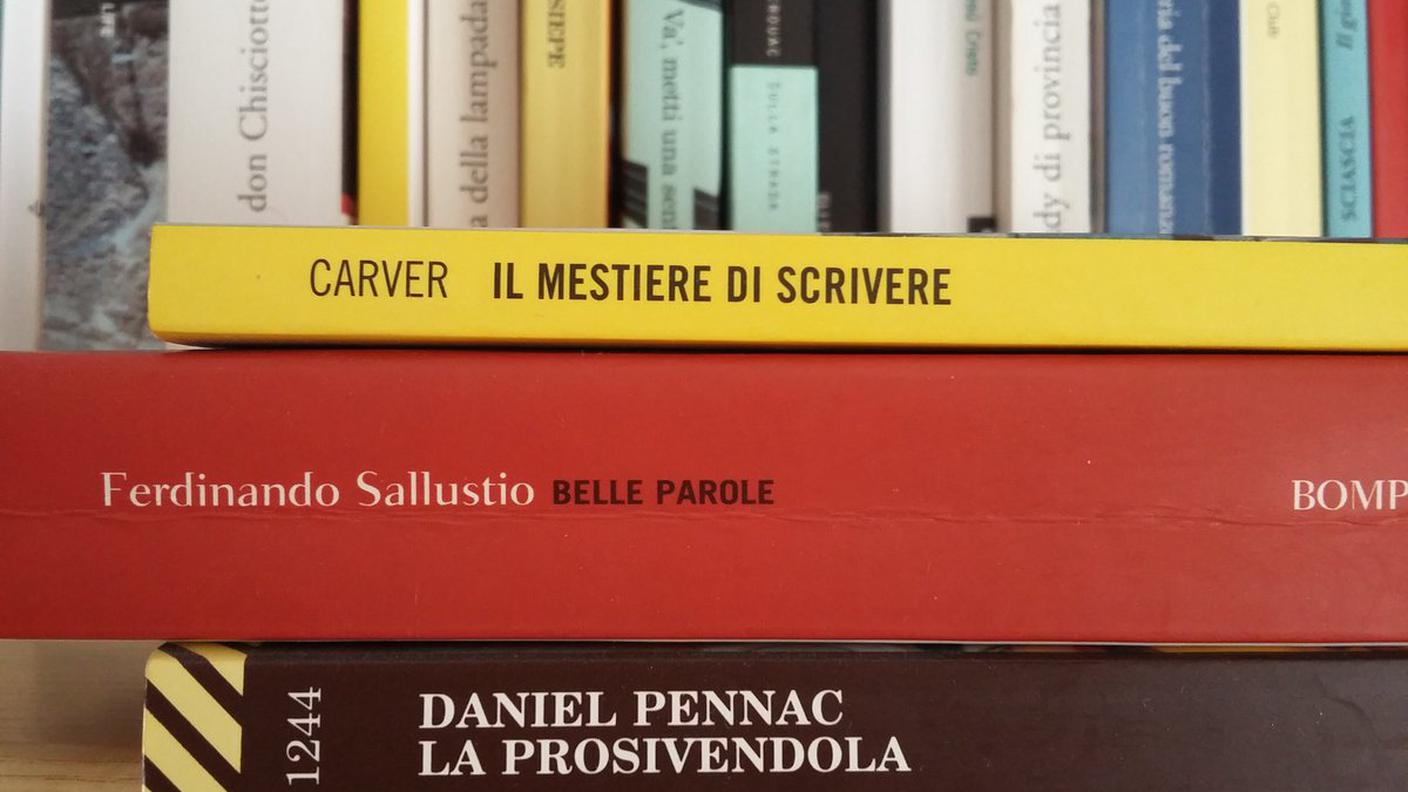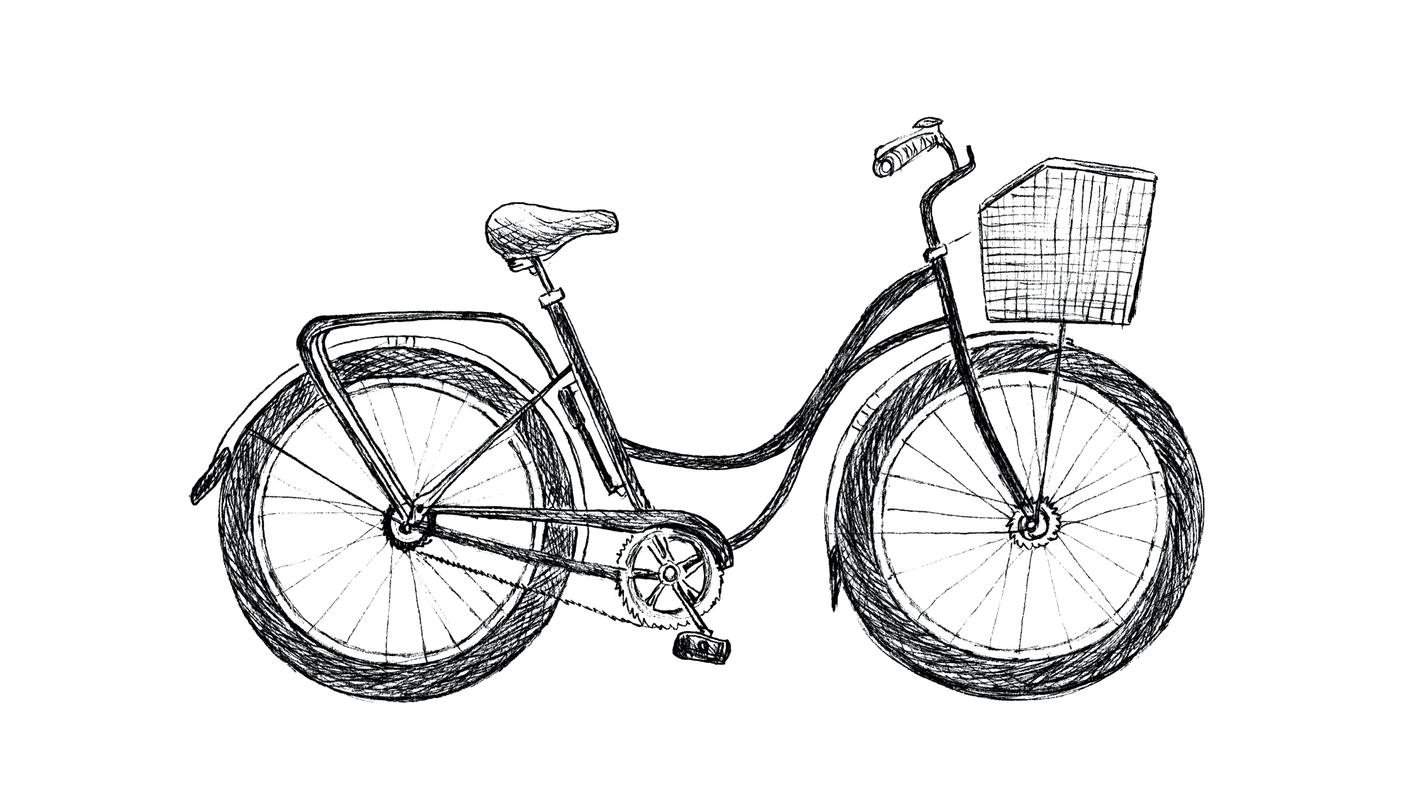Almeno dai tempi di Gutenberg, nel lavoro editoriale c’è un sottile e perverso inganno: farci credere che una pagina sia davvero una pagina.
Eppure di questo inganno ci siamo nutriti tutti fin da quando i libri hanno cominciato ad assumere la forma che ancora conosciamo, da quando cioè hanno potuto mostrare il capriccio – poiché infine si tratta di un capriccio – di presentarsi agghindati di copertina, risvolti, edizioni in questa o quella fattura di carta, in questo o quel genere di formato e soprattutto in questa o quella impaginazione.
Già, ecco la parola magica che ha sotteso il secolare inganno dai tempi dell’invenzione della stampa: impaginazione. Noi diciamo, con disinvolta noncuranza: Ho appena letto un libro di 400 pagine. E non ci rendiamo conto che quelle 400 pagine non significano assolutamente nulla. Oppure ci aggiriamo lungo gli scaffali di una libreria e affermiamo: Ci sono molti libri che non leggerei perché sono troppo lunghi. Oppure ancora: Questo lo compro perché non supera le 120 pagine.
Ah, cecità dell’abitudine, tranello dei numeri, fraintendimento della matematica! Come se un libro sottile fosse necessariamente breve e un libro voluminoso fosse necessariamente lungo!
In verità viviamo in una sorta di involontario spaesamento che ci perseguita e travia dai tempi di Gutenberg. E se pure qualcuno ha avuto l’accortezza di avvertirci che una pagina – la cosiddetta pagina canonica – dovrebbe coincidere a rigore con una cartella – la famosa cartella di 30 righe per 60 battute – di una simile convenzione gli editori si sono sempre ben guardati dall’essere succubi. E così noi – sotto i tranelli dell’intero sistema di promozione libraria – continuiamo nell’illusione, o nell’ingannevole certezza, di aver letto libri lunghi o brevi a seconda di quale fatidico numerino comparisse al fondo dell’ultima pagina.
In verità non abbiamo mai saputo – né probabilmente mai sapremo – se l’Ulisse di Joyce è più lungo o meno lungo dell’Uomo senza qualità di Musil. Ma visto che di norma l’Ulisse è presentato in un unico volume, mentre L’uomo senza qualità è quasi sempre pubblicato in due volumi, perseveriamo nella convinzione che con Musil abbiamo letto due libri e con Joyce uno soltanto.
Ma questo è solo un esempio. Il quale, malgrado la frivolezza dell’argomento, ci dice tuttavia molto sull’intero mondo dell’editoria.
Prendiamo due editori con vocazioni culturali e letterarie molto diverse: Feltrinelli e Mondadori. I cosiddetti “Tascabili” Feltrinelli presentano coste di dimensioni quasi tutte identiche, ma ci basta aprire due volumi a caso e ci rendiamo conto che... guarda un po’... le compressissime 350 pagine della Casa degli spiriti di Isabel Allende raggiungono un peso specifico, in termini farmaceutici, delle dilatatissime 100 pagine di uno dei centomila libercoli di Erri De Luca. E se allo stesso modo cerchiamo tra i ponderosi volumi di Mondadori, ci accorgiamo che il dilatatissimo Gabriel Garcia Marquez di Cronaca di una morte annunciata non è infine più leggere, sempre in termini farmaceutici, del compressissimo romanzo Ci sono bambini a zig zag di David Grossman.
Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che in definitiva sono gli editori, non gli autori, a presentare libri lunghi o brevi. Prendi Il cacciatore di aquiloni di Khaled Husseini e hai l’impressione di trovarti di fronte a un volume corposissimo: è in realtà un libretto molto modesto, in tutti i sensi. E prendi il romanzo a caratteri da bugiardino I figli della mezzanotte – in realtà enorme, in tutti i sensi – di Salman Rushdie e hai l’impressione che equivalga a uno dei tanti iperdilatati romanzi brevi di Antonio Tabucchi.
Insomma, in libreria si gonfiano e sgonfiano i libri come si fa al mercato delle verdure con le melanzane e i peperoni. E noi a fiondarci, a seconda dei gusti estetici o culinari, su quelli più vistosi senza accorgerci che magari sono privi di sapore e sostanza.
E in questa “logica della fisarmonica” abbiamo parlato solo di impaginazione. Ma cosa dire quando si parla di caratteri, di corpi degli stessi, di peso specifico della carta, di formato, di margini e spaziature? Sì, dai tempi di Gutenberg noi ci aggiriamo tra i libri come in un ombroso enigma navigando a vista lungo coste che non rivelano praticamente quasi nulla.