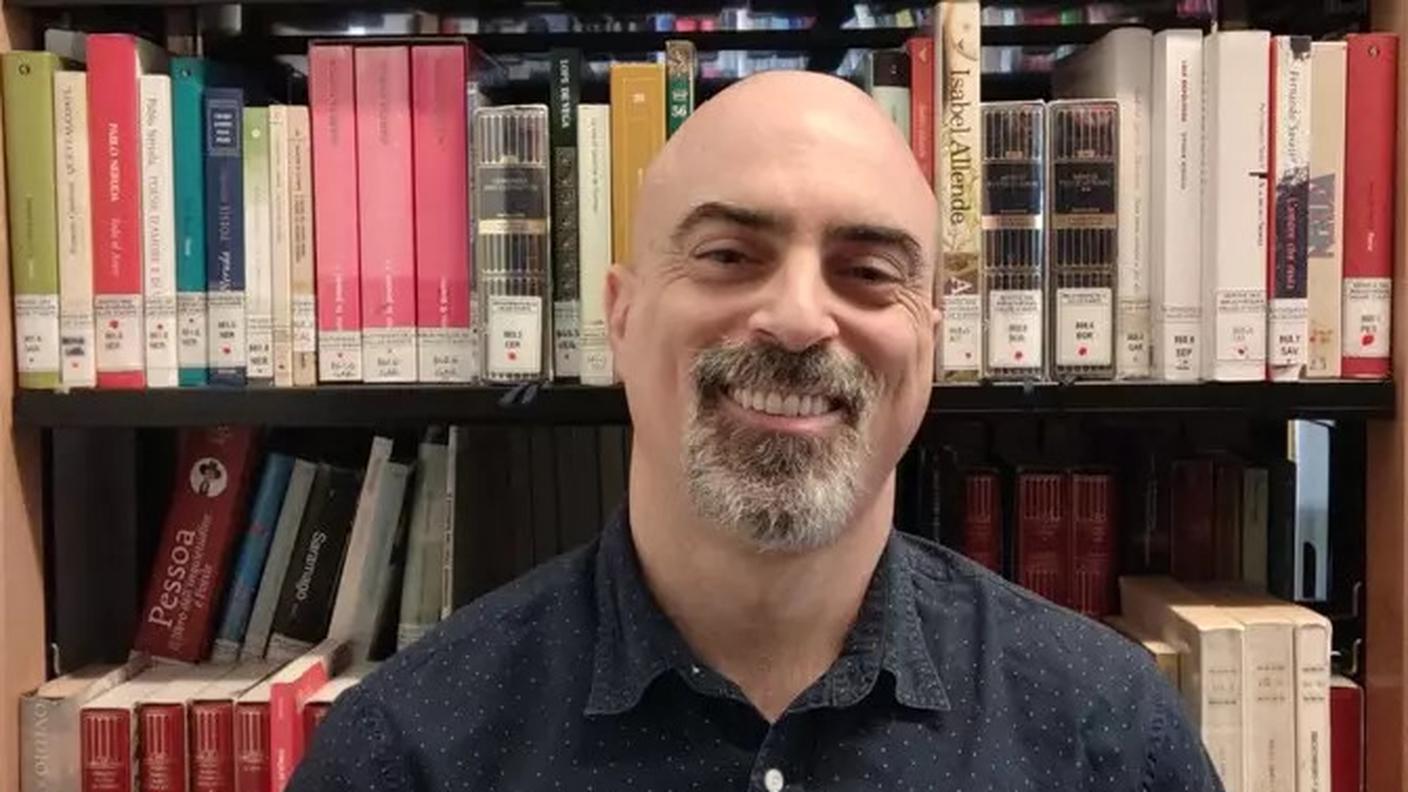A 75 anni dal tragico suicidio del poeta, Alphaville dedica la puntata a Cesare Pavese, con Mattia Pelli e Gioele Cristofari, autore di Cesare Pavese politico
Sono stati pochissimi, i temi principali dell’opera di Pavese. Scriveva, nei Dialoghi con Leucò: «Io non ho niente in comune con gli esploratori, con gli avventurieri. Anzi, preferisco fissarmi su un singolo oggetto, e a un certo punto rendermi conto di non averlo mai visto davvero come fino a quel momento». Altrove Pavese dice: «La mia opera è un monolito. I miei libri sono schegge di un monolito».
Pochi temi, insistiti. Il primo è il confronto-contrasto tra città e campagna, che in realtà non si oppongono davvero, anzi si viaggia dall’una all’altra. Il viaggio è un altro tema del romanzo pavesiano, e chi viaggia è tendenzialmente un adolescente. È un viaggio iniziatico, durante il quale l’adolescente scopre che tra città e campagna non ci sono così tante differenze, che forse il lavoro contadino e il lavoro operaio sono la stessa condanna, nell’una e nell’altra. Con questo viaggio, l’adolescenza finisce.
Dunque: adolescenza, viaggio, città e campagna, lavoro e politica. Non sono temi: Pavese avrebbe detto che sono miti della sua scrittura.
Ricordando Pavese
Alphaville 27.08.2025, 11:30
Contenuto audio
Cesare Pavese: intellettuale isolato o organico?
Concentrato su questi temi, Cesare Pavese voleva apparire isolato. A un certo punto, detta alla casa editrice la fascetta per la sua raccolta di poesie, e dice: la voce più isolata della poesia contemporanea. Io però non lo direi. Anzi, a guardare bene, la sua opera e la sua biografia dicono tutt’altro. Forse il Pavese giovane, quello degli anni Trenta, era un isolato, che traduceva i romanzieri americani nella solitudine del suo studio da disoccupato. Ma quando inizia a pubblicare romanzi, cioè dal 1941 con Paesi tuoi… Paesi tuoi fa scuola, per il neorealismo. Uso questa etichetta anche se è contestata, e Pavese stesso forse l’avrebbe rifiutata. In ogni caso è un romanzo che fa scuola, a cui guarda un’intera generazione.
Poi, dalla fine degli anni Trenta inizia a lavorare all’Einaudi, l’industria culturale più importante di tutta Italia, nei decenni centrali del Novecento. Giulio Einaudi era forse l’uomo più potente di tutto il nostro campo culturale, all’epoca, e Pavese prendeva per lui molte decisioni editoriali.
Basti un solo aneddoto, anche piuttosto noto: a un certo punto sulla scrivania di Pavese arriva un dattiloscritto, di un giovane chimico torinese che racconta la sua esperienza ad Auschwitz. Pavese dice che no, non è il momento di pubblicare memorialistica dell’Olocausto. Quel dattiloscritto era Se questo è un uomo, il giovane chimico era Primo Levi, e questo era il potere di Pavese: non far pubblicare un romanzo del genere. Dunque, tutt’altro che un isolato.
Perché Pavese rifiutò quel libro? Credo avesse un po’ in odio quella che vedeva come memorialistica della Seconda guerra mondiale: non gli interessava la testimonianza individuale del soldato, del partigiano, nemmeno di chi era finito in un campo di concentramento. Gli interessava di più la creazione letteraria su quei temi, idea che poi metterà in pratica con La casa in collina.

Cesare Pavese e la casa in collina
RSI New Articles 20.08.2020, 09:00
Pavese e la politica
Non è sempre facile collocare Cesare Pavese all’interno del dibattito politico del Novecento, e del secondo dopoguerra in particolare: si schierò contro il fascismo, ma rimase comunque polemico nei confronti degli ambienti antifascisti. Si iscrisse al Partito comunista, ma ebbe tendenze anarchiche. Non che fosse un bakuniano: semplicemente, pare di intravedere in tutta la sua opera un rifiuto dell’organizzazione politica in quanto tale.
Pavese visse momenti di entusiasmo, certo: a liberazione avvenuta, come tutta l’Italia, si aspettava una sorta di palingenesi dalla fine della guerra. Ma di fatto rifiutava le lunghe parole delle assemblee del movimento operaio, come scrive in una sua poesia, o l’organizzazione dell’antifascismo liberale torinese, di cui poi faceva parte.
È un rifiuto dell’integrazione che sembra nascondere una sfiducia nella politica attiva, nell’impegno politico come mezzo per cambiare il mondo. D’altronde il Pavese giovane si impegna culturalmente e politicamente all’inizio degli anni Trenta, e quasi senza accorgersene finisce prima in carcere e poi al confino politico in Calabria: ecco la prima, vera esperienza politica fondamentale di Pavese.
Un rapporto non facile con la politica che si riflette in quello con la resistenza, come testimoniato anche dal suo romanzo più problematico e forse anche più bello, La casa in collina. Il protagonista di quelle pagine è un borghese che sa di non poter fare la resistenza: di non essere – si potrebbe dire con termini marxisti – un soggetto rivoluzionario. I veri soggetti rivoluzionari sono gli operai comunisti, che la casa in collina non ce l’hanno, e non ci si possono rifugiare quando Torino viene bombardata. Lì Pavese ci dice che l’attività politica dipende anche dal nostro stesso posizionamento sociale.
Cesare Pavese: un ricordo biografico
RSI Cultura 19.10.2023, 07:00
Pavese e l’America
L’interesse politico e l’ideale antifascista lo portano anche verso la letteratura americana (aveva, del resto, scritto la sua tesi di laurea su Walt Whitman), in un momento in cui l’americanistica in Italia non esiste, perché le prime cattedre di americanistica arriveranno nell’Italia degli anni Sessanta. Pavese invece traduce scrittori americani sin dagli anni Trenta. Poi smette, guarda caso, quando cade il regime fascista.
Pavese scrive: «quella americana è una società che ha il male della crescita, che sta crescendo una società giovane». Così riprende lo stereotipo degli Stati Uniti come società giovane e lussureggiante, in un certo senso. Questa era la visione anche di Elio Vittorini e di molti altri, all’epoca. Oggi, a quale società guarda idealmente un giovane laureato o studente di facoltà letteraria? Di certo, non a quella americana.