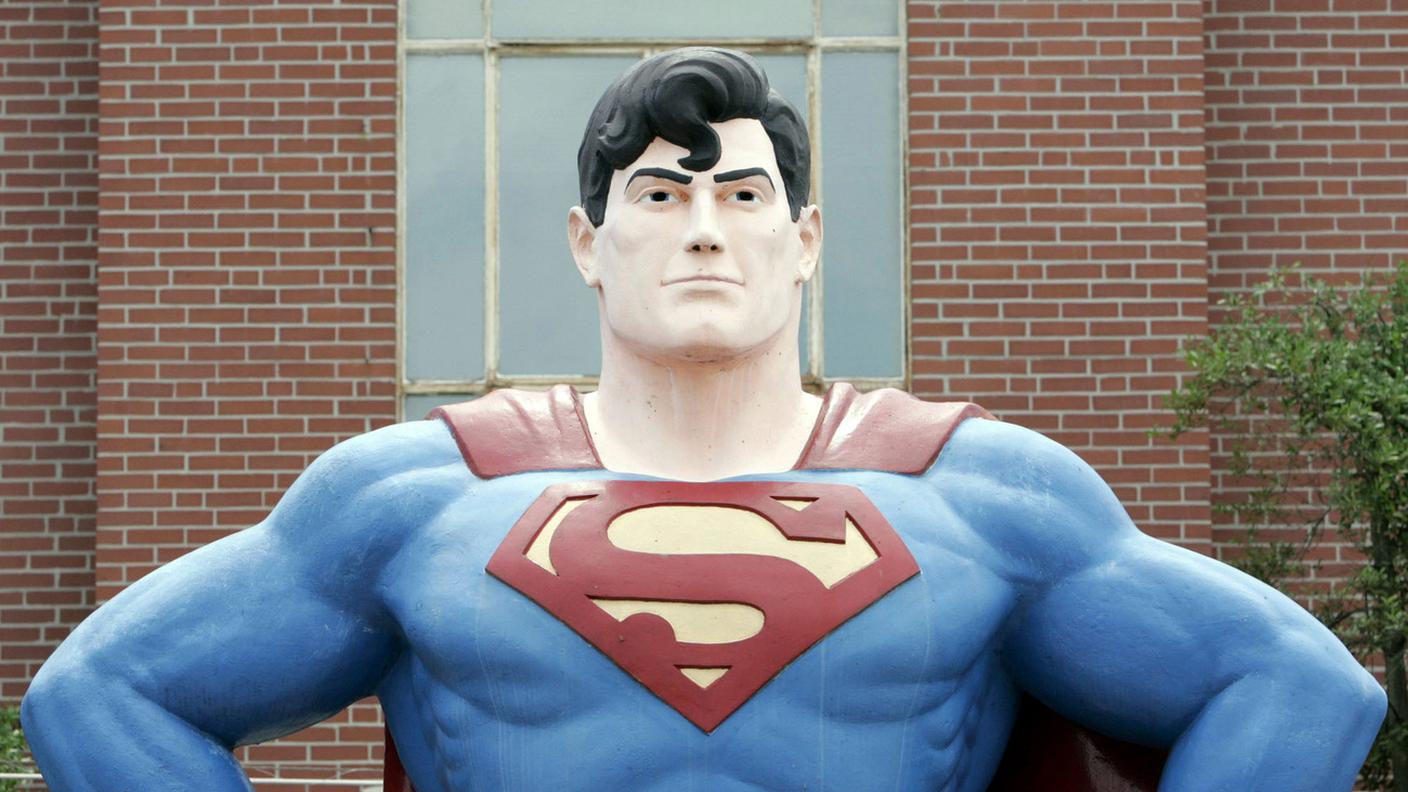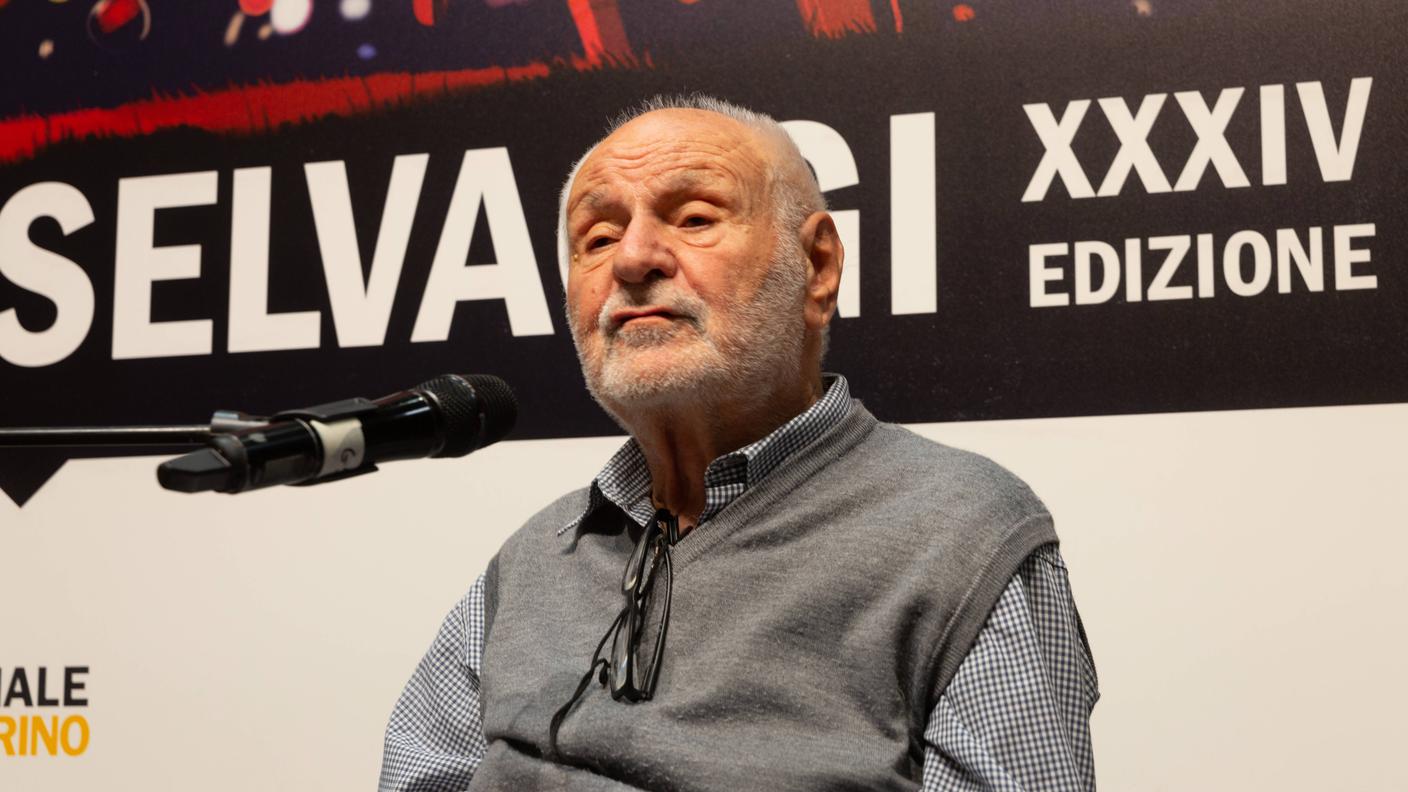Saranno anche una delle tante e vuote consuetudini dell’industria culturale, ma rimane il fatto che molto spesso c’è bisogno delle cosiddette “ricorrenze tonde” per riscoprire e rendere giustizia al valore e alla grandezza di non pochi scrittori, che in caso contrario sarebbero inevitabilmente destinati a cadere nel dimenticatoio oppure a costituire paragrafi marginali delle storie letterarie. Per quanto riguarda l’ambito germanofono della Svizzera, la sorte toccata a Meinrad Inglin ne è una chiara dimostrazione, forse la più evidente negli ultimi decenni.
Un semplice “luogo” diventa “paesaggio” quando è scritto in una lingua che si conosce, perché in caso contrario rimane un “non luogo” anonimo e incomprensibile (il mondo attuale, per inciso, ne è pieno). Dire “Inglin” significa quindi dire “Svitto”, perché nella storia della letteratura svizzera di lingua tedesca è difficile trovare una così completa identificazione tra un autore e il suo luogo d’origine (il pensiero corre ovviamente alla Zurigo di Gottfried Keller oppure all’Emmental di Jeremias Gotthelf, ma l’identificazione è meno marcata e per così dire meno totalizzante). Nato nel 1893 e morto nel 1971, abbastanza noto in vita ma piuttosto negletto nel periodo immediatamente successivo la morte (con la sola eccezione di un pionieristico studio dedicatogli dall’allora giovane germanista Beatrice von Matt e una scelta dei racconti, curata a metà degli anni Ottanta dal suo quasi conterraneo Thomas Hürlimann), Inglin è stato riscoperto e rivalutato soltanto in occasione del centenario della nascita, quando le edizioni Ammann di Zurigo diedero alle stampe l’edizione critica delle sue opere in dieci volumi. Si scoprì allora in Inglin un narratore di razza, dallo spiccato talento epico, autore tra l’altro di quello che con ogni probabilità, in termini puramente narrativi, rimane il più grande romanzo svizzero in lingua tedesca del Novecento: il monumentale “Specchio svizzero”, uscito nel 1938, una variazione in chiave elvetica e svittese dei “Buddenbrook” di Thomas Mann ma anche una sorta di continuazione, a partire dal titolo, del più grande romanzo svizzero in lingua tedesca dell’Ottocento, “Lo specchio dei contadini” di Gotthelf.
La “piccola” Svitto, intesa non solo come città ma anche come cantone e più ancora come precisa entità territoriale, per Meinrad Inglin coincide concretamente col luogo d’origine, con una circoscritta e talora claustrofobica o comunque limitante realtà provinciale, ma nella reinvenzione letteraria diventa Heimat e quindi coordinata esistenziale, luogo fondante, immagine del mondo. Lo stesso Inglin lo ha espresso in maniera molto penetrante in un passo di uno scritto del 1928 dal titolo “Elogio della Heimat”, che è quanto di più bello sia mai stato scritto su Svitto e la Svizzera centrale e può essere considerato il suo manifesto poetico: «Le repentine pendenze di boschi e rocce interrotte da graziosissime rive, le valli che dapprima si aprono dolcemente e poi si fanno fortemente impervie in mezzo a pareti slanciate, con le cime che le chiudono, le ampie conche, i massicci montuosi, imponenti e frastagliati, le acque quiete e schiumanti, i pascoli alpini e i boschi, le rocce, i campi, la neve, e sopra tutto questo il cielo che si inarca vicinissimo, azzurro o nero di tempesta oppure punteggiato di stelle. L’armonia di questi dettagli produce quella magia che solo approssimativamente può trovare espressione in termini quali “atmosfera”, “spirito” oppure “caratteristica del paesaggio”. E’ qualcosa di simile, in un altro contesto, a quel fenomeno che l’intelletto non riesce a comprendere ed è riconducibile a una catena di suoni, al ritmo prodotto da una sequenza di accordi».
Inglin si inserisce a pieno titolo, e non solo per qualità di scrittura, nel solco di una lunga tradizione che, dalla Seldwyla di Keller in poi, fino a luoghi immaginari e insieme estremamente concreti come Andorra nell’omonimo testo teatrale di Frisch, Güllen ne “La visita della vecchia signora” di Dürrenmatt, Barbarswila nei romanzi di Gerold Späth oppure Schilten nelle opere di Hermann Burger, costituisce uno dei tratti di fondo della letteratura svizzera di lingua tedesca. La provincia, o comunque il luogo geograficamente lontano dalle grandi correnti della storia universale, diventa insomma un ideale punto di osservazione, di modo che la “Our Town” alla Thornton Wilder o perfino il villaggio, nella reinvenzione letteraria, riescono ad esprimere i tratti salienti della condizione umana, l’apertura verso l’esterno oppure l’esaltazione regressiva del contesto dato.
Come molti letterati nati sul finire dell’Ottocento, nel suo caso specifico con l’aggiunta di una sensibilità ecologica davvero “avant la lettre”, Inglin ha individuato nell’imporsi violento dei nuovi modelli di vita i tratti di una decadenza (la “legge della decadenza”, come l’ha opportunamente definita Thomas Hürlimann) che ai suoi occhi assume le sembianze di un destino. E’ una consapevolezza, pur se variamente declinata, che si trova un po’ ovunque nella sua opera, non solo nei grandi romanzi come il già ricordato “Specchio Svizzero”, “Il mondo di Ingoldau” (1922), “Grand Hotel Excelsior” (1928), “Il confine grigio” (1930) e nell’autobiografia fittizia “Werner Amberg” (1949), ma anche in racconti come “La biforcazione” (1943), “Il Signore di Birkenau” (1958) e non da ultimo nella tarda e possente novella “Il viandante sulla strada di casa” (1968), nella quale Inglin ha preso idealmente congedo da Svitto e dalla Heimat. Poco dopo, gli verrà diagnosticata la malattia che lo porterà alla morte il 4 dicembre 1971.
Merita inoltre una particolare menzione il romanzo “Urwang”, pubblicato nel 1954, sulla scia delle polemiche suscitate dalla costruzione di una grande centrale idroelettrica in una valle del Cantone di Svitto. Le sue splendide pagine, amare e civilmente sconsolate, invitano a riflettere oggi più che mai sulla vacuità e inconsistenza di molti miti degli ultimi decenni, in particolare sull’idea del progresso ad ogni costo e su quella che lo stesso Inglin aveva definito la “mania dell’utile”.
Meinrad Inglin: da una vicina lontananza

Contenuto audio
Vita di poeta
Blu come un'arancia 18.06.2018, 10:35
Ricordi di un cacciatore
Blu come un'arancia 19.06.2018, 10:35
Elogio della patria
Blu come un'arancia 20.06.2018, 10:35
"La biforcazione": Svitto e il mondo
Blu come un'arancia 21.06.2018, 10:35
Il viandante sulla strada di casa
Blu come un'arancia 22.06.2018, 10:35
Ma il grande scrittore della “piccola Svitto” parla alla nostra sensibilità per motivi, se mai possibile, ancora più sostanziali e dirimenti. Inglin può infatti essere inserito tra gli esponenti di una cultura alternativa rispetto a quella che si è imposta nel mondo occidentale. Si potrebbe banalmente definirla cultura del sentimento opposta alla cultura della razionalità, ma la questione è più ampia e complessa, perché Inglin arriva addirittura a sostenere che l’unica possibile forma di conoscenza è quella rappresentata dalla fantasia e dalle proiezioni immaginative. Il tanto decantato io umanistico, fondato sull’intelletto e sulla ragione, per Inglin è soltanto lo strato superficiale, fittizio e cedevole di qualcosa di molto più ampio, quasi indefinibile, che affonda le proprie radici nella dimensione del mito: il cosiddetto “vissuto” è un miscuglio di realtà e immaginazione, cose realmente vissute e cose create, modellate e rimodellate dalla fantasia, e il tutto non corrisponde mai alla mera somma delle parti (il racconto “Il Signore di Birkenau”, ad esempio, è un’unica variazione su questo tema). Ecco il motivo per cui, in un memorabile passo di “Urwang”, Inglin fa dire a uno dei suoi personaggi: «Dove ci stanno portando il progresso e la fredda ragione? Non lo sappiamo. Una maggioranza al servizio di una potenza economica sta violentando un’indifesa minoranza. E questo non ha più nulla ha che vedere con la democrazia». In fondo, non è altro che la versione aggiornata del vecchio dubbio dei romantici. Un dubbio che oggi, in un mondo asettico e plastificato, che ha colpevolmente rimosso i dati primari dell’esistenza e il suo irredimibile cuore di tenebra, sarebbe il caso di rispolverare.
Tutta l’opera del “provinciale” Inglin, che si estende per quasi mezzo secolo, è in definitiva la dimostrazione che il provincialismo -come ha ricordato in tempi più recenti il compianto Hugo Loetscher- è sempre una scelta, non una condizione data una volte per tutte. E che Svitto può essere e anzi è il centro del mondo, come ogni luogo reinventato nella grande arte e trasferito in una “realtà” -più reale della cosiddetta e non meglio definibile realtà “reale”- che contiene immaginazione, fantasticazione e mito. E’ la vecchia ma sempre nuova verità di Dante: soltanto se si ama e reinventa Firenze, la “piccola patria”, ci si può sentire di casa nel vasto mondo come i pesci nel mare e si può pensare ai luoghi come dimore, come un orizzonte all’interno del quale abbia almeno una parvenza di senso la fatalità biologica del vivere e dover morire. La “piccola” Svitto di Meinrad Inglin -miracolo della grande letteratura- è uno di questi luoghi.