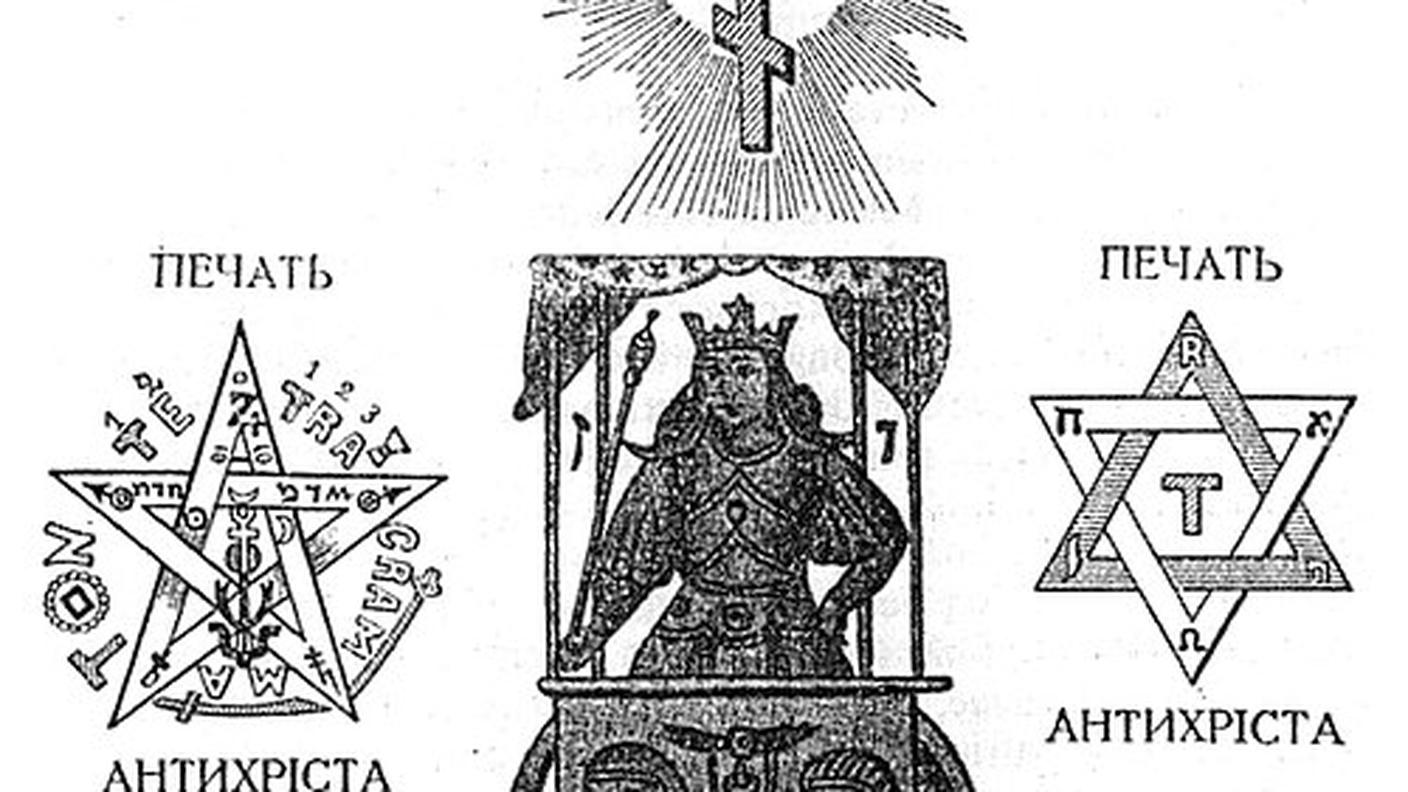Era il 1966 quando Primo Levi, nelle sue Storie naturali, aveva parlato di una «smagliatura del mondo in cui viviamo, una falla piccola o grossa», interpretabile alla stregua di «un vizio di forma che vanifica l’uno o l’altro aspetto della nostra civiltà e del nostro universo morale». Alla presente altezza cronologica ci sembrano previsioni piuttosto facili, ma all’epoca lo erano molto meno. Bisognava insomma essere piuttosto perspicaci per intuire la piega che avrebbe preso l’intera faccenda. Esattamente un secolo prima, negli anni del positivismo e delle sue presunte glorie anche in ambito politico e sociale, bisognava invece essere degli autentici visionari per capire che le “magnifiche sorti” e il progresso scientifico-tecnologico si sarebbero rivelati in ultima analisi una delle tante illusioni che hanno segnato il tormentato e tormentoso cammino dell’umanità.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Nel-sottosuolo-dellumano--1781444.html
Fëdor Michajlovič Dostoevskij era precisamente un genio visionario, forse il più grande di tutti anche in termini narrativi e di qualità di scrittura, malgrado il giudizio del suo conterraneo Vladimir Nabokov, che considerava la sua opera «mediocre e priva di gusto» (ma con Nabokov, sia narratore che critico, bisogna sempre stare molto all’erta, perché tutto si svolge sul filo del paradosso e della voluta provocazione). Si tratta ovviamente di una mera coincidenza, ma c’è qualcosa di simbolico nel fatto che esattamente un secolo prima di Levi, tra il 1864 e il 1865, Dostoevskij abbia dato alle stampe due testi che in diversa maniera, ma con gli stesi esiti, hanno investigato con impietosa lucidità gli inganni del progresso e gli abissi dell’animo umano.
Poi verranno i grandi romanzi, che svolgeranno il tema in infinite variazioni, ma è in quei due testi che si profilano per la prima volta non solo l’immagine dell’animale-uomo quale creatura ridicola, che sogna impossibili salvezze per la propria misera persona e l’umanità intera, ma anche il preciso tipo socio-antropologico del “meschino” e del “perdente”, pronto a mercificare la propria vita nonché a svendere la propria dignità e libertà in cambio di qualche ignobile vantaggio, abitante di un immenso sottosuolo che a uno sguardo più attento si rivela una superficie che è l’unica pensabile e immaginabile: la vita, sulla quale incombe la figura di quel “Megadirettore” fantozziano che in un celeberrimo segmento narrativo de I fratelli Karamazov viene definito “Il Grande Inquisitore”, ma che può essere denominato in un’infinità di modi e può assumere tutte le possibili sembianze.
Il primo testo, pubblicato originariamente sulla rivista Epocha, si intitola Memorie del sottosuolo ed è una delle pietre miliari della coscienza moderna quale espressione di una “malattia” che è la malattia stessa del vivere in un mondo dominato da quello che Dostoevskij, con straordinaria lungimiranza, definisce il “Principio Economico” (alcuni decenni dopo, Italo Svevo arriverà a parlare della vita come “malattia della materia”). Si tratta di un testo principalmente teorico, che tuttavia nella seconda parte svolge l’assunto di fondo in chiave narrativa e mostra l’io-narrante alle prese con le prime manifestazioni del nuovo mondo borghese e il miraggio di una futura società del benessere fondata su scienza e ragione, nella quale «due volte due darà sempre quattro», senza alcuna eccezione, in una realtà addomesticata dove forse si saprà tutto, ma vivere sarà terribilmente prevedibile e quindi noioso.
L’anno dopo, sempre sulla rivista Epocha, Dostoevskij pubblica un racconto dal titolo Il coccodrillo, che porta a compimento lo sviluppo narrativo delle Memorie del sottosuolo ma lo declina in chiave apertamente umoristica e grottesca, nel solco dei Racconti di Pietroburgo di Gogol’, in particolare Il naso, tanto che perfino un gogoliano “doc” come il già ricordato Nabokov fu costretto a riconoscervi «lampi di insuperabile umorismo». Ne Il coccodrillo Dostoevskij adotta un procedimento che nel decennio successivo riprenderà ampiamente nel Diario di uno scrittore, elevandolo a principio poetico: trarre spunto dai faits divers, offerti dalla tragicommedia quotidiana, per trasformarli in apologhi e vicende esemplari. Nel caso de Il coccodrillo, a dire il vero, la vicenda in questione non si è mai verificata, ma nell’invenzione/reinvenzione di Dostoevskij -e agli occhi di noi “venuti dopo”- si trasforma in una vicenda assolutamente plausibile.
Il décor è costituito come sempre da Pietroburgo, più precisamente da un negozio del Passage, l’elegante galleria commerciale inaugurata non molti anni prima sulla Prospettiva Nevskij, dove un commerciante tedesco espone a pagamento nientemeno che un coccodrillo (la scelta non è casuale: per Dostoevskij, il popolo tedesco era un “popolo di bottegai”). Il funzionario ministeriale Ivan Matveič, tipico esempio dostoevskiano e gogoliano non soltanto del sordido e losco burocrate, ma anche (e conseguentemente) dell’uomo supponente, ignorante e quindi ridicolo, si reca in visita alla strana ed esotica attrazione insieme alla bella moglie Elena Ivanovna, una sorta di influencer e content creator ante-litteram -svampitella, sguaiata, superficiale, con pose da sciantosa, non meno supponente e ignorante del marito-, e un amico di famiglia che svolge la semplice funzione di io narrante.
Quando lo sciagurato e improvvido Ivan Matveič, con un gesto di modernissima e plebea volgarità, davvero degno della bêtise di Flaubert, cerca di solleticargli le nari con un guanto, il sonnacchioso coccodrillo reagisce e lo inghiotte in un solo boccone. In una realtà senza scollamenti e vizi di forma sarebbe una tragedia, ma in una realtà infetta, dove la coscienza in quanto tale è già malattia, la vicenda vira fin dall’inizio in commedia e in farsa: l’ineffabile Ivan Matveič non solo è vivo e vegeto, ma dall’interno del coccodrillo pensa perfino di dedicarsi «come un novello Fourier» al miglioramento delle sorti umane, di modo che «dal coccodrillo verranno la verità e la luce». La metafora biblico-evangelica, ma declinata in chiave grottesca e nel segno di una totale quanto irreversibile secolarizzazione, è evidente.
E’ quasi inutile aggiungere che in seguito, nel mai concluso “secolo breve”, saranno in molti (troppi) a fare compagnia a Ivan Matveič nel ventre cavo e gommoso del coccodrillo, metafora e profezia di una società talmente involgarita da non essere nemmeno consapevole della propria volgarità. Una società dei simulacri, come sottolineava velenosamente Ennio Flaiano in una meravigliosa storiella desunta non a caso da un fait divers, dove può tranquillamente accadere che una gran dama con pretese culturali vada a teatro ad assistere a una pochade e alla fine dello spettacolo esclami con tono da pitonessa: «Che spettacolo meraviglioso! Mi sono fatta la pipì addosso dal ridere!». Al che il suo accompagnatore, poetastro da strapazzo e tipico esempio dell’intellettualoide da salotto o terrazza, le dice: «Ma signora, allora si faccia fare la psicanalisi delle urine!». Tutto vero, tutto drammaticamente (o farsescamente) realistico.
Si pongono tuttavia alcune questioni. Dove finisce la tragedia, dove cominciano la commedia e la farsa? E ancora: quale connotazione ontologica, prima ancora che sociologica e antropologica, si può attribuire al “tipo” Ivan Matveič? La risposta è contenuta in un’invenzione linguistica di Paolo Villaggio, che è stato giustamente definito il Gogol’ italiano del Novecento e deve molto, in termini di poetica, anche a Dostoevskij. L’invenzione non sarà forse elegantissima sul piano lessicale (ad ogni modo, parecchie parole della neolingua tecnologica sono involontariamente molto più volgari), ma rende benissimo l’idea: “merdaccia”. La produzione narrativa di Dostoevskij, infatti, pullula letteralmente di merdacce che sono tali per il semplice motivo che esistono e sono gettate in una realtà (“la” realtà) infida e ostile: nient’altro che umanoidi sordidi e servili, infimi gaglioffi per i quali non corre alcuna differenza tra il calpestare e l’essere calpestati.
«Ci dovrebbe essere maggiore solidarietà fra gli stronzetti. Se tutte le merde si aiutassero, ad ogni merdaccia la vita andrebbe meglio». La frase è dello scrittore e drammaturgo austriaco Ödön von Horváth, è contenuta nel romanzo Trentasei ore e risale al 1929, ma starebbe bene da qualche parte in uno dei tre libri, usciti tra il 1971 e il 1979, coi quali Paolo Villaggio ha consegnato a futura memoria il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi. Il paragone con Dostoevskij tramite Horváth non è affatto spericolato, perché il Fantozzi di Villaggio non è soltanto un personaggio prima letterario e poi cinematografico elevato a maschera immortale (i film ne hanno fornito per così dire la semplice “vulgata”), ma è anche e soprattutto una condizione dell’anima, un modello antropologico che esprime, declinandole a partire da un altro contesto storico e sociale -tipicamente italiano/italiota- le stesse eterne miserie che si trovano descritte nei romanzi e racconti del grandissimo scrittore russo.

Carta bianca - Paolo Villaggio
RSI Carta bianca 08.12.1988, 16:44
«Io non ho creato il fascismo, l’ho tratto dall’inconscio degli italiani», ha detto Benito Mussolini. Paolo Villaggio, da parte sua, avrebbe potuto affermare con tutti i diritti: «Io non ho creato il ragionier Ugo Fantozzi, l’ho tratto dall’inconscio degli italiani». E’ lecito dire, sotto questo aspetto, che il valore squisitamente letterario e socio-antropologico della trilogia narrativa di Villaggio non è stato ancora preso seriamente in considerazione dalla cosiddetta cultura “alta”. Forse lo si scoprirà in un futuro più o meno prossimo, con inspiegabile quanto colpevole ritardo.
Anche Ugo Fantozzi, come i personaggi di Dostoevskij, non è una “merdaccia” per colpa di chissà quale destino avverso, oppure perché così lo etichettano i vari Megadirettori (che forse -nella struttura piramidale, astratta e disumana del “burosauro”- nemmeno esistono, come dice uno dei tanti leitmotiv della trilogia narrativa e dei film). E’ una “merdaccia” perché esiste, perché è al mondo, dove tutto è tragico in quanto ridicolo, e viceversa. Come nella memorabile quanto devastante scena dei “servili auguri di Natale” e di uno “spettabile anno nuovo” nel primo film della serie.
Paolo Villaggio ha chiuso quello che forse, insieme alla trilogia di Fantozzi, rimane il suo libro più bello, il velenoso e dissacrante Storia della libertà di pensiero, uscito nel 2008, con alcune considerazioni tutte giocate (ma nemmeno troppo, se considerate alla presente altezza cronologica) sul filo del paradosso: «Che fine faremo tutti? Purtroppo, è facile prevedere che una nuova terribile, invisibile e subdola forma di dittatura ci riporterà in pochi anni a quella comoda condizione dell’assoluta mancanza di libertà di pensiero. Forse saremo più felici, ma vivremo incatenati in lunghe file a costruire le nuove piramidi».
Ci avevano promesso il paradiso del tenore di vita e la felicità per mille anni, e il paradiso è arrivato. Però quel paradiso tanto agognato assomiglia maledettamente a un inferno, ha osservato lo stesso Villaggio in un’intervista del tutt’altro che archeologico 1975. Da questo punto di vista, il suo genio visionario è davvero accostabile a Gogol’, Dostoevskij e Kafka, oppure a certe suggestioni surreali, crudeli e tragicomiche di Thomas Bernhard: il paesaggio circostante non è avvolto nel gelo e nemmeno perturbato da una conclamata follia, non è necessario svegliarsi un mattino e scoprirsi scarafaggi, non ci sono strani e inspiegabili processi in corso né condanne pendenti per chissà quali motivi, non ci sono sogni di salvazione per uomini ridicoli.
C’è soltanto «la nostalgia per una vita inutile», la scialba eternità dei suoi momenti vuoti, le sue innumerevoli nevrosi: a dirlo è il personaggio di Fantozzi, che in un ribaltamento dei ruoli molto dostoevskiano si rivolge in questo modo al suo autore Paolo Villaggio nel breve racconto L’ultima volta, pubblicato nel 2012 nel volume Tragica vita del ragionier Fantozzi. Ma anche quella nostalgia è tragica e insieme ridicola, persa com’è nel nulla comune, nel tempo che passa, in tutte le morti -nostre e altrui- che ci portiamo appresso. Un grande funambolo della lingua tedesca come Gregor von Rezzori ha inventato il termine giusto per designare e circoscrivere l’intera faccenda: Epochenverschleppung, “trascinamento di epoche”.
https://rsi.cue.rsi.ch/cultura/letteratura/Etica-dell%E2%80%99obbedienza--1815133.html
Distanti quasi due secoli l’uno dall’altro, eppure vicini, vicinissimi, Dostoevskij e Villaggio hanno dragato il fondo melmoso e fanghiglioso della coscienza infelice e ci hanno detto cosa siamo stati, cosa siamo e cosa siamo destinati ad essere fino a quando libereremo questo sciagurato pianeta dalla nostra ingombrante presenza. La loro sentenza, se così la si può definire, riguarda tutti, dai tirannosauri dei profitti e fatturati all’ultimo dei derelitti, dai presunti “vincenti” ai presunti “perdenti”, dai primi agli ultimi arrivati in quella strana e patetica competizione che Dino Buzzati, in un suo racconto, ha sintetizzato nell’espressione “corsa dietro il vento”. Lo aveva capito in maniera definitiva un illustre (presunto) “perdente” come Robert Walser, quando aveva affermato che i suoi libri non erano destinati alle «molto rispettabili persone che vogliono dei punti fermi per la vita», aggiungendo che non augurava a nessuno di essere come lui: «Di sapere tante cose, di avere visto tante cose e di non avere nulla, così nulla da dire». Poi si è sottratto al mondo, si è celato entro le mura di una clinica psichiatrica e si è felicemente votato e consacrato al silenzio: estrema sconfitta, forse, ma anche estrema salvezza dalla «nostalgia per una vita inutile».